Stefano Rota - Transglobal
Ma come io possiedo la Storia,
essa mi possiede,
ne sono illuminato.
Ma a che serve la luce?
P.P. Pasolini
Progetto ricco e ambizioso quello cui ha dato vita Fabrice Olivier Dubosc, che si è tradotto nella pubblicazione del volume Lessico della Crisi e del Possibile, di recente pubblicazione per i tipi di Seb27, e che potrebbe avere come sottotitolo aggiuntivo quanto Deleuze scrisse in un commento all’opera di Gabriel Tarde: “Non tutto ciò che è morto deve continuare a morire”.
Cosa significa, dal punto di vista del rapporto tra pratica discorsiva e pratica politica, passare dalla critica alla clinica? Leggendo l’elenco dei lemmi che compongono il libro, l’introduzione di Dubosc e la postfazione di Gianluca Solla, appare evidente come non vi sia necessità di inventare altri termini, ma, piuttosto, di dare nuova vita a quelli già esistenti, “deterritorializzarli”, sostanziarli con “nuovi nomi” in un “corpo senza organi”, ripensarne la logica produttiva ed enunciativa. Questa esigenza nasce da un dato evidente: è cambiato il contesto a cui siamo soliti riferirci quando utilizziamo molti di questi lemmi; le trasformazioni profonde dell’ultimo ventennio in ogni ambito - geopolitico, ecologico, sociologico, economico, emotivo, relazionale, solo per citare quelli di più largo uso – sono tali da rendere necessaria una rivisitazione dell’”essere linguaggio” da cui quei lemmi emergono, del mormorio che vi fa da sottofondo. Il cambiamento è lì ed è di dimensioni epocali: ognuno potrebbe pensare decine di parole a cui si è soliti rimandare a significati “storici”, ma sapendo allo stesso tempo che tali significanti necessitano di una rilettura, anche e soprattutto nelle concatenazioni a cui danno luogo.
Se la critica svolge da sempre una funzione fondamentale per immaginare il futuro oltre e contro le miserie del presente, capita troppo spesso, ormai da circa un ventennio, che l’ambito vitale di tale critica non riesca a espandersi in spazi che travalichino i ristretti circuiti in cui sorge, a tradursi in strumenti adatti a far sì che le parole usate possano essere riconosciute immediatamente utili per la propria vita, o la vita a cui apparteniamo, in una prospettiva di ripensamento generale del discorso di cui abbiamo bisogno per interrogare il nostro tempo, oltre le interpetazioni dogmatiche e consolidate a cui siamo soliti riferirci.

Tra i lemmi che necessitano di questa rivisitazione – anche distanziandosi almeno parzialmente da quelli proposti nel volume - c’è certamente popolo e popolare (ma anche populismo), così come cultura, soprattutto nella sua accezione di “cultura popolare”, o “classe” che, coniugato dentro la stessa striscia sostantivo/aggettivo, diviene “classe popolare”. Si tratta di termini con una lunga tradizione di uso dentro le pratiche discorsive della sinistra, “piegandosi” o venendo piegati nelle varie epoche storiche, a una determinata concatenazione di significati che hanno prodotto forme di soggettivazione e il sorgere di soggettività differenti. A questi se ne possono affiancare subito molti altri: benessere, desiderio, lotta, vita, ecologia, relazione, sinistra, cura, macchine, fuga, piacere, tempo, libertà, migrante.
Dove arriva (e si ferma) la critica? Dove questi termini producono un significato assoluto, tendente all’“infinito”, dove la condizione che si intende interpretare viene piegata a tali rassicuranti significati e non il contrario. Così come Deleuze e Guattari hanno avvertito il bisogno di sottrarsi, il primo, alla repressione della Storia della filosofia, giudicata una sodomizzazione (enculage, “inculata”) o “l’immacolata concezione, che è poi la stessa cosa”, e, il secondo, alla purezza e integrità del pensiero che non ammette nessun rinnovamento, attraverso la rivendicazione di un atto di falsificazione, corruzione (etimologicamente una rottura, complementare alla generazione), bisogno che li conduce a quella deterritorializzazione dei segni e dei significati di cui si è detto sopra, la proposta di Dubosc con questo testo sui lemmi deve seguire un percorso analogo. Se il concetto non può più tendere a un “infinito” trascendentale, a una forma che non ammette interrogazioni e relativizzazioni, non può neanche limitarsi a vivere in una forma di finitudine tout court, di un empirismo tecnico e comparato. Ecco che si fa spazio una nuova forma, di cui non a caso la letteratura che tende al suo limite (le forme agrammaticali) è assunta da Foucault come paradigmatica di questa terza fase: quella che, secondo Deleuze, è connotata dal “finito illimitato”. A questo piano deve tendere un lavoro sui lemmi: una molteplicità illimitata di sensi “finiti”.

I lemmi, fuori dalla grammatica e dalla morsa significante/significato, possono trovare vita in espressioni che li trasformano in linguaggi multipli, corporei, vocali, visuali, producendo nuove connessioni tra di loro e con il reale con cui interagiscono. La sottrazione della capacità enunciativa all’egemonia del linguaggio per riconsegnarla alla presenza interattiva dei corpi in situazione, a quello che fanno vedere stando fermi o muovendosi, silenti o accompagnati da voci, è il modo migliore per ridare vita agli “organi del corpo”. Con queste premesse si possono sperimentare azioni che coinvolgano i ragazzi, le signore e gli anziani delle periferie della città o del centro minore qualunque in cui viviamo, non ponendo alcun limite alle possibilità interpretative dei lemmi, registrando e accarezzando ogni significato proposto, come base per successive elaborazioni di quegli stessi lemmi o di altri.
Perché questo diventi clinica, dobbiamo riscoprire il piacere dell’inchiesta, del “go on theorizing”, la ridefinizione costante dei concetti che usiamo. Le aule, i luoghi di lavoro, di assemblamento, i luoghi per la “ricerca del rispetto” devono diventare il terreno in cui si misura la capacità di fare di ogni concetto, enunciato, atto un momento esperienziale “clinico”.
La clinica mantiene salda la relazione tra potenza del concetto ed essere, diviene un tratto distintivo del processo di soggettivazione dell’individuo. Consente, da un lato, il dispiegamento del concetto nell’illimitatezza, ne favorisce, dall’altro, la piega e la ripiega, dandogli spessore, creando strati, “piani” come suggeriscono Deleuze e Guattari, lasciandolo apero a rappresentazioni performative imprevedibili, secondo l’accezione di J. Butler.
Il concetto ha bisogno di un “non-concetto” che lo includa, che gli faccia continuamente da sfondo, “in ogni istante del suo divenire o del suo sviluppo”. Quindi non come “condizione di partenza”, e neppure come “fine nella quale si troverebbe a scomparire, nel momento della sua realizzazione”. Parimenti, si può dire che, con la stessa accezione, ogni lessico ha bisogno di un non-lessico, che è l’esperienza. Questa forma il soggetto dentro un piano di immanenza dato dalla “formazione storica” del sapere che gli è contemporanea e dominante, sulla base di concetti e lemmi – gli unici di cui può servirsi, perché sotto a questi non vi è nulla, non esiste un’esperienza selvaggia che li anticipa – che propongono all’individuo, interpelandolo in ogni istante della sua esistenza, un costante e mutevole assoggettamento. Ma per fortuna non finisce tutto qui: quei punti di potere che determinano le condizioni dell’assoggettamento sono sempre accompagnati – addirittura preceduti – da altrettanti punti di resistenza. Cosa significa, questo, per noi? Che possiamo usare quei concetti e quei lemmi contro la loro funzione proposta, deterritorializzandoli, rivoltandoli contro quelle stesse istanze di potere. Per questo, il prerequisito è dato dalla disponibilità all’apertura verso nuove esperienze che ci potrebbero condurre a ridefinire concetti cui siamo soliti opporre una strenue resistenza, a interrogarci sul modo più adeguato per capirne la portata al di fuori della nostra interpretazione, senza per questo abbandonarla ma semmai “venendo a patti con i propri itinerari”.
In questo senso, la clinica della crisi può recuperare molto di quanto si è perso nell’utlimo ventennio; può darci la misura esatta di dove siamo, di cosa abbiamo bisogno e del tragitto che dobbiamo seguire. I piani vanno tutti presi in considerazione, non ve ne sono di più o meno importanti, la posta in gioco è troppo alta per permetterci distrazioni.
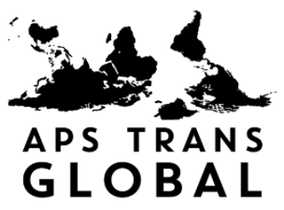
Scrivi commento