Francesco Spagna*
“Estremamente difficile all’etnologo formulare una giusta valutazione di un fenomeno come l’universalizzarsi della civiltà occidentale”[1].
Lévi-Strauss scriveva Razza e storia all’inizio degli anni ’50 in un periodo, per la cultura occidentale, di forte crisi dei valori, dopo i terribili eventi della seconda guerra mondiale, in un decennio che si rivelerà cruciale per la fine del colonialismo storicamente inteso.
La difficoltà alla quale si riferiva Lévi-Strauss dipendeva sicuramente dalla forte ambivalenza che aveva caratterizzato la relazione tra la civiltà occidentale e gli altri popoli del pianeta. La consapevolezza, espressa con forza e chiarezza in Tristi Tropici, che l’ordine e l’armonia dell’Occidente avevano comportato “l’eliminazione di una massa enorme di sottoprodotti malefici”[2]. Sottoprodotti che sono stati gettati addosso agli altri e che hanno caratterizzato la pesante eredità del colonialismo. Dalla prospettiva degli altri, la modernizzazione dell’Occidente, nei suoi aspetti scientifico-tecnologici, morali o politici, è arrivata insieme alle più gravi efferatezze e crimini contro l’umanità compiuti durante il dominio coloniale. I “diritti umani” sono arrivati insieme al genocidio su larga scala, e questo paradossale blend ha segnato in modo indelebile l’immagine dell’Occidente.
A mezzo secolo di distanza, la cosiddetta “civiltà occidentale” nell’era della globalizzazione cerca ancora di orientare i destini del pianeta, riproponendo i valori della modernità e una ormai traballante supremazia scientifica e tecnologica.
L’universalismo e i suoi benefici continuano a rappresentare il nostro “invito” all’Altro – anche se la fatale ambivalenza permane e l’Altro (che sia musulmano, immigrato clandestino o Indiano d’America) continua a essere rappresentato in termini di minaccia o di resistenza, o a persistere come elemento di difficile tematizzazione.
Anche laddove la modernità tenta di resistere alla corrosione del postmodernismo, essa subisce comunque quella azione termodinamica di accelerazione e “surriscaldamento” dei suoi processi che ha portato l’antropologo Marc Augé a parlare di “surmodernità”[3].
I “valori professati” sono sempre quelli che Lévi-Strauss aveva individuato in Razza e storia: la quantità di energia disponibile pro-capite e l’allungamento della vita umana[4]. I recenti progressi nel campo delle biotecnologie della medicina e della farmacologia continuano a propagare su scala planetaria questi valori e la necessità della loro universale accettazione.
Tuttavia, sono ormai diversi decenni che l’antropologia medica[5] mostra un quadro piuttosto contrastante rispetto all’immagine della presunta diffusione dei saperi e delle pratiche della cosiddetta “medicina occidentale” sul pianeta. Nessuno mi auguro voglia negare i suoi meriti e i risultati da essa raggiunti: la consapevolezza, ad esempio, dei milioni di vite umane salvate dall’invenzione della penicillina e dall’uso degli antibiotici. Va considerato però che se è vero che in alcune regioni del mondo, specialmente Africa e Sud America, la medicina occidentale non arriva anche se sarebbe richiesta – per carenza di strutture e di personale – è altresì vero che in altre vaste e densamente popolate aree del pianeta, come India e Cina, la “nostra” medicina non arriva perché non richiesta: laddove sono attivi (ed evidentemente efficaci) sistemi di cura autoctoni. A questo quadro va aggiunto il fatto che un numero sempre più alto di persone, nel nostro mondo, decidono di orientarsi verso le cosiddette medicine “alternative”. Dall’altra parte, in Africa come in Siberia, in Nord e Sud America, i guaritori tradizionali[6] si sono adoperati, negli ultimi decenni, per organizzare e legittimare le loro pratiche e i loro saperi, aumentando la loro visibilità.
I processi di globalizzazione e i nuovi consistenti flussi di immigrazione in Europa hanno portato le strutture socio-sanitarie a confrontarsi sempre maggiormente con pazienti di origine straniera e a dover valutare quella che in antropologia medica ed etnopsichiatria viene definita come “dimensione culturale del disturbo”, oltre alla necessità di porre i percorsi di ospedalizzazione e di cura su un terreno di mediazione culturale[7].
Tutto questo delinea uno scenario che mette in seria difficoltà le retoriche sull’egemonia della bio-medicina occidentale e sulla sua effettiva diffusione e applicazione su scala planetaria.
Le infuocate critiche lanciate da Ivan Illich negli anni settanta sono quanto mai attuali[8]. Le strutture sanitarie intese come “aziende” nel sistema di mercato neo-liberista, la corsa sempre più spregiudicata al profitto, la pressione delle multinazionali farmaceutiche a confezionare sempre nuove “sindromi” da inserire nel Manuale Diagnostico e Statistico (DSM), stanno ingenerando una crisi della fiducia che rischia di farsi sempre più profonda.
La vita, nel mondo occidentale industrializzato e super-tecnologico, appare sempre più “bilanciata” nel rapporto stress / consumismo. Laddove lo stress accorcia la vita, favorendo lo sviluppo di patologie difficilmente curabili - con il consumismo, come ha scritto il filosofo Aldo Giorgio Gargani, “si consuma e dissipa la stessa vita umana”[9].
La “medicina occidentale” – ovvero il lato forte dell’universalismo e della propagazione dei suoi valori – procede con due ancelle, la genetica e la statistica.
Si potrebbe dire, parafrasando Nietzsche, che il modello biomedico tende ad appoggiarsi da un lato alla dis-umanità della statistica e dall’altro alla troppo-umanità della genetica. Tanto quanto la statistica è “fredda” e disincarnata, la genetica scende nel profondo dei corpi a cercare i suoi codici. Ambedue sviluppano una retorica della prevedibilità e del controllo. Da due direzioni diverse, ambedue trascendono i destini e i vissuti concreti delle persone. Da un lato i diagrammi, le tavole e i modelli, dall’altro il genotipo concepito come “disegno formale” dell’organismo. Riprendendo la metafora di Lévi-Strauss, la purezza architettonica di questi sistemi modellizzanti esige l’espulsione di un sottoprodotto. Sottoprodotto che si manifesta come frattura, o slittamento, tra la concezione di “organismo” e quella di “persona”; o tra quella di “persona” e quella di “caso statistico”.
Questa frattura urta sia qualsiasi concezione metafisica tradizionale dell’Uomo e sia alcune delle più avanzate riflessioni dell’antropologia e dell’epistemologia. Le nozioni di “mero” organismo e di “mero” fatto statistico appaiono frutto di una duplice costruzione culturale. Come ha sostenuto Tim Ingold, ognuno di noi è sempre, indissolubilmente organismo e persona e non c’è nulla di “mero” (parziale o residuale) nell’essere un organismo[10].
L’essere “puro e semplice” – e anche “chiaro” – del significato del termine “mero” rende ragione del suo uso epistemologico: “la nozione di mero fatto” scriveva A. N. Whitehead, “è il trionfo dell’intelletto astrattivo”[11].
“Con le pietre dei fatti” fa dire Agatha Christie al suo personaggio, l’investigatore Poirot, “si costruiscono le strade delle nostre ipotesi”. Ma sono strade occidentali: possiamo invitare gli altri a percorrerle con noi, ma non necessariamente pensare che esse siano universalizzabili, così come non lo sono i baffi impomatati di Poirot.
Non sono universali e neppure facilmente “negoziabili” in una prospettiva interculturale, e lo scopo di questo mio contributo è di mostrare che la difficoltà di cui parlava Lévi-Strauss permane, nell’ambito delle relazioni tra la cultura occidentale e le altre culture, e che sarebbe ipocrita pensare di risolverla nel nostro universalismo.
Il razionalismo, il calcolo costi/benefici, il concetto di “utile” e il rapporto tra “sapere” e “potere” sono tratti culturali, che nel particolare percorso di secolarizzazione del mondo occidentale[12] hanno acquisito un carattere al tempo stesso implicito e preponderante. La verità è che essi rivestono un ruolo parziale anche in seno stesso a quella cultura che li vorrebbe totalizzanti. L’uomo occidentale è razionale “a fasce orarie” e il dosaggio quotidiano tra razionalità e irrazionalità è un problema analogo nell’isola di Manhattan come nel fitto delle foreste del Congo.
Tuttavia, l’attribuzione di valore che può essere data al calcolo sui costi/benefici dipende essenzialmente dalla visione del mondo che ne è sottesa. Nello scenario desertificato del mondo materialista, il calcolo costi/benefici è la risorsa finale, e chi la possiede risulta vincente. L’utile è un concetto estremo, che galleggia sopra tutte le varie e possibili forme di dissipazione. Restringe le relazioni sociali e tende a sviluppare differenziali di potere. L’utile per l’umanità si rovescia spesso nell’utile per pochi e dunque nell’utile per me, qui ed ora. Tra “umanità” e “individuo” si determina una sorta di oscillazione polare e un vuoto. Il vuoto è la comunità: “l’utile per la comunità” si rivela come una variabile culturale molto significativa, che può cambiare radicalmente la visione del mondo. L’utile per la comunità passa attraverso il dono, le feste, la solidarietà, la famiglia, le relazioni… in tutta la loro essenza dissipativa e – razionalmente parlando – “inutile”[13]. La visione comunitaria allude però a un mondo ad ampio respiro, per il quale gli interessi individuali possono anche venire sacrificati.
Nel mondo “occidentale” – che oltre il suo tramonto si pensa ancora come unico mondo e, come la strega cattiva di Biancaneve, lo chiede al suo specchio – il senso comune pensa alla vita umana come un segmento. Nascita e morte sono concepiti come due estremi alla soglia di un nulla che da secoli tormenta la nostra filosofia. Possiamo pensare che questa concezione sia l’inevitabile punto di arrivo di un pensiero laico, moderno e disincantato, ma sarebbe ingiusto generalizzare la nostra inquietudine. Sarebbe ingiusto riversare il nostro “nulla” nei territori delle ex colonie e seppellirlo nelle loro discariche.
La concezione della vita umana come un segmento appeso nel nulla – indipendentemente dal margine di dubbio o di consolazione lasciato alla sfera religiosa, o al grado di compensazione ed esaltazione esercitato dalla tecnologia – rischia di apparire agli altri semplicemente come un pensiero mutilato.
Il distacco dalla tradizione metafisica compiuto dal pensiero occidentale all’alba dell’età moderna, rischia di essere percepito, agli occhi degli altri, come una perdita. “Qualcosa di meno”, che nello scambio interculturale diventa poco negoziabile. Un materialismo che suscita diffidenza.
La concezione della vita come un segmento (o una parabola) appesa nel nulla implica che tutti i valori siano concentrati, ritirati, nell’intervallo significativo (o nell’apice della parabola). La ricerca sul genoma umano, vista da quest’ottica, fa pensare a una sorta di spedizione nello spazio (nel nulla), all’esterno della vita fenotipica, per carpire elementi, codici, segreti e stratagemmi per migliorare o allungare la vita nella sua parabola esistenziale. La genetica non si incarica di portare particolari elementi e valori a sostegno della discendenza e della continuità delle generazioni. Il suo compito è, ovviamente, puramente scientifico. Tuttavia, fa riflettere il fatto che essa viene alla ribalta in un clima culturale suicidarlo e catastrofista, dove è costantemente rappresentata nell’immaginario la fine del genere umano o del mondo, e dove qualcuno predica la necessità di smettere di fare figli.
La mappatura genetica si inscrive in una retorica del controllo in un mondo fuori controllo.
In questa nuova versione dell’universalismo, il genoma umano arriva “a pacchetto” con il sentimento incombente della fine delle generazioni: l’ultimo paradosso colonialista?
Non ci deve sorprendere – ma neppure deve essere sottovalutato – come questo pensiero possa apparire, agli occhi degli altri, come un pensiero mutilato, che ha perso la connessione con una visione d’insieme e che non ha direzione.
Il punto di vista degli altri è una generalizzazione antropologica da comprendere e valutare nel suo intento retorico. Prendiamo l’esempio dei popoli amerindiani, che molte volte nella nostra storia – da Montaigne e Rousseau a Lévi-Strauss – hanno fornito un pretesto antropologico per la nostra retorica.
Parlare di visione del mondo o di cosmologia degli Indiani del Nord America è possibile, a un certo livello di discorso, senza però dimenticare o mistificare le molteplici differenze interne a queste visioni e cosmologie; senza pretendere di ridurre l’incredibile caleidoscopio di queste culture, in tutte le loro diverse espressioni.
Come hanno sostenuto Bonnie ed Eduardo Duran, psicoterapeuti Apache/Tewa, “Nella visione del mondo dei Nativi Americani, un’ideologia compartimentalizzante viene vissuta come imposizione, come tentativo di soffocare forme di esperienza più interconnesse. La maggior parte dei Nativi Americani fa esperienza del proprio essere al mondo con la propria intera personalità e non attraverso sistemi separati all’interno della persona (…). La visione del mondo nativa americana è quella in cui l’individuo è parte di tutta la creazione, vivendo la vita come un insieme integrato e non attraverso unità separate, obiettivamente in relazione le une con le altre”.[14]
Nella concezione olistica degli Indiani d’America, in particolare negli insegnamenti tradizionali della Ruota di Medicina, o in cerimonie sciamaniche comunitarie quali la Midewiwin, che ho potuto conoscere da vicino[15], la nascita e la morte sono rappresentati come due passaggi significativi, che aprono a due dimensioni, quella degli “antenati” e quella di “coloro che devono ancora nascere”. L’essere umano è collocato e orientato in quest’orizzonte: i morti e gli spiriti dei nascituri sono una realtà spirituale con la quale i viventi intrattengono un costante scambio, regolato dalle offerte simboliche o dalle preghiere. Il posto dell’uomo nel mondo è centrato in un eterno presente, in una dimensione ciclica e autoriproducente. Le preghiere, le offerte, il cerimoniale sono la rappresentazione simbolica di questa metafisica. Una metafisica tradizionale, derivante da un insegnamento tenuto in vita e gelosamente custodito, che si ritrova un po’ ovunque nelle culture dei popoli nativi americani.
Evidente, in questo come in molti altri esempi nell’universo spirituale dei popoli cosiddetti primitivi, che siamo di fronte all’espressione di un pensiero impegnato a preservare la sua complessità culturale e il suo potere di simbolizzazione di fronte alle sfide del mondo tecnologico e della società dominante. Una metafisica che non può che esercitare una resistenza e manifestarsi come resistenza.
Da questa prospettiva, la storia stessa è percepita come una dimensione inautentica, accidentale e secondaria. La Tradizione va invece intesa come un sistema cognitivo, passato da generazione in generazione da una visione originaria o molteplici visioni incrociate. Una dimensione vivente, metastorica, che non può essere ridotta nelle categorie di “modernità” e tradizione” per come sono state prodotte dal pensiero occidentale[16].
I tentativi di “individuazione” dell’Indiano d’America come cittadino americano, tutelato nei suoi diritti e nella salute “dalla culla alla bara” – ma resecato dal suo orizzonte simbolico, collettivo e archetipico – sono stati percepiti dai diretti interessati come mortiferi e – aspetto non secondario – sono stati spesso di fatto mortiferi. Da una prospettiva tradizionale, è solo la morte che “individua” le persone, separandole dalla collettività. Inoltre, i nuovi cittadini nativi americani erano sì individui tutelati, ma che molto spesso finivano per essere socialmente esclusi, marginalizzati, candidati all’auto-estinzione o direttamente ammazzati. La spirale di deculturazione, marginalizzazione e violenza alla quale sono stati sottoposti, fino oltre la metà del Novecento, i bambini nativi americani nelle famigerate “scuole residenziali” in Canada e Stati Uniti[17] va compresa nella logica più ampia – implicita o esplicita, consapevole o inconsapevole – dell’etno-genocidio. Anche considerando quanto fosse lontana quella realtà scolastica dai modelli pedagogici che proprio in quel periodo venivano elaborati nel mondo occidentale e universalmente propagandati.
I nativi americani hanno dunque già sperimentato il lato oscuro e “biforcuto” del nostro universalismo. Essi stanno cercando, come molti altri popoli indigeni del pianeta, di sollevarsi dalla povertà e disgregazione delle loro comunità, e disegnarsi un proprio spazio nel futuro.
Da parte loro è emersa, negli ultimi decenni, una richiesta chiara, in una direzione completamente opposta rispetto ai valori correnti della società dominante e della secolarizzazione. Il Repatriation Act[18] ha riconosciuto alle comunità native americane il diritto di ottenere la restituzione dei resti dei propri antenati, laddove si trovassero conservati nei musei antropologici. La richiesta, in senso più ampio, di poter ricollocare i propri defunti in un orizzonte simbolico, in un luogo cerimoniale dove sia nuovamente possibile riattualizzare uno scambio.
Questo bisogno di simbolizzazione va visto come espressione vitale di una cultura che resiste e non si sente votata alla scomparsa. Semplicemente un altro “schema di civiltà”, ma profondamente diverso dal nostro e per molti aspetti non negoziabile.
In un mondo universalizzato, a senso unico, le ossa dei loro antenati sarebbero costrette a rimanere in quelle polverose scatole verdi che ho visto all’Anthropological Branch del Museum of Natural History di Washington, in quei tristi corridoi che, oltre alla solerzia scientifica, forse rispecchiano anche la nostra inquietudine…
In conclusione, il progresso e lo sviluppo dell’Occidente, per quello che oggi ancora può significare, continuano a mettersi al servizio del benessere e del prolungamento della vita individuale, ma strettamente rinserrati in una cornice valoriale sempre più asfittica e sempre più segnata da paradossi e controversie.
La partita, tutta da giocare, è da una parte tra una visione del mondo postmoderna, plurale e fuori controllo – dove il negoziato sui valori è difficilmente mediabile e il nostro universalismo tende a naufragare. Dall’altra parte, una visione del mondo nel quale il processo di secolarizzazione avanza graduale ma inesorabile, portando a compimento il nostro progetto universalista.
La seconda ipotesi è sicuramente quella “per noi” più auspicabile: rischia però di essere la più pericolosa in termini di futuro della specie umana su questo pianeta.
* Francesco Spagna, insegna Antropologia Culturale all’Università di Padova. Ha condotto ricerche etnografiche presso comunità native americane in Canada e Stati Uniti. Dal 2011 svolge ricerche presso le comunità immigrate a Padova, sui temi di antropologia Medica e Antropologia Urbana. Ultimi volumi pubblicati: La buona creanza. Antropologia dell’ospitalità (Carocci 2013); L’infinito antropologico (Carocci, 2015 – 2018); Cultura e controcultura (Elèuthera 2016), Il nostro quartiere profuma di spezie. Antropologia urbana all’Arcella (Cleup 2018).
[1] Lévi-Strauss C., Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1967, p. 124 [Race et histoire, Paris, Unesco, 1952].
[2] Lévi-Strauss C., Tristi tropici, Milano Il Saggiatore, 1982, p. 36 [Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955].
[3] Augé Marc, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, elèuthera, 1993 [Non-lieux, Paris, Seuil, 1992]; Lyotard Jean-François, La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1981 [La condition postmoderne, Paris, Les Editions de Minuit, 1979].
[4] Lévi-Strauss C., 1967, p. 125.
[5] Quaranta Ivo (ed.), Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina, 2006.
[6] Riconosciuti formalmente al convegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità tenutosi ad Alma Ata nel 1978.
[7] Nathan Tobie, Non siamo soli al mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 2003 [Nous ne sommes pas seuls au monde, Paris, Le Seuil, 2001].
[8] Illich Ivan, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Milano, Mondadori, 1977 [Limits to Medicine – Medical Nemesis: the Expropriation of Health, London, Marion Boyars, 1976].
[9] Gargani Aldo Giorgio, Stili di analisi. L’unità perduta del metodo filosofico, Milano, Feltrinelli, 1993, p.26.
[10] Ingold Tim, Ecologia della cultura, Roma, Meltemi, 2001, p. 64 [“Evolving skills”, in: H. Rose – S. Rose (eds.) Alas Poor Darwin. Arguments against Evolutionary Psychology, London, Jonathan Cape, 2000. pp. 225-246].
[11] Whitehead Alfred North, Modes of Thought, New York, McMillan, [1938] 1968, p. 9 (trad. mia).
[12] Asad Talal, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, 2003.
[13] Hyde Lewis, Il dono. Immaginazione e vita erotica della proprietà, Torino, Bollati Boringhieri, 2005 [The Gift. Imagination and Erotic Life of Property, New York, Vintage Books, 1983].
[14] “Within the Native American worldview, compartmentalization ideology is an imposition that attempts to displace a more interconnected experience. Most Native American people experience their being in the world as a totality of personality and not as separate systems within the person. […] the Native American worldview is one in which the individual is a part of all creation, living life as one system and not in separate units that are objectively relating with each other”. Duran Bonnie – Duran Eduardo, “Applied Postcolonial Clinical and Research Strategies”, in: Battiste
Marie (ed.), Reclaiming Indigenous Voice and Vision, Vancouver –Toronto, University of British Columbia Press, 2000, p. 91 (trad. mia). Bonnie Duran è assistant professor alla University of New Mexico School of Medicine.
[15] Spagna Francesco, “La Midewiwin e gli antropologi: campi magnetici”, in: G. Lanoue, F. Spagna (eds.), La forza nelle parole. Percorsi narrativi degli Indigeni canadesi da Jacques Cartier a oggi, Rivista di Studi Canadesi, suppl. al n. 13, 2000, pp. 45-64. Spagna Francesco, “The Anthropologist and the Magic Shell”, Suomen Antropologi – Journal of the Finnish Anthropological Society, 2, 2013, pp.23-40.
[16] Spagna Francesco, Sulle orme della tradizione. Gli Indiani d’America e noi, Padova, Imprimitur, 2008. Cfr. Sahlins Marshall, “Two or three things I know about culture”, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 5, 3, 1999, pp.399-421.
[17] Milloy John S. (1999). A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System 1879–1986. Winnipeg, University of Manitoba Press, 1999. Ward Churchill, Kill the Indian, Save the Man: The Genocidal Impact of American Indian Residential Schools, San Francisco, City Lights Books, 2004.
[18] Fine-Dare Kathleen S., Grave Injustice: The American Indian Repatriation Movement and NAGPRA, Lincoln, University of Nebraska Press, 2002.
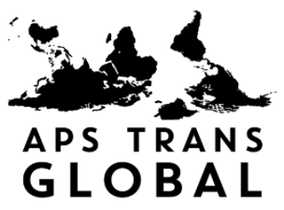
Scrivi commento