Stefano Rota
Più il potere e la conoscenza, il potere e il sapere si appropriano di questa soggettivazione che deriva da loro, ma che ne è indipendente, più nuove forme di soggettivazione [si] formano instancabilmente, quasi inconsapevolmente.
G. Deleuze, La soggettivazione. Corso su Michel Foucault (1985-1986)/3
Ogni formazione sociale vive di rapporti di potere: la famiglia, il luogo di lavoro, le istituzioni scolastiche, le strutture, anche le più minute, di produzione del controllo, le varie comunità e gruppi nei social network, fino alle grandi istituzioni, ai sistemi che definiscono su scala nazionale e sovrannazionale modelli consolidati di organizzazione della vita, tanto a livello collettivo, quanto individuale. Ma ogni rapporto di potere implica punti di resistenza. Su di essi – in modo esplicito o nascosto, organizzato o spontaneo, collettivo o individuale – si articola la costituzione di soggettività che esprimono (potenzialmente o palesemente) forme di antagonismo, sottrazione, “contro-condotta” rispetto ai dispositivi al cui interno tutti noi agiamo quotidianamente.
Per questa ragione, trovo più che mai attuale la domanda[1] che dà il titolo a questo articolo. Allo stesso modo, mi sembra che quella stessa domanda possa essere considerata il leitmotiv del lavoro che stiamo svolgendo Piero Acquilino e io; una domanda che, sia pur mai formulata in modo diretto, dà ritmo e senso alle conversazioni con tutte le persone con cui ci stiamo confrontando.
Dal mio punto di vista, e in linea con quanto il nostro lavoro intende mettere in evidenza, interpreto – arbitrariamente – quel quesito come l’urgenza di indagare le forme che ha assunto e assume il “dispositivo lavoro” negli ultimi sessant’anni, a partire dalla descrizione che i soggetti nostri interlocutori ci rimandano della vita dentro e fuori i luoghi di lavoro, delle lotte, delle rivendicazioni, delle alleanze che si articolano e si susseguono lungo questo periodo. Detto in altri termini, a partire dall’analisi delle soggettività che si costituiscono dentro, contro e in rapporto con le varie combinazioni di potere/sapere che il modello produttivo, politico e culturale attua nei luoghi di lavoro e in tutto il corpo sociale; a partire dall’aggancio ai “punti di resistenza” che, per la costituzione di quelle stesse soggettività, giocano un ruolo primario.
Un punto importante va ancora evidenziato: non si tratta di una “storia dell’antagonismo operaio” che propone una lunga sequenza di momenti di conflitto. Le storie individuali che entrano (per non uscirne) nei colloqui fatti non vogliono mettere l’accento su quel tipo di storia, anche se se ne delineano ovviamente le tracce e le modalità espressive. Tendono piuttosto a mettere in evidenza la correlazione che si instaura, a partire dall’esperienza storicamente individuale vissuta, “di un ambito di sapere, di un tipo di normatività, di un modo di rapporto con se stessi”[2]. In ognuno degli incontri realizzati, le tre dimensioni emergono con passione e chiarezza (e con nette differenze tra gli interlocutori), coinvolgendo la sfera familiare e comunitaria, l’ambito territoriale, le scelte politiche, la posizione nel lavoro, le aspettative e i progetti di vita.
Parlando di “lavoro”, si apre subito una questione importante, che rimanda a una scelta fatta in avvio di quanto ci si sta impegnando a fare in questa attività “analitico-politica”. Si è deciso di limitare il campo ad alcuni ambiti produttivi che, in modi e tempi differenti, hanno costituito la spina dorsale della Genova industriale fino alla grande crisi dell’inizio degli anni Ottanta, ed estendendo quindi quell’analisi ad altre realtà che, per caratteristiche produttive, organizzative e culturali, rappresentano in modo paradigmatico il “dispositivo lavoro” della nostra attualità. Ma questo obiettivo, così enunciato, sarebbe stato ancora molto gravoso e quasi certamente oltre le nostre possibilità. Si è deciso quindi di concentrare l’interesse su alcuni momenti che hanno marcato incontrovertibilmente il divenire del lavoro stesso, cercando di catturarlo nelle soggettività che in esso si sono prodotte e nelle forme di resistenza a cui quelle soggettività, costituendosi, si sono agganciate.
La domanda iniziale dis-piega, con un movimento verso l’esterno e verso l’interno, tutto il potenziale che le è implicito. Se è ragionevolmente intuitivo rispondervi pensando al decennio iniziato nel 1968, senza per questo voler omogeneizzare la pluralità di motivazioni che hanno condotto in piazza decine di migliaia di persone, diversa è la situazione se ci spostiamo più vicino alla nostra attualità. Basti pensare a cosa rappresenta oggi il lavoro, con le forme e i tempi che assume in un ambito affatto strategico qual è la logistica, ad esempio, o alla struttura a scatole cinesi che connota il lavoro nella cantieristica. In entrambi i casi – non a caso citati, perché parte di questo lavoro – l’elemento che contraddistingue il rapporto tra lavoratori e i decisori finali delle scelte e delle tecniche organizzative di lavoro applicate è la distanza, a volte l’immaterialità, dei luoghi di comando, che rende difficile la definizione di rivendicazioni, le contrattazioni, il riconoscimento di forme di rappresentanza. Va detto che il non riconoscimento della rappresentanza non è un dato che interessa solo le controparti dirigenziali dei lavoratori, ma, in buona parte, anche i lavoratori stessi, che, per le forme, i tempi, le tecniche che assume il lavoro, rende complicati i momenti di aggregazione, di condivisione di problematiche. Ciò non impedisce il sorgere di momenti di conflittualità anche molto elevata, a cui stiamo assistendo con una certa frequenza: quello che appare difficile (e le forme organizzative del lavoro in questi ambiti puntano proprio a questo) è la sedimentazione, il divenire minimo comune denominatore, l’articolazione tra ambiti differenti del conflitto.
Ritorna quindi prepotentemente la domanda iniziale: cosa intendiamo per “lotta”? Quale rapporto il lavoratore (in quegli ambiti, ma non solo) ha con se stesso, con le maglie del potere a cui è assoggettato, con le forme di sapere che quel potere strutturano? Si tratta di un rapporto che mette radicalmente in discussione le forme di “lotta di classe” a cui siamo spontaneamente portati a fare riferimento e indica in modo altrettanto inequivocabile l’urgenza di ripensare un’ontologia dell’antagonismo nel nostro presente [3]?
Se questi rappresentano alcuni dei quesiti e degli obiettivi del lavoro intrapreso è proprio perché il senso di un’indagine analitico-politica, o clinica, va ben oltre la produzione di una “critica”: ha come obiettivo il collocarsi all’interno della definizione di un “essere politico” aderente alle condizioni socio-storiche al cui interno ci muoviamo, un “politico” che sia non la somma ma l’elemento di raccordo tra tutte le esperienze “politiche”[4] che ogni specifica lotta esprime. Per non correre il rischio di apparire eccessivamente ottimisti – o, peggio ancora, inevitabilmente presuntuosi – definiamo come obiettivo minimo quello che è uno dei presupposti di una ricerca attivista[5]: restare lì, dove l’inchiesta ha preso avvio e lì continuare il suo lavoro; quindi, con quale linguaggio, quali priorità, quali alleanze, quali limiti, ma anche senza quali filtri, senza quali preconcetti, senza quali zavorre.
La scelta di partire dall’inizio degli anni Sessanta per questa ricerca ha, da questo punto di vista, una funzione strategica ed epistemologica piuttosto chiara. È in quel periodo che nasce a Genova una nuova figura operaia, a fianco di quelle più tradizionali che continuano ad esistere, all’interno della neo-costituita Italsider: con essa nascono nuove strategie, nuovi saperi, nuove tecniche di dominio, nuovi quartieri, nuovi modelli di consumo, nuove aree di provenienza. In una parola, un nuovo rapporto tra l'esistenza, individuale, familiare, comunitaria, e il lavoro.
A fianco (nel senso stretto del termine) continua a vivere e a prosperare, almeno fino all’inizio degli anni Ottanta, la grande fabbrica degli operai specializzati, l’Ansaldo, e poco più in là il Cantiere, con caratteristiche produttive e organizzative molto specifiche. Il tutto in non più di tre chilometri. Il racconto dei nostri interlocutori (Piero per una parte svolge anche il ruolo dell’interlocutore, avendo lavorato dall’inizio degli anni Settanta fino al primo decennio dei 2000 prima all’Ansaldo e poi al Cantiere) si articola su diversi piani, sempre emergenti nella narrazione spontanea, non scandita da domande, che si intersecano su alcuni punti nodali: la vita sul lavoro, i rapporti familiari, il rapporto con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni politiche, con forme di sapere che creano nuove alleanze (il gruppo di Gianfranco Faina e quello degli studenti di Medicina, ad esempio).
Dalla nascita dell’Italsider e l’applicazione della job evaluation, quindi, si arriva all’autunno caldo, allo Statuto dei Lavoratori, all’inquadramento unico, passando per la vertenza della Chicago Bridge, i consigli di fabbrica, la grande crisi del modello produttivo che fa sprofondare Genova in una palude, da cui sembrava impossibile potesse uscirne. E poi, ancora, la direzione “illuminata” del personale dell’Ansaldo a cavallo tra anni '70 e '80, le sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi della produzione al Cantiere, con il tentativo di adattamento a quella realtà del toyotismo, ancora negli anni '80, la nascita di Leonardo e la ristrutturazione del polo tecnologico, fino all’attuale struttura del lavoro al Cantiere e, per concludere, l’installazione di Amazon a Campi.
Sono questi i passaggi che vengono presi in considerazione nel lavoro che stiamo realizzando, attorno ai quali, ci sembra, sia possibile ricostruire almeno parzialmente una genealogia delle forme di esperienza, delle soggettivazioni che a quelle esperienze danno corpo, voce e vita.
Il tempo e il corpo: sono i due elementi che danno il senso di questo scavo archeologico sotto i nostri piedi. Il corpo viene impresso e devastato dalla diversa composizione dei tempi che ne fanno la storia. Vi ci lasciano, quei tempi, delle tracce che segnano una cartografia multisensoriale, ripercorribile attraverso le narrazioni che ricompongono le visibilità, gli odori, i suoni, i godimenti e i dolori dei vivi, dei morti e dei fantasmi[6], per sottrarli alla storia dei vincitori. Forse a questo scavo, tutt’altro che puro esercizio di attività di ricerca, è necessario volgere la nostra attenzione per darci la possibilità di definire, con i tempi lunghi che questo richiede e affinando la vista su ciò che abbiamo di fronte, quale sia oggi il significato di “lotta”.
[1] È una domanda che Foucault, dialogando con i suoi interlocutori, si pone in due distinte interviste del 1977, La torture c’est la raison e Le jeu de Michel Foucault - contenute in Dits et écrits, Tomo II, Gallimard, Parigi, 2001, la prima e Tomo III, 2004, la seconda. Non essendo state pubblicate in italiano, le ho trovate e tradotte abusando ancora una volta della sempre preziosa disponibilità e abbagliante competenza di Daniele Lorenzini. Nel primo scritto, Foucault dichiara di voler fare la storia dei vinti, chiedendosi però se esiste “una lingua dei vinti”. Se è così, “possiamo descrivere la storia come un processo di guerra? come un susseguirsi di vittorie e sconfitte? Questo è un problema importante che il marxismo non ha ancora del tutto superato. Quando parliamo di lotta di classe, cosa intendiamo per lotta? È una questione di guerra, di battaglia? Possiamo decodificare lo scontro, l'oppressione che avviene all'interno di una società e che la caratterizzano, possiamo decifrare questo scontro, questa lotta come una sorta di guerra?” Un tema ripreso nella seconda intervista, dove Foucault afferma: “se si considera che il potere deve essere analizzato in termini di rapporti di potere, mi sembra che qui abbiamo un mezzo per cogliere, molto meglio che in altre elaborazioni teoriche, il rapporto che c'è tra il potere e la lotta, in particolare la lotta di classe. Quello che mi colpisce, nella maggior parte dei testi, se non di Marx, almeno dei marxisti, è che (tranne forse nel caso di Trotskij) viene sempre ignorato cosa intendiamo per lotta quando parliamo di lotta di classe. Cosa significa qui lotta? Confronto dialettico? Lotta politica per il potere? Battaglia economica? Guerra? Società civile attraversata dalla lotta di classe, quale sarebbe la guerra continuata con altri mezzi?”.
[2] M. Foucault, Prefazione alla Storia della sessualità, in M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica e politica, Archivio Foucault 3, pp. 233-239, Feltrinelli, Milano, 2020, pp. 233-234
[3] Nel suo intervento in Res publica. La forma del conflitto, Olivier Marchart sostiene che “il nome appropriato per il politico come ciò che descrive la natura ontologica di tutti i fatti sociali sia ‘antagonismo’”. Da qui ne deriva che “ridirigendo l’attenzione sulla natura in ultima analisi conflittuale di tutto ciò che è sociale, un’ontologia del politico ci spinge a sviluppare una prospettiva politica complessiva sul sociale”. O. Marchart, Ontologizzare sempre! L’antagonismo e il primato della politica, in A. Di Gesu, P. Missiroli, Res publica. La forma del conflitto. Quodlibet, Macerata, 2021, pp. 70-71.
[4] In apertura dello stesso saggio, Marchart distingue “tra la politica ontica ‘ordinaria’ e una nozione ontologica del politico (come dimensione che pertiene all’intero campo del sociale più che a una pratica o campo particolare)”, evidenziando come in francese tale distinzione sia marcata dalla differenziazione tra la politque e le politique. Marchart, cit. pag. 69.
[5] Il tema della ricerca attivista è stato trattato nel paper S. Rota, Note per una ricerca attivista (o clinica), pubblicato in tre parti su Transglobal:
https://associazionetransglobal.jimdofree.com/2021/04/05/note-per-una-ricerca-attivista-terza-parte/
[6] Un riferimento all’affascinante lavoro svolto dall’antropologa Stefania Consigliere sulle presenze spettrali, di cui riporto uno dei paragrafi finali del suo articolo Le Rovine selvagge (2018): “Ora che le mura della fortezza cominciano a creparsi, il momento è eccellente per fare la conoscenza degli spettri che imprigionava e dare loro, finalmente, ciò che è loro dovuto. Imparentato all’angelo della storia descritto da Benjamin, il fantasma rivela ciò che è stato nel passato e rimpiange quel che avrebbe potuto essere”. Una concezione di fantasma at large, quindi, al cui interno Stefania include “tutto ciò che una cultura rimuove dalla propria zona di conoscibilità e relega nel non dicibile, nelle cripte mentali e nell’abbandono, illudendosi così di non doverci più fare i conti” (pp. 15-16). Una trattazione del tema in forma più compiuta è contenuta in S. Consigliere, P. Bartolini, Strumenti di cattura: Per una critica dell’immaginario tecno-capitalista, Jaka Book, Milano, 2019, in particolare nella parte 12 “Haunting”.
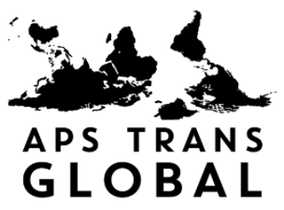
Scrivi commento