Quando Dio vuole fare impazzire qualcuno, esaudisce tutti i suoi desideri
Paulo Coelho, Le Valchirie
Hannibal Lecter, pluriomicida dedito all’antropofagia con le sue vittime, ma anche esperto psichiatra, interroga Clarice Starling, giovane agente dell’FBI, nel celebre film Il silenzio degli innocenti:
(Lecter) “Qual è la prima e principale cosa che fa [parla di Buffalo Bill, lo psicopatico che sta uccidendo giovani donne], quale necessità soddisfa uccidendo?” (Starling) “Rabbia, risentimento sociale, frustrazione sessuale…” (Lecter) “No! Desidera! Questa è la sua natura. E come iniziamo a desiderare, Clarice? Cerchiamo cose da desiderare? Stupiscimi con la tua risposta”. (Starling) “No, noi…” (Lecter) “No, esatto. Iniziamo a desiderare ciò che vediamo ogni giorno”.
Il desiderio è ciò che porta Buffalo Bill all’assassinio di svariate donne: il desiderio di avere, se non un corpo di donna, quanto meno un corpo rivestito da pelle umana femminile, che lo porta a confezionarsi un abito fatto con l’epidermide delle donne uccise. Desidera quella pelle, la vede ogni giorno. Come sostiene Lecter, la rabbia, il risentimento, la frustrazione, gli stessi omicidi sono secondari, avvengono in conseguenza del sorgere del desiderio nella mente di uno psicopatico criminale.
Scusandomi per l’approccio pulp al tema, provo a ritornare al significante desiderio affrontandolo in termini, per fortuna, più consueti alla nostra quotidianità, perché è fuori dubbio che ognuno di noi sperimenti il desiderio nelle mille forme in cui questo si manifesta.
Dire che non cerchiamo cose da desiderare, ma “iniziamo a desiderare ciò che vediamo ogni giorno”, equivale a dire che facciamo un’esperienza del desiderio come causa sui. Non è l’effetto di altro, se non nei termini in cui lo pone Lacan quando parla di desiderio dell’Altro: il desiderio è ciò che l’Altro desidera, laddove con Altro si intende il Grande Altro. Questo mi sembra un punto centrale, che ha a che vedere con molte e diffuse pratiche derivanti da modelli che ci vengono proposti quotidianamente. Suely Rolnik e Nora Merlin, due psicanaliste e filosofe sudamericane (brasiliana la prima, argentina la seconda) insistono da anni sulle conseguenze mortifere della colonizzazione psichica della soggettività in chiave neoliberalista. Noi desideriamo quello che vediamo ogni giorno, perché è ciò che la nostra condizione ci fa vedere, ciò che la nostra vista seleziona: non si tratta di processi oggettivi, ma relazionali tra noi e le proposte da cui siamo bombardati. Non è possibile stabilire una separazione netta tra noi soggetti e gli oggetti che vediamo e desideriamo, li vediamo perché sono già in noi.
Il desiderio come tecnica di potere ha origini lontane, come ha illustrato magistralmente Foucault in Sicurezza, Territorio, Popolazione; risale al XVIII secolo, con la nascita della “popolazione” e del “pubblico”, soggetti collettivi fondamentali nella filosofia utilitaristica dei fisiocrati che impone di “far presa su oggetti di cui si conosce la capacità di incidenza sulla popolazione stessa”, sulla sua “naturalità”. “L’idea della gestione delle popolazioni a partire dalla naturalità del loro desiderio e di una produzione spontanea dell’interesse collettivo è un cambiamento fondamentale nelle tecniche di governo. Bisogna riuscire a dire “sì” al desiderio della popolazione”.
Siamo ancora lontani, almeno mi sembra, dalle tecniche di dominio basate sull’induzione del desiderio, sul suo controllo, sull’interiorizzazione psichica delle norme che governano questo processo. In altre parole, il desiderio come parte fondamentale del processo produttivo e riproduttivo, come merce. Ma la linea è tracciata. Il desiderio, da ancora prima, dal II-IV secolo e tramite la sua esternalizzazione, diviene il modo per governare e giudicare la vita degli individui. Su questa pratica, sostiene ancora Foucault in Le confessioni della carne, si baserà la formazione giurisdizionale del rapporto tra autorità e individuo.
Richard Miskolci inizia un suo interessante articolo di qualche anno fa pubblicato sulla rivista online brasiliana RevistaCult, dal titolo Redes de ressentimento. Notas sobre o microfascismo nas redes sociais, con la descrizione di una scena di un altro film:
“In La Rosa purpurea del Cairo di Woody Allen (1985), - scrive Miskolci - nel mezzo della Grande Depressione degli anni '30, una donna disoccupata e maltrattata dal marito cerca rifugio in un cinema del New Jersey. Cecile scambia la realtà con la fantasia, guarda più volte lo stesso film finché il protagonista non esce dallo schermo ed entra nella sua vita.”
Da qui parte il ragionamento di Miskolci sul ruolo che hanno i media nella vita di ognuno di ogni, su come il suo uso sempre più frequente e individualizzato, con il passaggio dal cinema, alla televisione, a internet e agli smartphone, abbia frantumato la barriera tra reale e virtuale (come ha ben spiegato Mark Fisher, il reale non è l’opposto del virtuale). L’immagine un po’ romantica e sognatrice di Cecile si traduce, con l’uso degli smartphone, in una perenne condizione di protagonista del film della nostra vita, basata su un gesto divenuto usuale per molti di noi: “rivolgere l’obiettivo verso se stessi”. Una successiva frase dell’autore dell’articolo mi consente di ritornare a quanto detto prima sulla colonizzazione psichica della soggettività. La frantumazione della parete non più insormontabile dello schermo non avviene solo quando siamo online, “ma anche nell’intimo e profondo offline delle nostre coscienze”.
Rieccoci al punto di partenza di queste considerazioni. Desideriamo quello che vediamo, non solo in termini di prodotti di consumo diretto, ma anche o soprattutto in modalità di apparire, di parlare, di cercare consenso alle nostre affermazioni di cui riempiamo i social media. Il “likismo” è un credo da cui nessuno di coloro che usano assiduamente i media è esente, se no, non avremmo come “amici” e/o followers chi sappiamo in partenza che, molto probabilmente, apprezzerà le nostre esternazioni.
Per questi motivi, non mi sembra affatto esagerata la definizione di “microfascismo nelle reti sociali” che dà il titolo a questo bell’articolo di Miskolci. Ma c’è un motivo in più per sostenere quella definizione. Il desiderio di apparire come speciale, fico, spiritoso, intelligente, originale, in pratica quello che i colossi della Silicon Valley ci hanno da sempre detto che saremmo stati nei loro network, ci riporta a quanto detto sopra riguardo il desiderio come modo per governare e giudicare la vita degli individui. Si è creato all’interno di ogni social network un rapporto giurisdizionale tra autorità e individuo, dove il concetto e il confine di autorità assume contorni che vanno dal gestore del network, alla comunità pressoché illimitata dei suoi frequentatori.
Paolo Godani ha dedicato un suo recente lavoro editoriale al desiderio o, per meglio dire, al piacere che il desiderio stesso annichilisce. Il libro, titolato Sul piacere che manca. Etica del desiderio e spirito del capitalismo, è un affascinante excursus del rapporto secolare e sempre in contrapposizione tra piacere e desiderio. Mi sembra che quanto qui brevemente accennato si collochi in quella linea. Il desiderio non cessa di essere fonte di produzione di soggetti il cui tratto principale è proprio l’assoggettamento a tecniche di dominio che inducono una soggettivazione modulata su principi etici che ci collocano in una dimensione dove la ricerca del piacere viene negata dal predominio asfittico del desiderio. “La soddisfazione della sfida, del miglioramento di sé, del rilancio continuo e della competizione è un genere di piacere costitutivamente insoddisfatto”, scrive Godani.
È possibile sostituire il desiderio e con cosa, quale taglio possiamo effettuare, affinché non venga espulsa dalle nostre vite il piacere, visto che l’egemonia del desiderio ci sottrae da sotto le nostre mani le condizioni di possibilità del piacere? Provo ad abbozzare, per come posso, due risposte.
Marx nel terzo dei Manoscritti del 1848 usa il termine “passione” per definire “Il dominio dentro di me dell’ente oggettivo, l’erompere sensibile dell’attività del mio essere”; la passione, quindi, diviene “l’attività del mio essere”. La passione in quanto attività dell’essere umano che si rende possibile nell’unità tra uomo e natura, uomo e mondo, vanifica il rapporto tra soggetto e oggetto, tra interiorità ed esteriorità. È una bella definizione, non c’è dubbio. La passione come attività, non il desiderio come mortificazione dell’agire, perché sempre insoddisfacibile e sempre sfuggente. Il piacere è connaturato alla passione come attività, c’è un rapporto di immanenza tra i due stati.
“Utopia, per me, è un al di là. Al di là terreno. Esito a dire mondano. Perché mondo oggi si identifica con questo mondo: esattamente ciò che mi respinge e che mi spinge a cercare un oltre. Sento vicina, per questa via, ogni misura o dimensione trascendente. Senza identificarmi con le forme teologiche che essa assume, trovo lì, e utilizzo, un pensare, e un parlare, di misura politica, che metaforicamente, o allegoricamente, accenna a qualcosa d’altro da qui, da questo. C’è antagonismo già in questa sola scelta”.
Questa abbagliante definizione di utopia è di Mario Tronti, inclusa nel suo breve saggio Disperate Speranze. Una blochiana “utopia concreta” è, scrive Tronti, “un urto con la realtà. Un disperato grido di speranza”.
Anche in questo caso, siamo agli antipodi del desiderio come ripiegamento in una dimensione onirica, idiota e perennemente sfuggente alla nostra “volontà di potenza” come affermazione della vita.
Ma c’è un passaggio a dir poco dirompente in questo scritto, dove passione e utopia si fondono in una visione della storia che ne cancella il corso lineare, problematizza l’idea di futuro come il luogo a cui affidare le nostre speranze e di un passato come qualcosa di non modificabile.
“La passione utopica è un’istanza soggettiva, spezza la storia, la mette sottosopra, è contro ciò che è, ma non contro tutto ciò che è stato. Non cammina verso il futuro, salta oltre il presente, anche in nome di un altro passato”.
È nella passione utopica dove si trova il più efficace antidoto al dominio del desiderio e allo stesso tempo la potenza affermativa della vita come possibilità di riconoscere e frequentare il futuro ora.
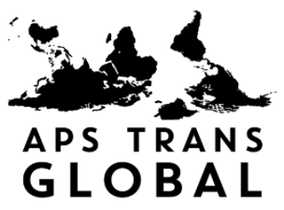
Scrivi commento
Giuseppe De Feo (mercoledì, 01 marzo 2023 19:13)
Una bella e chiara riflessione che rende più evidenti i limiti e gli effetti perversi del desiderio, come inganno per dominare che oggi proviene dalla cultura e dal sistema neoliberale. Un quadro inquietante, al quale pare difficile sfuggire, considerata la diffusa tendenza a farsi schiavi del desiderio e di tutti i suoi artifici sostenuti dalla tecnologia. Come praticare oggi la passione e l'utopia? Domanda, forse, insieme ingenua e complessa, alla quale dedicare altre pagine di riflessione e approfondimento, nei prossimi post!
Stefano (giovedì, 02 marzo 2023 13:32)
Grazie! La domanda non è ingenua, ma è certamente complessa. Personalmente l'unica risposta che trovo sta nelle ultime due righe: riconoscere e frequentare (utopisticamente e passionalmente) il futuro come pratica odierna, la condizione di possibilità per sottrarsi dall'abbraccio mortifero del desiderio.