Nicholas De Genova
L’antropologo statunitense Nicholas De Genova affronta il controverso tema dell’inclusione, alla luce di un concetto non molto in uso in Europa, ma estremamente efficace per spiegare, come fa De Genova, le dinamiche socio-politiche che contrappongono “cittadini” e “altri”, primo e terzo mondo, o, per dirla con le parole di Balibar, “due umanità”. Si tratta del concetto di “nativismo”, che negli Stati Uniti indica fin dall’inizio del Novecento i movimenti contro gli immigrati animati da discendenti dei coloni anglosassoni. E’ a partire da qui che De Genova spiega, con grande senso dell’attualità, termini di uso comune, quali razzismo e nazionalismo, inclusione ed esclusione. (s.r.)

In questo articolo per il blog di Transglobal cercherò di destrutturare alcuni dei concetti nazionalistici e razziali, usati come base per le disquisizioni intellettuali convenzionali e dibattiti politici su quei termini “scivolosi” che rispondono al nome di “inclusione” ed “esclusione”, con un particolare riferimento al loro uso per le politiche migratorie (e di razza) nello scenario europeo contemporaneo. Gli stessi argomenti sono stati da me trattati in modo più ampio in un recente articolo per l’European Journal of Social Theory, dal titolo Migration and Race in Europe: the Trans-atlantic Metastases of a Post-colonial Cancer.
Capita di incontrare, ad esempio negli scritti di Habermas (1996-1998), l’equazione tra “Terzo mondo” e “cheap labor”, rafforzata dalla nozione di “sottoclasse”. Con “cheap labor”, che implica in sé il concetto di “rubare il lavoro” e quindi minare la condizione sociale di quella che si considera il soggetto unico avente diritto al lavoro, la classe lavoratrice ”nazionale”, e simultaneamente di “sottoclasse” (inevitabilmente sottoccupata, disoccupata o non occupabile, ma sempre pronta a succhiare i benefici del welfare state), ci troviamo di fronte a quello che Étienne Balibar ha definito un “complesso da immigrazione”. Tale complesso induce alla “trasformazione di ogni problema sociale in un problema fondato, nei fatti, sulla presenza di immigrati, o, quanto meno, aggravato dalla loro presenza” (1991), qualunque sia il problema in questione.
David Theo Goldberg (1993) vede in questo un rinnovato progetto razziale di identità europea: viene rimodellata una “whiteness” post-coloniale, contrapposta a e accerchiata dall’eterogenea, amorfa massa di immigrati, certamente ostile dal punto di vista culturale e vissuta come una sorta di generica alterità.
In questo contesto, il “multiculturalismo”, qualunque cosa si voglia intendere con questo termine, viene visto come una condizione che può essere tollerata, finanche incoraggiata, ma sempre e solo subordinata a una obbligatoria deferenza nei confronti del corpo politico e giuridico – che incarna automaticamente i principi democratici universali e valori cosmopoliti - già definito e fissato dalla cultura (nazionale) dominante.
Propongo, inoltre, di utilizzare la categoria analitica di “nativismo” – con il suo significato di ostilità ed esclusione nei confronti dei migranti – perché più precisa rispetto al concetto psicologico e unidimensionale di xenofobia, anche se il termine “nativismo” è di scarso uso fuori dai confini statunitensi. Sostenendo la priorità dei nativi, per il semplice fatti di essere tali, il nativismo opera inestricabilmente come una politica di identità che alimenta tutti i nazionalismi. Se come elemento fondante della nazionalità viene assunta l’identità del nativo, la cosiddetta “inclusione dei migranti” in una comunità nazionale si basa necessariamente e costantemente sul primato e la priorità dei nativi, che costituisce la cifra identitaria del nazionalismo stesso.
Molti studiosi (tra i quali il già citato Habermas) si ostinano a non voler vedere una relazione tra questa condizione e il razzismo. Paul Gilroy, nel suo lavoro efficacemente intitolato Postcolonial Melancholia e successivamente in Dopo l’impero, fa notare che “il rifiuto di pensare il razzismo come qualcosa che struttura la vita della politica postimperiale si associa a quella che è diventata una morbosa fissazione nei confronti di un’impalpabile sostanza di identità e cultura nazionale”.
L’omissione dei razzismi europei - come conseguenza diretta della condizione postcoloniale d'Europa - serve soprattutto a rendere invisibile il postcolonialismo in sé, e supporta l'insinuazione che l’esplosione di movimenti razzisti o “nativisti” in Europa è leggibile solo in termini di manifestazioni di reazione populista, provocate dalla presenza inopportuna dei migranti stessi.
Così come l’Europa è stata “letteralmente creata dal Terzo Mondo”, secondo la memorabile definizione di Franz Fanon (1961-1963), allo stesso modo il cosiddetto Terzo Mondo è letteralmente una creazione dell’Europa e ne costituisce la sua legittima eredità. A questo proposito, Balibar (1991) ha suggerito l’immagine di “due umanità”. Storicamente costituita dal razzismo globale della modernità (coloniale) capitalista, questa umanità sdoppiata è composta dalle categorie di sub-umani e super-umani, associate rispettivamente a indigenza e ultrasviluppo. Queste “masse tendenzialmente incompatibili” si confrontano oggi su un piano che non ha precedenti e all’interno dello stesso spazio di vita quotidiana. I due campi umani vengono forzati all’interno dell’imprevista prossimità fisica e della casuale intimità, che sorge dalla condivisione di spazi di coabitazione, lavoro, produzione e, in misura minore ma comunque innegabile, di consumi. Questa riconfigurazione transnazionale e decisamente postcoloniale delle disuguaglianze di classe a livello mondiale segna inequivocabilmente l’incompiutezza del processo di decolonizzazione.
Ora, nella proliferazione di spazi metropolitani postcoloniali, queste ineguaglianze operano, irreggimentate all’interno delle odiose definizioni giuridiche di cittadino e straniero e, come non mai in passato, sotto i vessilli del nativo e del suo ostile e ineffabile altro, come mere differenze di “identità”.
Nuove dinamiche di razzializzazione e nuove forme di razzismo divengono, invero, inseparabili dalla produzione sociale della “differenza” dei migranti, nella misura in cui, molto frequentemente, dissimulano il proprio razzismo e dis-articolano “razza” e “immigrazione”, specificamente tramite politiche di nativismo. Non c’è solo la persistente e perniciosa reificazione del “dentro” e “fuori” lo spazio della “nazione”, o dell’Europa; ci sono anche “ghetti” e “città interne”, a cui si aggiunge una visione del “Terzo Mondo” connotata da una spirale involutiva di miseria, che porta a dichiararne l’incapacità di autogoverno.
Questo cosiddetto “Terzo Mondo” sembra essersi insinuato in Europa, guadagnandovi importanza in modo inversamente proporzionale al suo ruolo decrescente sul piano della geopolitica mondiale, facendo perdere all’Europa stessa quella sensazione di estraneità rispetto alle conseguenze dei disastri prodotti dalle proprie aziende coloniali nelle aree associate alla definizione di “Terzo Mondo”. La massa amorfa riconducibile alla crisi umana del Terzo Mondo viene trasposta in Europa, assumendo la nuova forma di crisi per l’Europa, riconfigurandosi come una “sottoclasse” di migranti “denizen” (“a cui è negata o riconosciuta solo parzialmente la cittadinanza”, da Mezzadra 2001, n.d.r.), le cui patologie penetrano i pori dell’Europa dall’interno.
Naturalmente, lo spazio precedentemente immobile di “sottosviluppo” e arretratezza culturale è riuscito a produrre il gioco di prestigio di rilocarsi in quanto “luogo”, mentre le persone ne venivano rappresentate come suo sinonimo. Queste, in quanto migranti – mobilizzati e in movimento – portano lo stigma negativo del Terzo Mondo sui loro volti, il loro corpo, vestiti e cibo.
Le dimensioni inevitabilmente eterogenee e smisuratamente contorte della “razza” in queste manifestazioni contemporanee di nativismo rendono, in ogni caso, meno significativa, meno utile, la seducente ma illusoria coerenza delle categorie “biologiche”. La politica di cittadinanza, apparentemente neutra dal punto di vista razziale e presumibilmente “legittima”, può favorire l’omissione della “razza” e l’intera gamma di concetti nativisti che il fantasma dell’”identità nazionale” si porta con sé.
Per contro, da tutto lo spettro politico, in un paese europeo dopo l'altro, i "nuovi" nativisti europei (in qualità di cittadini) si sentono autorizzati a deliberare sul "problema" dell’"immigrazione", chiedendo a gran voce e all'unisono: "Che cosa, noi, facciamo con loro ?" La stessa domanda può essere riformulata nel seguente modo: “Cosa si deve fare nei confronti di un Terzo Mondo impazzito che ha oltrepassato i suoi confini e ha avuto il coraggio di uscire dal suo posto?"
Più questo tipo di polemica nativista genera rumore e accaloramento, più procede a ritmo sostenuto l’inclusione di coloro che sono incessantemente oggetto di esclusione. La loro inclusione riguarda la subordinazione del loro lavoro; l’inclusione può essere realizzata solo nella misura in cui è assediata in modo permanente da campagne razziste e di esclusione, attraverso le quali ci si assicura che tale inclusione sia appunto una forma di sottomissione. Ciò che è in gioco, quindi, è un più ampio processo socio-politico (e giuridico) di inclusione attraverso l'esclusione, di importazione del lavoro (palese o dissimulata), fondata sulla costante deportabilità dei soggetti.
Quasi mezzo secolo fa, in mezzo alle tensioni, più o meno violente, della decolonizzazione e la morte certa e irreversibile del potere coloniale europeo su scala planetaria, Frantz Fanon, in I dannati della terra (1961), aveva proclamato che "il gioco europeo è definitivamente terminato", che “l'Europa va in vertigine spaventosa verso [gli] abissi […]". Pensò che fosse inevitabilmente l’ora di lasciarci questa Europa alle spalle. Eppure, nonostante la sua seria e incriminante valutazione, la critica anticoloniale di Fanon, che rievoca con chiarezza la nostra condizione post-coloniale universale, è stata splendidamente generosa nei confronti della plausibile “redenzione” degli europei, nonostante l'Europa. La sua saggia raccomandazione appare oggi più che mai pertinente e la sua urgenza ne risulta, anzi, intensificata:
“Il Terzo Mondo non intende organizzare una immensa crociata della fame contro tutta l'Europa. Ciò che esso si attende da quelli che l'han mantenuto in schiavitù per secoli, è che lo aiutino a riabilitare l'uomo, a far trionfar l'uomo dovunque, una volta per tutte. […] Questo lavoro colossale che è quello di reintrodurre l'uomo nel mondo, l'uomo totale, si farà con l'aiuto decisivo delle masse europee che, devono riconoscerlo, si sono spesso allineate circa i problemi coloniali sulle posizioni dei nostri comuni padroni. Per questo, bisognerebbe anzitutto che le masse europee decidessero di svegliarsi, si scuotessero il cervello e cessassero di giocare al gioco irresponsabile della bella addormentata nel bosco”.
Quindi, ora, il compito a cui sono chiamati gli europei di ripudiare e smantellare l’Europa (e collaborare al progetto globale di ricostruzione dell’umanità, al di là della lunga e duratura schiavitù dell’impero) si presenta immediatamente come un compito necessario semplicemente per poter continuare a vivere … in Europa.
*Nicholas De Genova is Reader in Urban Geography and Director of the Cities Research Group in the Department of Geography at King's College London. He is the author of Working the Boundaries: Race, Space, and "Illegality" in Mexican Chicago (2005), co-author of Latino Crossings: Mexicans, Puerto Ricans, and the Politics of Race and Citizenship (2003), editor of Racial Transformations: Latinos and Asians Remaking the United States (2006), and co-editor of The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement (2010).
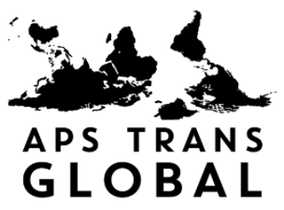
Scrivi commento