Cosa hanno in comune Theresa May, la premier britannica che ha preceduto Boris Johnson, e Antonio Albanese, il grande performer, attore, comico, mimo, ballerino e cabarettista? Apparentemente niente, vista la distanza siderale che li separa, ovviamente tutta a favore del secondo. In realtà, qualcosa condividono; entrambi hanno creato un ministero che non esisteva, ma di un’attualità sconcertante, ciascuno dove gli competeva: Theresa May dentro il suo secondo governo, nel 2017, Antonio Albanese dentro il palinsesto Rai nel 2008. Si tratta del ministero della Solitudine per la prima, il Ministro della Paura, da parte del secondo.
I due “ministeri” si intrecciano, si combinano tra di loro, vivono entrambi lì dove neoliberismo e biopolitica definiscono con il loro abbraccio mortifero lo spazio e le (differenziali) condizioni di esistenza delle nostre vite. Il fatto che il primo sia stato reale e il secondo frutto dell’abilità di mettere in scena personaggi allegorici del nostro tempo è un elemento del tutto ininfluente.
Mai, forse, dall’ultimo conflitto bellico la paura, in particolare della morte, ha svolto un ruolo assolutamente centrale nell’organizzazione e nella percezione della vita come in questo momento pandemico. Vita e morte vengono percepite come appartenenti a un unico piano: la morte è divenuta “parte della vita”, e la paura “è diventata un’angoscia strisciante, indistinguibile ormai dalla nostra stessa esistenza”. Così Paolo Godani nel suo ultimo lavoro Il corpo e il cosmo. Per un’archeologia della persona descrive la nuova episteme moderna, nata dopo l’âge classique, quindi con la fine del XVIII secolo, tutt’oggi più che mai viva.
Vediamo alcuni brevi passaggi tratti dalla prima apparizione del Ministro della Paura che quel genio di Antonio Albanese ha messo in scena da Fazio, dopo un anno dall’esplosione della grande crisi economico-finanziaria e undici anni prima di quella pandemica che stiamo vivendo.
“Se non ci fossi io le guerre scoppierebbero inutilmente, le epidemie non avrebbero senso, le bombe esploderebbero senza nessun vantaggio sociale. Io trasformo la paura in ordine, e l’ordine è il cardine di ogni società rispettabile. E soprattutto, senza la paura non si governa”.
“La politica moderna si capisce solo assumendo devastanti psicofarmaci”.
“Come ben sapete senza la paura non si vive, senza la paura della fame, della sete, non si vive, senza la paura della famiglia, della scuola, non si vive, senza la paura di dio e della sua barba bianca, non si vive”.
Difficilmente si potrebbe trovare un modo più chiaro per descrivere come la gestione della paura sia entrata nelle tecniche di governo, condizioni la formazione di una percezione di sé come soggetto costantemente (e differenzialmente) in pericolo, in cui la presenza della morte è immanente alla vita.
Quello che entra in gioco qui è la possibilità di riflettere, come dice François Jullien nel suo saggio La vera vita, sul significato di felicità e di come questa si relazioni con quel concetto molto complesso che dà il titolo al suo lavoro. Quella riflessione, scrive il filosofo e sinologo francese, si rende possibile grazie a una negazione. Negazione “del fatto che la violenza non può in realtà sparire – anzi, non deve sparire – perché è intrinseca alla vita; o del fatto che la morte è dentro alla vita e non solo ciò che le impone un fine”. Da qui ne deriva che “la vera vita inizia precisamente quando si è scoperta questa negazione per cui si fortifica la felicità nella sua utopia”.
Sul senso, mai compiuto, di vera vita, sul rompicapo della felicità, mi sembra si possa cogliere la continuità tra il Ministro della Paura e quello (quella, anzi, era la Ministra Crouch) della Loneliness.
In un articolo su The Guardian, Terry Eagleton recensisce due saggi, History of Solitude di David Vincent (in corso di pubblicazione) e A biography of loneliness di Fay B. Alberti. A questo, ha fatto seguito un altro articolo di Gustavo Assano su OutrasPalavras (un web magazine brasiliano molto ben fatto e interessante), in cui viene ripreso il tema trattato su The Guardian e sviluppato secondo una lettura che tiene necessariamente conto della drammatica situazione in cui versa il suo paese e degli interessi di studio e ricerca dello stesso autore.
In italiano non esistono due termini che distinguano la solitude dalla loneliness (così come in portoghese, la solitude dalla solidão): forse, il modo migliore per riprodurre quella differenza è usare due espressioni come “stare da solo” e “essere solo”, perché il termine “isolamento” rimanda a un’idea di costrizione, punizione, anche autoinflitta che mal si combina con l’idea romantica di solitude.
La loneliness, scrive Eagleton citando Vincent, è una solitude fallita (failed solitude), identificandola con una scelta che va, involontariamente, oltre la scelta stessa. La ricerca della solitude aumenta con il crescente affollamento della società moderna, si tratta di un’esigenza che storicamente viene avvertita, ma ancor più attualizzata, da membri della upper-class, poeti, scrittori, artisti. Se a partire dal XIX secolo sempre più membri della middle class dimostrano propensione alla solitude, è nella nostra contemporaneità che tali tendenze sembrano ampliarsi, soprattutto tramite la “networked solitude” o le varie tecniche, più o meno esotiche e pseudo-spirituali, di ricerca del benessere. Se Vincent, come riporta Eagleton, non avverte l’emergenza di una “pandemia della solitudine”, Alberti presenta nel suo lavoro uno scenario differente. Partendo da un punto di vista diverso la quello di Vincent e prestando più attenzione agli stati emozionali, sostiene nel suo saggio che la loneliness è stata creata, razionalizzata, solo nell’Ottocento. È in quel periodo, sostiene Alberti, che la solitude ha cominciato a manifestare tratti e dimensioni che andavano ben oltre la sua connotazione classica, divenendo oggetto di interesse da parte di vari ambiti scientifici e, quindi, politici e tecnico-amministrativi. Da lì, con lo sviluppo costante del capitalismo industriale, è stato un crescita continua, accompagnata da cambiamenti nelle forme della e nei discorsi sulla loneliness stessa. Come dire, parafrasando Foucault, che in quel periodo si sono date le condizioni per la “formazione di oggetti” di analisi e intervento, la cui regolarizzazione consente la formulazione di enunciati che costituiscono il discorso sulla loneliness. La “separazione di sé dalla società” non è certo nata nell’Ottocento, ma solo all’interno di quel contesto si è resa possibile la sua problematizzazione. Allo stesso modo, ci sono voluti altri due secoli affinché al premier di una delle maggiori potenze occidentali venisse in mente che era giunto il momento di dedicargli un ministero.
Questo importante passaggio nel discorso sulla loneliness viene trattato nell’articolo di Assano su OutrasPalavras. Nel periodo connotato dalla accesissima discussione sulla Brexit, la visione di una solitude come conseguenza di una scelta per valorizzare momenti particolari della vita di una persona lascia il posto al “pessimismo statistico [che indica come] più di un quinto della popolazione adulta nel Regno unito si percepisce sola per la totalità o quasi totalità del tempo”, come evidenziò uno studio della Croce Rossa nel 2016. Da qui, dice Assano, il sorgere di una emergenza per preservare l’ordine pubblico, per la gestione della sofferenza sociale, “una combinazione di fattori demografici, politici, culturali, ideologici e medici che hanno creato una ‘categoria di esperienza’ da ricondurre a logiche di governamentalità, un indice per gestire la sofferenza psichica di massa”.
“La politica moderna si capisce solo assumendo devastanti psicofarmaci”, fa dire Albanese al suo personaggio: una frase che potrebbe essere stata pronunciata dalla ministra Crouch.
È inutile ricordare come la pandemia - e soprattutto il modo in cui è entrata quotidianamente nelle nostre vite attraverso i media - abbia generato una “categoria di esperienza”, le cui conseguenze a livello di sofferenza psichica per l’isolamento forzato e ingestibilità della paura ha condotto a un aumento spropositato di uso di psicofarmaci e di richieste di supporto psicologico.
Le conseguenze non solo o non tanto della pandemia, ma principalmente di un sistema produttivo che crea continuamente momenti di sospensione che si trasformano in solitudine e paura produce una massa di “solitari in interdipendenza sistemica” affetti da “mutilazioni soggettive”. La scelta che abbiamo di fronte, allora, è la “reinvenzione di una solidarietà tra mutilati, la scoperta di una nuova collettività”.
Reinventare forme di solidarietà, di mutualismo di base può essere, forse, l’unico punto di partenza per la produzione di nuove articolazioni che riescano a delineare un progetto in grado di farsi egemone. Dal mio punto di vista, questo è ciò che sta insegnando l’esperienza del Collettivo della GKN di Firenze.
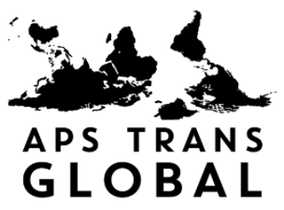
Scrivi commento
Giuseppe De Feo (giovedì, 10 febbraio 2022 16:36)
Un testo denso, che - con uno stile lucido - mette in evidenza intuizioni importanti e utili.
Stefano Rota (giovedì, 10 febbraio 2022 19:12)
Grazie!