di Farah Abdessamad*
La vita dei nordafricani in Francia è caratterizzata da una straziante lotta per l'appartenenza, segnata dal trauma postcoloniale
Non riuscivo a mangiare molto e il più delle volte barcollavo. La forza abbandonava la mia struttura indebolita. "Non sto bene", dicevo a chi mi ascoltava. "Ho dolore", aggiungevo, indicando lo stomaco, la testa, i polsi, quando non erano le ginocchia o il collo a darmi fastidio. In questi momenti, il mio corpo si sentiva sballottato tra lo stress e il sonno insufficiente - spento, interrotto da sensazioni di rosicchiamento, torsione e pulsazione. Desideravo che qualcuno mi stringesse il braccio, per farmi sapere che qualsiasi cosa stesse schiacciando le mie viscere sarebbe stata presto sconfitta. Ogni volta che si verificavano queste esplosioni di malattia, mi nascondevo, stringendo un ciondolo di corallo tunisino ereditato, al quale avevo attribuito proprietà talismaniche.
Ero una bambina malata, dai capelli ricci, che evitava di giocare all'aperto. Crescendo nella zona ovest di Parigi, mi distinguevo già tra i miei amici francesi come la bambina che era come loro ma non del tutto: mezzo bianca, per via di mia madre, e mezzo araba, per via di mio padre, il che mi condannava a una diversa categoria di francesità. Volevo disperatamente integrarmi, essere una versione di ciò che pensavo fosse "normale". Ma le mie afflizioni rendevano tutto ancora più difficile. Formavano un repertorio compatto che comprendeva infezioni simil-influenzali e raffreddori che mi facevano regolarmente tossire fino a bruciare le costole. Per un certo periodo, sono stata disseminata di sfiguranti piaghe da raffreddamento.
I medici, gli amici e persino i membri della famiglia respingevano le mie autodiagnosi, insistendo sul termine familiarmente nebuloso di "virus". Oh, è solo un virus, dicevano, sperando che questo diminuisse la mia preoccupazione. Ma questo non faceva che accendere la mia curiosità. Quale virus? Ha un nome? Posso fare il test? Perché viene a me, in modo specifico e regolare, e non a nessuno dei miei amici bianchi?
Mentre gli altri bambini costruivano fortini di cuscini, io ho sviluppato protocolli di salute - cibo, vitamine, erbe - e un sesto senso per individuare i segni di malattia. Quando il virus è arrivato, ho utilizzato il mio arsenale di pozioni e rimedi. Quando la sua forza mi prendeva alla sprovvista, mi lasciavo andare alla deriva. Temevo soprattutto le notti e raramente osavo controllare cosa ci fosse sotto il mio letto.
La condizione cronica che ho sperimentato assomigliava a una che era stata nominata molto prima della mia nascita. Nel 1952, il ventisettenne Frantz Fanon aveva appena pubblicato il suo primo libro, Pelle nera, maschere bianche, la sua controversa e rifiutata tesi di dottorato sugli effetti del razzismo sulla salute. Fanon stava facendo uno stage all'ospedale di Saint-Alban, nel sud della Francia, quando notò subito che il personale medico spesso trascurava e minimizzava le preoccupazioni dei pazienti nordafricani. A quel tempo, Marocco, Algeria e Tunisia (dove è nato mio padre) erano colonie o protettorati francesi e questi pazienti erano immigrati di prima generazione, uomini che avevano attraversato il Mediterraneo all'indomani della Seconda guerra mondiale per ricostruire la Francia metropolitana. La vita non era facile per loro. La maggior parte di loro viveva in insalubri quartieri popolari, grazie ai loro magri guadagni, e occupava il gradino più basso della società francese. Sopravvivevano con poco più di una profonda nostalgia per la casa e la famiglia che avevano lasciato. E condividevano sintomi simili di una malattia senza nome. Dalle osservazioni cliniche di Fanon - che avrebbero influenzato il suo influentissimo libro e lo avrebbero spinto a entrare nell'ospedale psichiatrico algerino di Blida-Joinville - scrisse un articolo fondamentale che esponeva un insieme comune di sintomi di quella che chiamò la "sindrome nordafricana".
I nordafricani lamentavano un dolore inafferrabile. Le loro descrizioni, secondo i medici francesi, erano inaffidabili. Sembrava che mentissero o esagerassero i loro disturbi, diventando nient'altro che un inconveniente medico. Ma Fanon si prese il tempo di ascoltare. Su basi tradizionali, il loro dolore era difficilmente spiegabile. Arrivano "avvolti nella vaghezza", scrive Fanon e, a parte rari casi, non presentano lesioni fisiche. Sentivano male "ovunque" e in nessun luogo specifico. I medici volevano fare diagnosi per somministrare correttamente le medicine, ma i pazienti si irritavano per tutte le domande, perché la loro sofferenza era proprio lì, quasi insopportabilmente evidente da descrivere. "Fa male" - ma qual è la natura di questo male?
La Francia degli anni Cinquanta si trovava a un punto di svolta. Nel 1954 esplose la guerra d'indipendenza algerina, che Fanon sostenne attivamente per il resto della sua breve vita, e l'Unione francese (che nominalmente sostituiva l'impero coloniale) perse le sue colonie nel sud-est asiatico. Alla vigilia delle indipendenze e della decolonizzazione, Fanon teorizzò che il dolore fisico sopportato dai migranti nordafricani fosse un avatar di un'alienazione profondamente radicata, una manifestazione di spersonalizzazione. Egli analizzò le loro comuni lamentele di sofferenza fisica come una "teoria della disumanità": Senza famiglia, senza amore, senza relazioni umane, senza comunione con il gruppo, il primo incontro con se stesso avverrà in modo nevrotico, in modo patologico; si sentirà svuotato, senza vita, in una lotta corporea con la morte, una morte al di qua della morte, una morte nella vita - e cosa c'è di più patetico di quest'uomo dai muscoli robusti che ci dice con voce veramente rotta: "Dottore, sto per morire"?
I lavoratori nordafricani hanno lottato per articolare il loro deficit socio-emotivo, inciso dalla violenza coloniale e dallo sradicamento. Fanon raccomandava di lavorare collettivamente sul "significato di casa" per affrontare il loro spossessamento e il loro dolore. Sfatò i pregiudizi dei suoi colleghi che spesso equiparavano queste strane afflizioni alla stupidità o alla follia. Ad esempio, la "sinistrosi" - una diagnosi inventata all'inizio del XX secolo per spiegare la presunta propensione dei lavoratori a ingigantire gli incidenti per chiedere un risarcimento - è stata poi associata in particolare ai nordafricani: le preoccupazioni mediche e politiche convergevano. Ma i nordafricani che si sono imbattuti nell'ospedale di Fanon non erano squilibrati o astuti. Erano malati perché le condizioni avverse della società francese avevano schiacciato la loro umanità.
L'articolo di Fanon mi ha portato a interrogarmi sul motivo per cui il dolore affliggeva i nordafricani francesi più di altri, se è ancora così e cosa possiamo imparare dalla misura in cui le loro condizioni socioculturali giocano un ruolo critico nella formazione e nella comprensione delle patologie. Non sono un medico come Fanon; la mia esperienza è più soggettiva che oggettivamente verificabile. Per me il dolore è allo stesso tempo visceralmente personale e universale. Ha il potenziale di farci sentire soli al mondo, ma anche di metterci in contatto con un gruppo più ampio che sta affrontando la stessa prova.
Ho incontrato questa dualità non molto tempo fa. Nel giugno del 2023, poche ore dopo che un poliziotto aveva ucciso a bruciapelo un adolescente nordafricano francese di 17 anni di nome Nahel Merzouk nella banlieue parigina di Nanterre, sono stata colpita da un dolore tale da riuscire a malapena a parlare. A differenza di altri omicidi - almeno 20 uccisi ogni anno dalla polizia francese negli ultimi dieci anni - questo è stato filmato. Nella breve registrazione, un'auto gialla viene fermata, circondata da moto della polizia e da due poliziotti a piedi. All'inizio sembra un normale controllo, se non fosse che uno dei poliziotti punta una pistola contro il conducente, Nahel, e lo avverte che sparerà. Quando l'auto inizia a muoversi, il poliziotto spara e l'auto si schianta a pochi metri di distanza. Nahel è morto. Il tentativo istituzionale di insabbiare l'incidente è stato rapidamente smentito quando il video è trapelato online. Come nordafricana francese, ho avuto un'orribile impressione di déjà vu e di dolore. A questi si è aggiunto un sentimento comune di rabbia, che ha portato alle violente proteste a livello nazionale scoppiate poco dopo l'uccisione di Nahel. Nella mia mente è sbocciato il ricordo di altri Nahel, come i giovani Zyed Benna e Bouna Traoré, morti nel 2005 mentre erano inseguiti dalla polizia in un'altra banlieue parigina, Clichy-sous-Bois. Le foto d'identità sgranate di Zyed e Bouna, che sono circolate ampiamente in televisione e sui giornali, mi sono rimaste nel cuore. Quando si tratta di ricordare, la fotografia ha il morso più profondo", scrive Susan Sontag in Regarding the Pain of Others (2003). La fotografia è come una citazione, una massima o un proverbio". Nel caso di Zyed e Bouna, le loro fotografie sono un avvertimento. Se hai questo aspetto, potresti essere in pericolo.
"Pensa che ci sia razzismo nella polizia?", ha chiesto un giornalista una settimana dopo l'omicidio di Nahel. “No, assolutamente no", ha risposto il prefetto della polizia di Parigi. Era "scioccato" dal fatto che un tale termine potesse anche solo essere suggerito. Molte istituzioni continuano a negare l'esistenza di un razzismo sistemico in Francia. Ma, come ha detto il sociologo Kaoutar Harchi in un saggio pubblicato quell'estate, le vite degli africani francesi sono state "rese uccidibili" dalla nozione stessa di essere visibilmente razzializzati. Vivere una vita da arabo, da nero, in una Francia strutturalmente razzializzata", scriveva, "significa vivere a stretto contatto con la morte".
Questa esperienza di violenza va oltre i casi isolati di brutalità della polizia. Nel 2017, l'80% dei giovani percepiti come arabi o neri ha dichiarato di essere stato fermato almeno una volta dalla polizia, contro il 16% del resto della popolazione. In francese, questa profilazione razziale è chiamata " contrôle au faciès" o "controllo facciale", denotando in modo grossolano l'importanza dell'aspetto etnico - un'altra disuguaglianza che delimita gli spazi di sicurezza per i nordafricani, subordinati alle prescrizioni bianche sul significato di sicurezza.
Quando le proteste si sono diffuse la scorsa estate, in alcuni casi sono diventate violente. Tre giorni dopo la morte di Nahel, tra l'imposizione di massa del coprifuoco, due dei maggiori sindacati di polizia hanno denunciato "orde di selvaggi", impegnandosi a combattere questi "parassiti". Seguendo il principio foucaultiano secondo cui la punizione non è un atto di giustizia, ma un atto di potere, hanno giurato di pacificare gli indigeni indisciplinati del XXI secolo e di mantenere l'ordine (l'ordine di chi?) La punizione di massa dei discendenti disordinati dei soggetti colonizzati, etnicamente predisposti alla violenza come lo erano stati i loro antenati, è diventata uno spettacolo pubblico sui canali d'informazione con opinionisti che incolpavano Nahel della sua stessa uccisione (o, se non lui, sua madre). Le peggiori tendenze razziste della Francia si sono scatenate. Le élite non solo hanno riconosciuto la differenza etnica come una verità cardinale, ma l'hanno razzializzata e politicizzata per dividere l'opinione pubblica. Come ha chiesto una volta Judith Butler: quando la vita è "addolorabile"? Solo quando la vita è intesa come vita, come vita precaria e finita. Ma le élite della società francese vedevano Nahel e quelli come lui solo come minacce, e nient'altro. Per loro, la sua non era una vita da piangere.
Anch'io sono cresciuta in una banlieue di Parigi, ma l'estate scorsa non ero in Francia. Tuttavia, ho rivisto incessantemente il video dell'uccisione di Nahel, sperando che una visione diversa mostrasse in qualche modo la colpevolezza di Nahel o forse un uso legittimo della legittima difesa da parte della polizia. Ma ogni visione confermava il contrario, scatenando un crescente risentimento per il fatto che il mio dolore non fosse più ampiamente condiviso da persone che non assomigliavano a me o a Nahel. La violenza non si verifica in modo isolato o solo nel passato, come nel 1961, alla vigilia dell'indipendenza dell'Algeria, quando la polizia massacrò 100 manifestanti e gli algerini furono spinti ad annegare nella Senna. Questi eventi, come il mio dolore cronico, sono qui e ora e sempre presenti.
Il dolore è localizzato nel corpo. In quanto tale, ci riporta alla nostra costituzione fisica, che per i nordafricani in Francia è sinonimo di identità politica. I nostri corpi sono il luogo di molteplici dimensioni sovrapposte - simboliche, reali, soggettive - che insieme operano in un terreno sociale gerarchico acquisito di recente dalle proiezioni orientaliste-coloniali. Ci viene detto che apparteniamo a terre sconosciute, intrinsecamente diverse dall'Europa, e che dobbiamo essere "civilizzati" e conquistati. Siamo oggetto di ricerche scientifiche esterne, ci viene impedito di raccontare le nostre storie - dobbiamo farci dire chi siamo dagli esperti europei.
Il dolore è "un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata o simile a quella associata a un danno tissutale reale o potenziale", secondo l'Associazione internazionale per lo studio del dolore. Il dolore deriva dalla rottura. Il corpo segnala al cervello che qualcosa non va bene e che dobbiamo prestare attenzione. Ora comprendiamo l'idea di Fanon della "sindrome nordafricana" sotto l'ampia bandiera del trauma postcoloniale. Si tratta di un campo che esamina l'interazione tra le minoranze etniche (o i gruppi non occidentali) e i fallimenti della psicologia e della psichiatria tradizionali nel rendere conto del retaggio, dell'eredità o della memoria dell'assoggettamento transgenerazionale. La disciplina cerca di definire nuove relazioni tra la personalità, l'esperienza e le ferite. Non si tratta di affermare il determinismo biologico - l'idea che i geni controllino il comportamento - o di patologizzare in qualche modo gli arabi perché sono arabi. Si tratta di riconoscere specifiche serie di esperienze ereditate e acquisite che mostrano un conflitto tra il modo in cui si è rappresentati e il modo in cui si vive tale rappresentazione, che può derivare da un retaggio storico condiviso. Tuttavia, a differenza di un approccio tradizionale al trauma o al dolore che favorisce l'articolazione di un modello basato sull'evento (una causa scatenante, una risposta), o una rigida separazione tra un prima e un dopo, il dolore postcoloniale è continuo. Il trauma postcoloniale è un "modo di vivere, uno stato permanente delle cose", scrive la studiosa e psicoanalista Jennifer Yusin.
I pazienti descritti da Fanon vivevano, o meglio sopravvivevano, in un continuo stato di alienazione, aggravato dalle loro condizioni materiali. Molti di loro entrarono nelle case operaie o vissero nelle baraccopoli fangose di Nanterre, che raggiunsero rapidamente i 10.000 abitanti e da dove centinaia di algerini favorevoli all'indipendenza si sarebbero uniti alle proteste brutalmente represse a Parigi nel 1961. Lo Stato francese spesso considerava pericolosi i quartieri abietti in cui erano ammassati i nordafricani, poiché fornivano un terreno fertile per l'attivismo politico, alimentato dall'estraneità e dalla povertà. La baraccopoli di Nanterre fu ristrutturata negli anni '70 e Nahel sarebbe stato ucciso in quella stessa città 50 anni dopo, un adolescente che viveva una vita ai margini della Francia. Come in passato, le banlieues rimangono luoghi di attivismo e di protesta perché mantengono i cittadini postcoloniali e i migranti nelle cosiddette "no-go zones".
Negli anni Cinquanta, Fanon poteva dire dei pazienti nordafricani che "hanno avuto la Francia schiacciata dentro di loro" e che, quindi, rimandare questi pazienti in Nord Africa aveva poco senso. Oggi, l'estrema destra invoca una "re-emigrazione" per epurare la Francia da questi indesiderabili. Tuttavia, nonostante i nordafricani siano in maggioranza francesi, sono ancora segnati dalla loro generazione - seconda, terza, quarta. In questo modo, la società francese dice loro che non appartengono pienamente. Nessuno definirebbe uno spagnolo di terza generazione, ma tutti sanno che "immigrati" significa arabi e africani. Mentre una generazione segna il passaggio del tempo, l'esperienza nordafricana della violenza è definita da episodi ripetitivi all'interno di un quadro più ampio di emarginazione. La violenza è un serpente che si arrotola e che soffoca in modo sempre più aggressivo.
Poiché molti nordafricani francesi sentono qualcosa di sgradevole e di anormale nel loro corpo, oggi si rivolgono a chi si occupa di salute mentale, infrangendo i tabù culturali. Stanno bene fisicamente, a parte questo strano dolore bruciante e questo malessere indefinibile, che li rende nervosi riguardo ai confini della follia e alla necessità di essere ascoltati. Nello studio di salute mentale di Fatma Bouvet de la Maisonneuve, a ovest di Parigi, si aprono sul dolore inflitto da identità contrastanti, microaggressioni e discriminazioni varie, sugli effetti di un discorso antiarabo di estrema destra in aumento nei media tradizionali e nella classe politica. Bouvet de la Maisonneuve, psichiatra e autore franco-tunisino, ha dichiarato a Le Monde nel 2019 che questi pazienti vivono con un "dolore reale che non viene compreso", essendo stati esposti alla loro sofferenza per decenni. Il tempo non ha modificato in modo sostanziale la sindrome nordafricana, un trauma postcoloniale diffuso che fatica a conciliare l'esterno e il sé.
Essere un paziente richiede di essere osservato, spogliato, auscultato, giudicato. Questo pone già una persona in una relazione asimmetrica con l'autorità medica, opponendo chi cerca e chi dà, chi non conosce e chi sa, una dinamica di potere che pone il paziente in un ruolo subordinato (a cui il nordafricano è abituato dalle circostanze della vita e dal peso della sua storia). Questo parallelo non è dissimile dalla copertura mediatica francese dei nordafricani, uno sguardo invadente che sviscera maniacalmente ogni segno di devianza che possa giustificare uno status di inferiorità, elevando sempre le notizie che convalidano i pregiudizi preesistenti. Scrivendo di una donna dell'Africa occidentale che era stata indirizzata a una clinica etnopsichiatrica fuori Parigi per un'educazione "problematica", l'antropologo e sociologo Didier Fassin ha detto: "Ogni frase che pronunciava diventava un segno che meritava di essere interpretato". Anche questo provoca dolore.
Sono l'unica figlia di una madre bianca francese e di un padre arabo tunisino. Non ho scelto il mio trattino e mi sono affidata a spiegazioni acrobatiche ogni volta che mi è stato chiesto da dove venissi veramente, una domanda posta con una frequenza sconcertante da quando ero abbastanza grande da capire cosa significasse il suo sottotesto. Non ero del tutto francese - lo sapevo dal tono di chi mi interrogava - eppure mi ci sono voluti decenni per arrivare alla risposta: Vengo da Parigi e da Tunisi, dalla Gallia e da Cartagine, dalla croce e dalla mezzaluna, dal Mar Mediterraneo e dai giardini di Monet, dal burro e dall'olio d'oliva, dal vino e dalla “citronnade”. Sono olio e aceto, vengo da un sangue che tradizionalmente non si mescola. Potrei non avere senso per voi, ma si tratta di “e” non di “o”. Contenti ora? Ma non erano né contenti né convinti. A volte queste due componenti della mia identità formano una timida unione, a volte si separano. E spesso si sentono come un fardello intrattabile che richiede continue spiegazioni, navigazioni, negoziazioni. In Francia, la distinzione tra essere francese o voler essere francese è inesorabile. O lo si è, o non lo si è - e quando non lo si è, è brutale e irrevocabile.
Sono cresciuta in Francia negli ultimi anni di François Mitterrand, nel periodo in cui la Marcia per l'uguaglianza e contro il razzismo del 1983 era stata un'esperienza deludente. Durante quella manifestazione, un turista algerino, Habib Grimzi, fu brutalmente assassinato su un treno notturno da tre francesi, proprio mentre decine di migliaia di nordafricani (e alcuni alleati) camminavano da Marsiglia a Parigi per denunciare gli abusi quotidiani e la discriminazione. Nonostante questa parvenza di presa di coscienza da parte della società, guidata da nordafricani di seconda generazione che aspiravano a una vita meno violenta di quella vissuta dai loro genitori, l'impulso al cambiamento non è durato. Di conseguenza, non c'erano molte narrazioni di speranza a cui potessi collegarmi. Nella mia cerchia, la Marcia era una barzelletta; la cooptazione politica dei suoi leader era spesso presentata come un ammonimento per i nordafricani, che dovevano rimanere accondiscendenti per avere successo (uno "yes-man" chiamato béni-oui-oui, un termine dell'epoca coloniale esportato dall'Algeria).
Non appartenevo alle storie e ai miti nazionali francesi, nonostante fossi nato francese da genitori francesi. Ero macchiato di incompletezza, il mio nome era esotico e non avevo nessuno a cui ispirarmi. Non conoscevo altre "metà" come me, né sapevo che una bussola potesse puntare non solo verso il nord o il sud del Mar Mediterraneo - quel fastidioso confine di civiltà - ma anche verso un centro intermedio. In assenza di modelli di riferimento, ho dovuto spiegare da sola sensazioni che mi sembravano reali e intimidatorie. Mi guardavo e mi trovavo in disaccordo con i ragazzi bianchi francesi che mi circondavano, faticando a fare amicizia con il "virus" che mi assaliva. Sentivo di occupare troppo spazio, di essere troppo visibile con i miei tratti arabi, mentre la mia umanità non era abbastanza visibile. Molte volte ho desiderato semplicemente scomparire.
La Tunisia era una terra misteriosa che avevo visto fin da giovane attraverso una lente coloniale: arretrata, povera, violenta, degenerata. Mio padre (non è forse partito lui stesso per una possibilità migliore?) non mi ha mai detto molto fino alla nostra prima visita insieme alla fine degli anni Novanta, che mi ha lasciato in uno stato di shock culturale e ancora più confuso sul perché questo altro luogo dovesse far parte della mia esistenza. In ogni caso, a casa non abbiamo mai parlato arabo, una lingua che non ho ancora imparato. La mia lingua madre è il francese; vivo il dolore in francese. La Francia è "schiacciata dentro di me".
Per anni ho combattuto una guerra contro me stessa, finché la mia sindrome non si è apparentemente attenuata come un prurito. I miei genitori mi hanno mandato in una scuola privata dove ero l'unica bambina nordafricana della mia classe e ci si aspettava che non fossi un’araba di una banlieue parigina. Sfilai con la mia simbolica maschera bianca e compiacqui le persone, compreso me stessa, fino a estraniarmi. Ma, poco dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, mi sono resa conto di appartenere a un gruppo subalterno immutabile, incolpato di tutto, e di non poter mai essere abbastanza brava, abbastanza intelligente, abbastanza in forma, abbastanza amichevole - abbastanza umana - per questi osservatori.
In quell'odioso discorso pubblico modellato sulla distinzione di Noi e Loro, sono diventata ancora una volta Loro. Per una volta non mi sono sentita sola, anche se ciò ha comportato l'alienante consapevolezza che il mio posto era in basso, fuori, lontano. È stato allora che ho iniziato a leggere Fanon e ho capito che il mio dolore era reale. Le sue parole mi hanno confortato e ho iniziato a desiderare nuovi legami. La diffusa emarginazione e discriminazione nei confronti degli arabi e dei musulmani in quel periodo ha fatto sì che iniziassi a pensare politicamente ai miei antenati, e a me attraverso di loro. Sono diventata consapevole di vivere storicamente e ho imparato che il dolore racchiude una parabola somatica della complicata vita dei nordafricani in Francia. È una parabola infinita.
Farah Abdessamad è una saggista e critica franco-tunisina. Vive a New York
Articolo pubblicato su Aeon
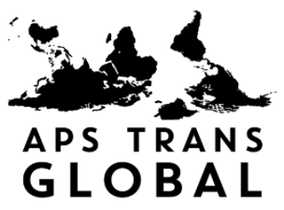
Scrivi commento