Stefano Rota e Mariapiera Pepe su "Il lavoro culturale"
Laurie Taylor, giornalista della BBC e ideatore del programma radiofonico “Thinking allowed”, ha intervistato nel marzo 2011 Stuart Hall, una delle personalità del mondo accademico di maggior rilievo del secolo scorso.
L’intervista, riproposta nel febbraio 2014 (una settimana dopo la morte di Hall), riesce a mettere in evidenza i tratti salienti del pensiero del sociologo giamaicano, pur nella parziale, e comunque sempre gradevole, leggerezza che un’intervista radiofonica necessariamente comporta, attraverso una chiara illustrazione dei temi su cui Hall ha maggiormente insistito nei suoi cinquant’anni di intensa attività e senza mai perdere di vista la stringente attualità.

Cofondatore con Hoggart e Williams del Birmingham Centre for Contemporary Cultural studies nel 1964 e di cui ne divenne il direttore nel 1968 sostituendo lo stesso Hoggart, Hall ha dato un contributo fondamentale, con un forte impianto innovativo, allo sviluppo dei Cultural Studies. I temi su cui ha maggiormente insistito il lavoro di Hall, già molto ben descritti su queste pagine da Serena Guarracino, vertono sull’articolato rapporto tra cultura e potere nella società contemporanea. Attraverso un’attenta innovazione degli schemi interpretativi dell’ortodossia marxista e l’utilizzazione in chiave post-strutturalista del pensiero, tra gli altri, di Gramsci, Deridda e Foucault, Hall ridefinisce ruoli, funzioni, valori, tecniche, pratiche, attraverso cui ripensare epistemologicamente quel rapporto, sempre in evoluzione, come vuole la sua impostazione anti-essenzialista di lettura dei fatti e dei soggetti sociali.
Collocandosi, naturalmente e “ideologicamente” (questo termine viene messo tra virgolette e usato con molta cautela, essendo l’ideologia uno dei temi su cui Hall ha molto insistito), nel produttivo filone degli intellettuali della diaspora, il contributo di Hall su argomenti quali “razza”, “multiculturalismo”, “identità” – e molti altri, ovviamente - ha certamente segnato un turning point imprescindibile per chi si occupa, a vario titolo, di migrazioni, composizione e ricomposizione delle società contemporanee, razzismo e antirazzismo, conflitti culturali, rivendicazioni identitarie e valoriali.
Il pensiero di Stuart Hall, ripresentato recentemente in un volume curato da Miguel Mellino e recensito da Serena Guarracino nell’articolo sopra citato - a cui si vuole aggiungere qui un’altra raccolta di suoi scritti: Politiche del quotidiano. Culture, identità e senso comune, a cura di Giovanni Leghissa, per i tipi de Il Saggiatore (2006) - trova nell’intervista che segue una piacevole sintesi, grazie anche all’abilità e competenza del giornalista nel dialogare con un intellettuale radicale (qualità rare, dalle nostre parti, come dimostrano alcune recenti “recensioni” all’autobiografia di Toni Negri, Storia di un comunista).
Come lo stesso Taylor premette nell’introdurre l’intervista, l’incontro avviene in un momento in cui Hall è già provato dal male che lo condurrà al decesso tre anni dopo. A causa di ciò, ma senza per questo nascondere i limiti di chi ha realizzato la traduzione, l’intervista presenta alcuni punti di difficile interpretazione. Quello che ne consegue, anche a causa della sua lunghezza, è una trascrizione parziale della stessa (una versione più ampia si trova nel pdf allegato). A tal fine, si riporta in chiusura il link all’audio originale (sr).
Laurie Taylor (LT): Stuart Hall è un accademico, fondatore e direttore, dopo Hoggart, del Birmingham Centre for the Contemporary Cultural Studies. Ho esordito chiedendogli di rievocare le origini del suo percorso intellettuale, il suo arrivo a Bristol nel 1951 su una “banana boat” dalla Giamaica, la sua terra natale.
Stuart Hall (SH): Mi ricordo del mio arrivo in treno a Londra. Pensai “Conosco tutti questi maledetti alberi!”. Sa, non li avevo mai visti prima, il che la dice lunga sul sistema scolastico coloniale. È stato tanto tempo fa. Questo significa che non sono un suddito post-coloniale, una frase oggi ricorrente. Sono coloniale, così come mi sono formato nell’infanzia, e sono venuto esibendo un passaporto britannico, come soggetto britannico.
LT: Ok, abbiamo questo tema del multiculturalismo: è improvvisamente tornato a far notizia. Il Primo Ministro ha pronunciato un discorso in occasione della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza. Parlando della minaccia del terrorismo coltivato in casa, ha dichiarato che questi giovani uomini trovano difficile identificarsi con l’Inghilterra perché abbiamo consentito l’indebolimento della nostra identità collettiva. In nome del multiculturalismo di Stato – ha proseguito – abbiamo incoraggiato le diverse culture a condurre vite separate rispetto a quella della cultura dominante. Ecco, riconosce quell’espressione, “multiculturalismo di Stato”?
SH: La riconosco. Credo che quello a cui si riferiva il Primo Ministro fosse la politica così come adottata dal nostro governo per promuovere la conoscenza e comprensione tra i diversi gruppi che vivono in Inghilterra. Una tale politica è stata sicuramente trasformata dall’emergere del fondamentalismo islamico. Credo che quando le persone si rifanno al termine “multiculturalismo” ciò che intendono è di evidenziare il problema molto complesso che risiede nel rimanere fedeli a sé stessi e alle tradizioni che si vogliono preservare e, al contempo, compiere quel grande passo che è l’adattarsi ad un altro Paese ed un’altra cultura. E’ in atto un cambiamento multiculturale, definizione con la quale non mi riferisco ad un multiculturalismo ispirato o finanziato dallo Stato ma a quei cambiamenti sociali che avvengono molto lentamente, gradualmente e dappertutto. Pensi soltanto, ad esempio, alla visibilità delle persone di pelle nera nei media, nello sport, nella cultura pubblica o nella vita di strada. Questo cambiamento nella loro visibilità si è prodotto negli ultimi cinquant’anni. C’è stata una svolta verso – cosa esattamente? – la tolleranza, l’accettazione, l’identificazione positiva. Questo cambiamento multiculturale non si è concluso, sebbene il signor Cameron pensi che abbiamo bisogno di un liberismo “con i muscoli”. Dio ci aiuti. Ritengo che il multiculturalismo come multiculturalismo di Stato sia un fenomeno relativamente recente. Soltanto adesso, con I finanziamenti del governo affinché le comunità musulmane non permettano ai propri giovani di radicalizzarsi, si è raggiunto un tipo di investimento più profondo, un inedito tentativo di pianificare ciò che accade in quelle comunità. Non abbiamo mai visto niente di simile in passato: abbiamo visto la polizia gestire quello che accade nelle loro aree di residenza, ma mai una simile forma di penetrazione interna.
LT: Quindi, si potrebbe dire che, dopo gli anni Cinquanta, con l’arrivo di nuovi gruppi, i governi ha impostato la loro azione su una forma di laissez faire, che ha consentito alle persone di sviluppare le proprie comunità e identità collettive. Quando il fondamentalismo islamico emerge, all’improvviso questo diventa l’incentivo per dire “Siamo stati troppo compiacenti, adesso dobbiamo intervenire attivamente per porre fine a tutto questo”.
SH: Credo che abbia identificato le due estremità dello spettro. Tuttavia, c’è stato un lungo periodo tra queste due estremità durante il quale le persone esprimevano preoccupazione e pensavano “Queste persone non appartengono alla nostra cultura, non la comprendono, non vi s’identificano, s’identificano in qualcos’altro. Causano problemi e hanno cambiato il volto delle nostre città”. Questo è quel periodo intermedio che chiamo “cambiamento multiculturale” e credo che il cambiamento sia avvenuto anche all’interno di queste comunità. So, ad esempio, che fino a non molto tempo fa, chiedendo ad un Pakistano quale fosse la sua identità, la risposta sarebbe stata la sua nazione d’appartenenza e non la sua religione. Dunque, l’emergere della religione come un collante che attiva l’identificazione – sia questa positiva o negativa, pericolosa o pacifica – rappresenta un fenomeno relativamente recente.
LT: Quindi ritiene che, considerando ciò che sta accadendo in termini di radicalizzazione, l’islamizzazione sia un movimento politico?
SH: Sì. Credo si tratti di re-identificazione da parte della nuova generazione. Adesso stanno tornando alla religione dei loro genitori con maggior fervore. E, sicuramente, la forma di islamizzazione nel Medio Oriente ed altre regioni ha assunto un carattere politicamente molto più connotato.
LT: Cosa ne pensa dei tentativi che sono stati effettuati per affermare una qualche forma d’identità collettiva britannica? Gordon Brown, ad esempio, era solito parlare d’identità nazionale. Si è discusso d’introdurre il giorno di San Giorgio. Una serie di tentativi top-down per permettere alle persone di dire che sono britanniche e fiere di esserlo. Lei è completamente cinico di fronte a queste iniziative?
SH: No, non direi che sono cinico, ma comprendo le motivazioni di queste iniziative, per chiarire la sua domanda. Le comprendo perché penso siano collegate alla questione del “Chi siamo noi? Chi siete voi? In cosa credete? Cosa ritenete importante?”. È una questione particolarmente complessa in tutte le società imperiali che hanno dovuto rinunciare alla gestione di tanti sudditi dall’altra parte del globo e si è ritrovata a domandarsi: “E ora cosa resta di noi?” Dunque non mi stupisce che l’identità sia diventata una questione politica ma sono alquanto sconfortato – lo so, è ironico – rispetto alle forme che questa assume. Il giorno di San Giorgio, ma s’immagina? Abbiamo feste di qualunque tipo e tutti fanno shopping la domenica, quindi mi sembra abbastanza ridicolo. Allo stesso tempo, però, la globalizzazione ha fortemente accentuato il declino dello Stato nazione e della cultura nazionale, due concetti che camminano mano nella mano.
Dunque, la domanda “A cosa siamo legati?”, soprattutto per una società che ha costruito la sua storia in modo da suggerire che questo è un popolo speciale, i padroni della creazione, emersi dal Mar del Nord già tolleranti, liberali, dalla mente aperta e votati alla libertà, e così via, quest’orrenda distorsione della nostra storia nazionale che si sta verificando adesso e che riguarda l’insegnamento di una versione secondo la quale siamo emersi dal mare già civilizzati. Credo che niente di tutto questo sia divertente. È una preoccupazione difficile e pericolosa. Quel tipo di preoccupazione che Paul Gilroy ha definito “malinconia”, una sorta di lutto per un oggetto che è perduto. Ed è un lutto inconsolabile perché ciò che è perso non tornerà e, soprattutto, non in quella stessa forma.
LT: Ma lei vede una specie di rinascita di tutto questo? Intendo dire, l’altro giorno sono andato a vedere “The King’s speech” e ci sono stati degli applausi alla fine da parte di tutto il pubblico. Sembra che ci sia una ripresa del senso di identità nazionale, fondata sulla famiglia reale, che può ancora suscitare un sentimento comune. Lei vede questo con una forma di ironia?
SH: No, non la vedo affatto con ironia. Credo che lei non stia dicendo niente di diverso da quanto io stesso sto dicendo. Intendo dire che, l’altra faccia della globalizzazione è l’internazionalizzazione della cultura, dei modelli, della letteratura, della musica. Le persone vogliono ancora sapere: “sono radicato da qualche parte, in qualcosa, credo in qualcosa? Sono differente dalla gente dall’altra parte della Manica (si sa che gli inglesi sono molto bravi nel definire in cosa siano differenti dai francesi)? Nonostante tutto ciò, io sono ancora molto differente da loro.” Questo li precipita nella ricerca in qualche luogo dove ‘collocarsi’.
Adesso, la domanda è: come trovi qualche posto dove stare. E ci si immagina che questo sia destinato a essere lo stesso di quello che era in passato. Questo è problema, questo è l’elemento pericoloso. Tutto è destinato a tornare: i valori britannici, i valori familiari, la bandiera. Tutto ritorna.
Ma questo non è assolutamente l’investimento britannico nella globalizzazione. La signora Thatcher è stata dopo tutto una pioniera di quello che chiamiamo nuovo liberalismo. Ma chi è profondamente attaccato alla bandiera, all’esercito, ecc.? Queste cose sono scomparse e la contraddizione che impongono va avanti da molti anni.
LT: Mi sembra che una delle cose di cui lei ha scritto e parlato in modo critico rispetto al New Labour e Blair sia il modo in cui certi termini come “comunità” sono stati buttati lì e ha utilizzato l’espressione “evacuazione di significati”. Lo metto insieme alla nozione di Cameron di “big society”: Blair parlava di comunità e Cameron di big society. Cosa sta accadendo?
SH: Credo che il New Labour è riuscito a mettere insieme l’idea neoliberale di destra, con cui era profondamente coinvolto (lo stesso Gorgon Brown aveva dimostrato di essere fortemente vincolato al neoliberismo), con i suoi elementi costituenti, la sua tradizione e impegni, unificandoli. Quindi, se si guarda alla politica del Labour, certamente vi sono aspetti positivi e progressisti, il salario minimo e altro. Avendo quindi due repertori, il problema è quale dei due era dominante: io penso che fosse quello dell’economia neoliberale, l’economia di mercato verso una società di mercato. Ora, è necessario aggiungere un’interpretazione a un contesto di questo genere: come si fa a fare cose di sinistra se la parola che usi è la stessa per fare le cose di destra? E’ una questione di strategia politica generale, ma il linguaggio e l’ideologia sono totalmente critici a questo riguardo. Pensiamo all’uso privo di significato che si fa del termine “correttezza”. Viene usato da chiunque: ministri, portavoce, in qualunque occasione. Bene, sa cosa significa “corretto”? Significa che, utilizzando un rapido esempio, tassiamo i ricchi e i poveri nello stesso modo. Non è “corretto” questo? Certo, a parte il fatto che lascia i ricchi ricchi e i poveri poveri e la struttura al cui interno la correttezza viene esercitata appare come un dato di fatto. Non ci sono dubbi al riguardo, ma è necessario provare a fare qualcosa dal punto di vista tattico in mezzo a tutto questo.
LT: Guardando ai recenti sviluppi [del marzo 2011] della situazione in Libia, Tunisia ed Egitto, cosa pensa il suo amico Edward Said avrebbe detto riguardo alla reazione dell’Occidente di fronte a quegli eventi?
SH: Non posso rispondere per Edward. Ciò nonostante Said è sempre stato quello che si definisce “counter punctualist”: ciò significa che se si intende la musica barocca come un insieme composto da due melodie, se ne riesce a cogliere solo una. Le due melodie suonano sempre in contrapposizione una all’altra, senza che nessuna delle due abbia il sopravvento; a volte suonano insieme, ma la cosa interessante è che suonano una in opposizione all’altra. Quindi credo che Said direbbe: non sappiamo qual è la tendenza dominante in questo momento. Non siamo in grado di leggerla precisamente, ma possiamo solo tenerci il più aperti possibile verso le forze che portano quelle società in una direzione generale che pensiamo sia giusta per il popolo. Niente più di questo.
Le dico cosa penso io, però. Io non sopporto le ciniche risposte da vecchia sinistra: i militari hanno preso il potere e questo gli è stato concesso. L’Occidente è occupato a mandare là elicotteri, aspettando solo il momento di potersi assicurare le riserve di petrolio. La storia non funziona in base a cospirazioni. Non si viene giudicati solo in base al risultato finale di un processo. Quello che accade lungo il percorso verso la conclusione ha sempre un impatto, lascia sempre dietro di sé un segno. Le cose non sono mai esattamente come erano prima. Il Medio Oriente è stato sempre una fonte di enorme instabilità geopolitica per venti o trent’anni. Ma essendo divenuta la crisi palestinese uno dei punti più rigidi dell’instabilità politica a livello mondiale, quella fonte non può essere rimossa. Anche il solo realizzarsi di una moderata riforma democratica, o un aumento della libertà di parola, sarebbero comunque sufficienti per rappresentare un cambiamento della storia.
Come si sa, molti dicono: “nel 1968 gli studenti, alleatisi con i lavoratori e supportati dai partiti comunisti, non hanno vinto, non hanno preso il potere; hanno provato a prenderlo, ma di fatto non è successo niente”. Non è assolutamente vero! Moltissime cose sono cambiate da allora, la vita dal 1968 in poi è stata profondamente trasformata. Non si ritornerà mai indietro a cosa era prima di allora. L’idea del collettivo, del femminismo, ecc.: ogni tipo di lavoro teorico è stato trasformato dall’impatto di una rivoluzione che non ha avuto successo. Se guardiamo al XIX secolo, 1848 rappresenta esattamente la stessa cosa.
Quindi, io non ritengo opportuno giudicare il significato degli eventi storici e del loro dispiegarsi, nei termini dati dal nostro abituale giudizio sul modo in cui quegli stessi eventi possono terminare.
Intervista integrale: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00zfkfn
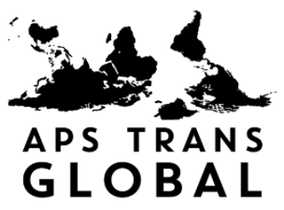
Scrivi commento