Fabrice Olivier Dubosc
Nel 2014 si è tenuto a Rio un ciclo di conferenze dal titolo “Os mil nomes de Gáia – Do antropoceno á Idade da Terra” (I mille nomi di Gaia – Dall’Antropocene all’età della Terra), organizzato da Eduardo Viveiro de Castro.
Questo mio contributo è il tentativo di “tradurre” il bell’intervento svolto in quell’occasione da Patrice Maniglier, un filosofo di scuola francese molto interessato alla svolta verso un’antropologia ‘cromatica’ e trasformativa (ma altrettanto si potrebbe fare per Donna Haraway, Bruno, Latour, Isabelle Stengers, Viveiros de Castro, Dipash Charabarty per citare solo i più noti partecipanti). L’interesse di Maniglier deriva da una passione filosofica per il pensiero della variabilità e della trasformazione. Un suo aforisma dice che “compito dell’epistemologia è fare della variazione una procedura di verità”. L’antropologia come sistema intrinsecamente comparativo permetterebbe allora l’accesso a un’idea inedita di trasformazione. L’antropologia si costituirebbe come dispositivo di “traduzione” - con tutti i possibili malintesi ed equivoci che da ciò può derivare – un dispositivo che tuttavia modifica lo statuto stesso dell’operazione antropologica.
L’idea emergente è che i popoli indigeni conoscano l’arte di costruire concetti quanto noi. Si tratterebbe di ri-concepire il ‘pensiero selvaggio’ come costruzione concettuale e come una semiotica immaginativa e non come mero riflesso di significanti strutturali inconsapevolmente volti all’ omeostasi delle ‘società fredde.’ Levi-Strauss tutto sommato o almeno inizialmente pensava che pur risultando in una sorta di conservazione dell’equilibrio il rapporto con l’ambiente delle società indigene era il risultato di una “struttura” inconscia di significazione di un funzionamento più che di un ritmo del pensiero. Pensarlo come tale muta non solo i nostri concetti ma lo stesso nostro concetto di concetto. E questa nuova ecologia delle idee ha ripercussioni importanti anche per la coscienza ecologica.
La dimensione mitica del pensiero indigeno porta infatti viva in sé la possibilità dell’equilibrio ma a partire da un’idea della metamorfosi, della trasformazione e del conflitto, in cui la diversità delle forme e delle nature sottende una medesima “tensione a essere” che include un essere vivi (e un doversi nutrire alle spese di altri che pure proprio come noi si devono nutrire), la necessità di una capacità rappresentativa sufficiente per farlo e una comune finitudine. In altre parole la possibilità dell’equilibrio deriva dal riconoscimento delle diverse prospettive e soggettività significanti in tutto ciò che è vivente.
E questo potenziale di variabilità, la ricchezza di “versioni del Sé” che le “traduzioni” rivelano, fa dell’alterità condivisa una sorta di fondamento relazionale in un senso che amplia le intuizioni della psicoanalisi. La relazione tra differenze implica negoziazione tra simmetrie e asimmetrie, modalità di relazione, malintesi, trasformazioni. Il pluralismo è complesso: vi sono più modi di connettere cose eterogenee nella loro stessa eterogeneità.
Se l’Altro è una forma costitutiva del Sé, allora essere significa potersi «situare in un insieme di alternative a sé stessi». Tale ecologia delle idee e delle relazioni presuppone che il Reale pre-individuale, che include tutte le forme viventi, non sia sottrazione ma eccesso, una dimensione polifasica metastabile suscettibile di trasformazioni e individuazione, un contnuum comune da cui si differenziano forme naturali molto diverse di cui si ricorda sempre ciò che hanno in comune.
Ora, secondo Maniglier, l’intrusione di Gaia di cui parlano Stengers e Latour - Gaia non come madre buona ma come deriva problematica - ci spinge a esplorare la crisi della modernità a partire dalla prospettiva dell’antropologia comparativa e permette di meglio pensare come tale intrusione, lo scontento di Gaia, faccia da ostacolo alla narrazione evolutiva e universalista che si trova frenata nella sua stessa immaginazione lineare. Gaia è inoltre un ibrido negativo – non una sorta di mitica rivolta di una Madre Terra integra ed indignata, perché la Gaia che si ribella è già una natura umanizzata, “trasformata”, ibridata dall’agire umano. Un esempio classico è come gli antibiotici abbiano contribuito a sviluppare super-batteri resistenti contro i quali non esiste cura.
Per Latour la chiave dell’intrusione è che Gaia interrompe la descrizione che i moderni fanno di sé, la logica che sottende a una certa versione della ‘storia’. Non è più possibile credere a una versione meccanicamente evolutiva della storia; anzi, saltano molte delle partizioni con cui consideriamo uomo/mondo, cultura/natura, economia politica/geologia. Gaia esprimerebbe dunque una sorta di ibrido negativo – non è la natura in sé che si ribella alla tecnica, ma la natura ‘umanizzata,’ modificata dalla tecnica che in molti casi fa problema. Anche l’attuale enfasi sulle differenze escludenti (identitarie, “razziali”, “culturali”) è probabilmente sintomo della sfida e difficoltà contemporanea a pensare l’ecologia delle idee e dei mondi e la negoziazione tra cosmopolitiche (Stengers). Nelle “ecologie degli altri” il cosmo è sempre presente, mentre nella nostra dimensione immaginativa è prevalentemente un oggetto di speculazione scientifica, appassionante per gli specialisti, ma prevalentemente freddo, distante, disanimato o minaccioso per la maggior parte delle persone.
Maniglier preferisce Gaia (con i suoi mille nomi) al termine Antropocene – che come è noto indicherebbe il fattore cruciale dell’impatto umano nella presente era geo-climatologica. Ma la nozione di Antropocene presuppone che esista qualcosa come un “Anthropos” cioè un’umanità collettivamente responsabile – mentre solo una piccola parte dell’umanità ha generato l’attuale impatto critico sull’ambiente – Alcuni dei termini coniati in alternativa a Antropocene sono infatti Eurocene, Anglocene, Capitalocene...
Effettivamente il termine Antropocene ha un’aura coloniale perché dire che l’Anthropos, la summa collettiva dell’umano, la specie insomma, sia responsabile della catastrofe socio-ambientale significa sostenere che un segmento tutto sommato esiguo della specie ne costituisca l’essenza, in modo analogo a come nel colonialismo l’uomo bianco e la sua ‘cultura’ si consideravano rappresentazioni per eccellenza dell’umano. Forse l’Anthropos – o la specie come sostiene Chakrabarty - non esiste ancora, può emergere solo da un’antropologia comparata (e dalle differenti negoziazioni cosmopolitiche che lo scarto tra narrazioni e miti mette in gioco).
La domanda allora sarebbe: Chi può rispondere a Gaia? Chi è l’Anthropos? Se è vero che non esiste una umanità indifferenziata che avrebbe inscritto il suo effetto globale sulla superficie della terra, c’è forse un problema rispetto all’umanità da costruire che sarebbe in grado di tener conto del carattere globale del problema.
Ciò che effettivamente caratterizza l’antropologia (come disciplina comparativa) è che si sviluppa a partire dallo scacco dell’estensione di una categoria etnocentrica (per esempio: economia, religione, scienza, uomo, terra) alle categorie altrui. L’antropologia è stata costretta a ridefinire i termini a un tempo riduttivi e universalizzanti con cui interpretava queste categorie nel suo percorso e ad accogliere gradualmente nelle sue “traduzioni” i nomi e le semiotiche altrui. Questo lavoro di traduzione ha trasformato la stessa antropologia. Maniglier sostiene seguendo forse i contributi di Roy Wagner (“l’invenzione della cultura”) e di Marylin Strathern (“il genere del dono”) che l’antropologia comparata è costretta a utilizzare gli equivoci della traduzione per ridefinire i termini in gioco a partire dalla loro posizione nel malinteso stesso. Ciò che accade nel disvelamento parziale dell’equivoco iniziale (che è la croce dell’indagine etnografica) modifica i concetti con cui ci si accosta all’alterità. Il malinteso è infatti tale nella misura in cui nello scambio diventa possibile capire che non intendiamo bene. Il malinteso opera allora come una sorta di denso prisma che permette di riconoscere quantomeno nella diffrazione le diverse lunghezza d’onda dello spettro di colori. Oggi i mille nomi di Gaia sono la nuova frontiera di questo processo.
Lo dice molto chiaramente Peter Skafish nella sua introduzione all’edizione inglese di Metafisiche Cannibali: «la quantità da capogiro di prospettive sul sé comporta che l'altro abbia effettivamente priorità ontologica e la soggettivazione richiede che ci si faccia carico - come insegnano lo sciamanesimo e altre forme di traslazione/traduzione - della sua prospettiva.»
Si tratta dunque di esigere che l’Anthropos – l’umano - si ridefinisca a partire dal modo con cui possiamo pensarlo, cioè a partire dai molteplici malintesi di traduzione che ne costituiscono le varianti. Non esiste una storia dell’Antropocene senza una antropologia che “rimetta i moderni al loro posto” dice Latour. In altre parole la prospettiva della modernità torna ad essere una tra le tante prospettive provinciali. Siamo anche “noi” altri tra gli altri.
E questi altri non sono solo gli umani. Edouardo Kohn, l’antropologo che ha scritto “How forests think” rilegge così il mito greco in cui la Sfinge, un entità transumana che sembra intersecare più dimensioni inclusa quella animale, interroga Edipo con il famoso indovinello su quale sia l’animale che ha quattro, due e poi tre zampe. Ciò è sempre stato interpretato come un’interrogazione sullo statuto dell’umano. (Infanzia, età adulta, vecchiaia). Accogliendo le suggestioni amerindiane, questo ‘umano’ che la Sfinge interroga può essere pensato come ulteriormente inclusivo dell’animale e della sua prospettiva, quella a quattro zampe, così come dei ‘dispositivi’ - gli strumenti, i ‘bastoni’ cioè la terza gamba, le invenzioni a cui l’umano (e a quanto pare sovente anche gli animali) hanno modo di appoggiarsi.
Ci basterebbe riconoscere, conclude Maniglier nel suo intervento di Rio, che la crisi riguarda più esseri di quelli che siamo soliti includere nel “noi” – che un soggetto globale è un “noi “che è più del “noi” che conosciamo già! In questo senso la specie umana – o l’Anthropos - non è la causa dell’Antropocene ma potrebbe esserne il risultato.
Se Gaia si presta a essere male intesa Gaia non consente che il malinteso resti tale: anche il cielo e l’aria (e non solo concetti come democrazia, economia, cultura) hanno bisogno di tornare a noi trasformati dopo i malintesi generati dalla loro traduzione. Basta leggere la caduta del Cielo dello sciamano Yanomami Davi Kopenawa per capire quanto abbiamo in realtà da guadagnare nel tradurre la sensibilità indigena di relazione con l’ambiente che per noi è diventata nel migliore dei casi prevalentemente concettuale.
Provo a dare un esempio di questo processo riprendendo ancora quanto Scrive Kopenawa:
«Omama è al centro di ciò che i bianchi chiamano ecologia. E’ vero! Molto prima che queste parole esistessero e che i bianchi cominciassero a parlarne tanto, erano già nostre anche se non le nominavamo allo stesso modo [...] Nella foresta, noi esseri umani siamo l’”ecologia”. Ma anche gli xapiri (spiriti), la selvaggina, gli alberi, i fiumi, i pesci, il cielo, la pioggia, il vento e il sole... I bianchi che un tempo ignoravano tutte queste cose iniziano ad ascoltarle [e] ora chiamano se stessi “popolo dell’ecologia”».
Col commento di Peter Skafish:
«Considerare il pensiero Amerindiano in termini di concetti non solo cambia i nostri concetti, ma lo stesso concetto di concetto; il concetto entra nell’orbita del mito e della sua capacità di effettuare la trasformazione non solo di altri miti ma di altro materiale discorsivo [...] per questo motivo abbiamo iniziato a vedere attraverso occhi come quelli di Kopenawa che “i tapiri, i pecari, i macachi che cacciamo nella foresta un tempo erano umani” e “che è per questo che oggi apparteniamo tuttora a una medesima specie.” E’ anche il motivo per cui, capendo che questo mito trasforma per forza i nostri concetti, noi che siamo diventati recentemente “popolo dell’ecologia” faremmo bene a elaborare un altra comprensione, panpsichica, transpecifica, metamorfica della prospettiva ‘umana’»
Maniglier conclude il suo intervento dicendo che se le parole in gioco si prestano a equivoci non si tratta di decostruire proiezioni concettuali; l’invito alla traducibilità è qualcosa di più, e sta nella nostra possibilità di fare di noi stessi un cammino di variabilità e trasformazione, un cammino di traduzione da contesto a contesto. E’ così che forse iniziamo a immaginare a una diversa forma di relazionalità tra le idee e gli ambienti. Bisognerebbe infatti pensare a un ambiente, a un contesto, a un ecosistema come a una lingua, e sappiamo che è impossibile pensare una lingua senza compararla a un’ altra.
La variabilità è dunque effettivamente condizione di qualcosa che non sappiamo ancora definire ma che ci avvicina a una diversa comprensione dei fenomeni sociali quanto di quelli naturali.
Concludo con questa bella citazione di Vivieros de Castro in “Metafisiche Cannibali”:
«Contro le grandi dicotomie, un’antropologia minore farebbe proliferare le piccole molteplicità, - non il narcisismo delle piccole differenze ma l’anti-narcisismo delle variazioni continue; contro gli umanesimi fatti-e-finiti, un umanesimo interminabile che costantemente sfidi la costituzione dell’umanità in un ordine separato. Lo sottolineo ancora: una tale antropologia farebbe proliferare le molteplicità. Perché la questione, come ha colto Derrida (2008), non è di predicare l’abolizione delle frontiere che uniscono/separano segno e mondo, persone e cose, “noi” e “loro”, “umani“ e “non-umani” . Riduzionismi facili e monismi assimilativi sono fuori luogo quanto le fantasie fusionali - la questione è piuttosto come rifiutare sia la tentazione riduttiva quanto quella di fissare le definizioni (Latour) piegando invece ogni linea di divisione sino a farne una curva infinitamente complessa. Non si tratta di cancellare i contorni ma di piegarli e addensarli, esercitando una sorta di diffrazione sino a renderli iridescenti. Come scrissero Deleuze e Guattari “miriamo a un cromatismo generalizzato” (D. G. 1987). Il cromatismo sarà il vocabolario strutturalista con cui verrà scritta la nostra agenda per i posteri.»
Se questa nuova epistemologia mira a fare della variazione una “procedura di verità”, Gaia ci invita a rendere ancora più urgente il compito di immaginare l’altro e persino la possibilità di coglierne la prospettiva diversa, per certi versi o per un tempo a trasformarsi nell’altro (se la possibilità della trasformazione è principio intrinseco alla vita stessa). Ma trasformarsi nell’altro (con tutti i fantasmi di divorazione che ciò comporta) non è incompatibile con l’essere accanto all’altro. E’ in questa visione frattalica e cromatica che credo si collochi la possibilità di pensare in modo ampio i mille nomi di Gaia e le sfide politiche al pensiero, alle pratiche e alle eredità che continueranno a interpellarci nei prossimi decenni di transizione.
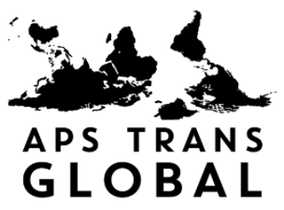
Scrivi commento