Sandro Mezzadra
Il 28 novembre, mentre si approvava alla Camera la conversione in legge del “Decreto immigrazione e sicurezza”, Matteo Salvini ha chiuso la polemica che da qualche giorno sembrava attraversare lo stesso governo sul “Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration”. L’Italia, contrariamente alle precedenti dichiarazioni tanto di Conte quanto del Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, non parteciperà alla Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre, dove l’accordo verrà firmato. Sguaiatamente si esulta da destra per lo scampato pericolo di un’“invasione di proporzioni mai viste”, mentre da parte del PD e di LEU si attacca il governo per il suo crescente isolamento internazionale e qualcuno arriva perfino a chiamare “accordo sull’accoglienza” il documento elaborato sulla base della cosiddetta “Dichiarazione di New York” adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2016.
Non si tratta qui di scendere nel merito della polemica politica italiana, contestando in particolare le assurdità che sul “Global Compact” sono state dette da destra. Mi pare più interessante domandarsi che cosa ci dice in termini più generali sulla congiuntura che stiamo attraversando il nesso tra le nuove misure contenute nel Decreto Salvini e la mancata firma dell’accordo promosso dalle Nazioni Unite. Andrà infatti pur detto che l’isolamento internazionale del governo italiano è quantomeno relativo, considerato che tra i Paesi che non firmeranno l’accordo figurano gli Stati Uniti, l’Australia, l’Austria e l’intero blocco di Visegrad. Più correttamente, si deve parlare di un attacco concertato al multilateralismo e allo stesso sistema delle Nazioni Unite, secondo una logica che ha caratterizzato fin dal suo principio la presidenza Trump (con un salto di qualità rispetto allo stesso unilateralismo di Bush Jr. nei primi anni del secolo). Il “ritorno alla sovranità” e il “primato nazionale” non potevano che trovare attorno ai temi delle migrazioni (e conseguentemente del controllo dei confini) un terreno privilegiato di manifestazione. E il “Global Compact” si presentava per molti versi come un bersaglio ideale, sia per la storia della sua gestazione e redazione sia per il linguaggio che impiega.
Per quanto il suo antecedente più immediato sia la “Dichiarazione di New York” poc’anzi menzionata (nonché l’“Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile” del 2015), l’idea di un “accordo” o di un “regime” globale sulle migrazioni ha una storia più lunga, che in qualche modo coincide con quella dei dibattiti sulla global governance che presero avvio nella cornice dell’ONU all’indomani della caduta del muro di Berlino. Proprio in quella cornice fu infatti formulata nel 1993 la categoria di migration management, che ha rappresentato negli anni successivi il riferimento essenziale per il dibattito e per le sperimentazioni pratiche che hanno preparato il “Global Compact”. Un ruolo essenziale di promozione e coordinamento di queste iniziative, a cui hanno partecipato singoli governi, agenzie transnazionali, centri di ricerca, attori economici e organizzazioni non governative, è stato svolto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: quest’ultima, divenuta nel 2016 un’“agenzia collegata” della Nazioni Unite, funzionerà come segreteria operativa della “rete ONU sulle migrazioni” prevista nel testo del “Global Compact” per monitorarne l’applicazione e gli effetti nei prossimi anni.
Molto si è scritto sul migration management e sulla stessa idea di un “regime globale” di gestione delle migrazioni. Nell’insieme si può dire che attorno a queste categorie si è lavorato per definire schemi di reclutamento dei migranti improntati a una essenziale flessibilità, considerata necessaria tanto per i cambiamenti strutturali del mercato del lavoro nei Paesi “recettori” quanto per intercettare e valorizzare le caratteristiche sempre più turbolente e imprevedibili degli stessi movimenti migratori. Migrazione temporanea, migrazione circolare, schemi di reclutamento legati alle esigenze dei singoli settori economici sono alcuni degli strumenti essenziali del migration management, ampiamente utilizzati in Europa e altrove nel mondo quantomeno fino alla grande crisi del 2007/8. E alla flessibilizzazione delle politiche migratori corrispondevano proposte di riorganizzazione in una chiave altrettanto flessibile dei dispositivi di controllo dei confini: senza che mai venisse messa in discussione la competenza sovrana degli Stati in materia, si puntava tuttavia a coinvolgere un insieme di attori non soltanto statuali, secondo una logica multilaterale e a geometria variabile caratteristica dell’insieme di queste politiche e di queste retoriche.
Il “Global Compact” che verrà discusso alla Conferenza di Marrakech si pone in una linea di sostanziale continuità con questi sviluppi nel tentativo di delineare – in modo “non vincolante” – una cornice e un insieme di standard che possano orientare un processo di convergenza delle politiche migratorie a livello globale. Il “quinto obiettivo” del testo è particolarmente significativo in questo senso: insiste infatti sulla necessità di predisporre una molteplicità di differenti canali d’accesso legali e flessibili sulla base delle esigenze “demografiche e del mercato del lavoro”. Numerosi sono i riferimenti al “capitale umano” di cui sono portatori i migranti, nonché all’esigenza di promuovere un’analisi di quel capitale umano in termini di skills e “impiegabilità” nei diversi contesti. Altrettanto presente nel testo dell’accordo, effettivamente pervaso dalla convinzione che le migrazioni siano un elemento strutturale che si tratta di rendere produttivo, è l’insistenza sulla necessità di consolidare quadri giuridici, garanze e diritti per i migranti, con particolare attenzione alle dimensioni di genere e alla lotta contro “razzismo, xenofobia e intolleranza”.
Vi sono molti altri aspetti del “Global Compact” che andrebbero discussi – a partire ad esempio dalla questione delle “rimesse”, dei rapporti dei migranti con il sistema bancario e con le istituzioni finanziarie, nonché più in generale del rapporto tra migrazioni e sviluppo (mentre va ricordato che alla condizione dei rifugiati è riservato un altro accordo). Ma vorrei per il momento fermarmi a questi tre elementi: 1. Il riconoscimento del carattere strutturale delle migrazioni; 2. La proposta di un insieme di strumenti flessibili per renderle produttive, in ultima istanza secondo la logica neoliberale del “capitale umano”; 3. L’enfasi sui diritti dei e delle migranti. Non sarebbe difficile articolare una critica di questo discorso e di questo progetto: lo abbiamo fatto in molti negli scorsi anni, ponendo in particolare in evidenza il carattere selettivo e duramente gerarchico del migration management, il suo entrare necessariamente in collisione con l’universalità dei diritti e il suo rapporto con la persistente violenza dei dispositivi di controllo dei confini. Mi pare tuttavia importante sottolineare, nel momento in cui contro il “Global Compact” si schierano i nazionalismi e si invoca la sovranità, che i tre punti sopra indicati configurano nei fatti un progetto realistico di governo capitalistico delle migrazioni a livello globale – e in qualche modo un progetto “riformistico” di normalizzazione delle migrazioni.
Uso il termine normalizzazione pensando al modo in cui, in un capitolo famoso del Capitale, Marx parla della definizione di una “giornata lavorativa normale” come esito dello scontro tra la lotta operaia per la riduzione dell’orario di lavoro e il progressivo emergere di un interesse capitalistico generale a riorganizzare su quella “misura media” lo sfruttamento e l’accumulazione. In qualche modo si può leggere tra le righe del “Global Compact” la ricca trama di lotte e di rivendicazioni che i movimenti dei e delle migranti hanno intessuto a livello globale negli ultimi anni. E il riconoscimento di queste lotte e di queste rivendicazioni sul terreno dei diritti si accompagna alla definizione di parametri e standard che definiscono appunto una “misura media” per la valorizzazione del lavoro e della vita dei e delle migranti (puntando a escludere uno “sfruttamento” definito nel testo in termini esclusivamente giuridici). Si tratta di parametri e standard non vincolanti, è bene ripeterlo, che delineano una tendenza, stabilendo un insieme di garanzie e limiti ben più fragili ed elusivi della “barriera sociale potentissima” rappresentata secondo Marx dalla legge sui limiti della giornata lavorativa. E tuttavia quella tendenza indica almeno potenzialmente un campo di lotta e un terreno più avanzato su cui strappare conquiste e costruire una politica espansiva.
Il rifiuto del “Global compact” assume in questo senso un valore sintomatico, che mi pare ben lungi dal limitarsi al solo ambito delle politiche migratorie. Il salto in avanti nella criminalizzazione della migrazione, anticipato con la chiusura dei porti alle navi delle ONG quest’estate, si coniuga ora non casualmente, con la conversione in legge del Decreto Salvini, con l’attacco a forme di lotta come il blocco stradale e l’occupazione di edifici che sono state praticate in particolare dai e dalle migranti negli ultimi anni in Italia ma rientrano evidentemente nel repertorio di ogni movimento sociale. E non è certo di una tendenza soltanto italiana che stiamo parlando: la negazione della possibilità stessa di riconoscimento e mediazione sembra caratterizzare nella congiuntura attuale ogni politica che faccia dell’invocazione della sovranità nazionale il proprio baricentro. Ancora una volta non casualmente, accanto ai migranti sono le donne a subire nel modo più violento l’attacco, nel momento in cui rifiutano di piegarsi all’ordine patriarcale: per restare all’Italia, la coincidenza tra il disegno di legge Pillon e il Decreto Salvini assume anch’essa valore sintomatico.
Si potrà dire che quanto si è qui discusso dimostra una volta di più che il capitalismo contemporaneo, come abbiamo spesso sostenuto, è strutturalmente ostile a ogni ipotesi di “riformismo”. È in qualche modo così, se assumiamo come riferimenti le esperienze storiche di riformismo operaio e capitalistico. Ma la ricostruzione di un tessuto di mediazioni, per quanto affidato essenzialmente al mercato e all’azione del capitale finanziario, è pur stato elemento caratteristico della “globalizzazione” quantomeno fino alla crisi del 2007/2008 – che è stata anche (se non soprattutto, retrospettivamente) crisi di quel tessuto di mediazioni. Come mostra l’esempio delle migrazioni, tuttavia, il “ritorno alla sovranità” (per quanto un’infinità di combinazioni tra sovranità nazionale e neoliberalismo sia possibile) si pone potenzialmente in contraddizione con gli interessi quantomeno di alcune componenti essenziali del capitale contemporaneo. E lo stesso vale per la politica dei dazi e per la “guerra commerciale”.
Non si tratta evidentemente di invocare una presunta “razionalità” capitalistica e di attendere fiduciosi (o di agire in qualche modo per) un qualche “adeguamento” a essa delle politiche globali. Davvero non è questo il punto! Occorre piuttosto cominciare a domandarsi come possono svilupparsi le lotte, che tipo di politica della liberazione è necessario costruire in una congiuntura segnata dalla violenta riduzione dei margini di riconoscimento e di mediazione. E occorre certamente indagare l’insieme delle contraddizioni che rendono fragile l’assetto di questa congiuntura – nonostante le retoriche “maschie” e sicure di sé che pretendono di rappresentarla egemonicamente. Il formidabile movimento transnazionale femminista costituisce senz’altro una base essenziale da questo punto di vista, così come l’insieme delle pratiche e delle rivendicazioni con cui, in modo sempre più determinato e politicamente articolato, uomini e donne migranti sfidano i confini, a Tijuana come nel Mediterraneo, e si battono per conquistare spazi di libertà in Italia così come in molte altre parti del mondo.
Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Euronomade
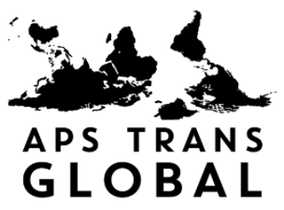
Scrivi commento