di Eliane Brum
Voglio cominciare ricordando dove siamo.
Voglio ricordare che siamo nel centro del mondo. Non è una frase retorica, non è neppure il tentativo di costruire una frase a effetto. Nel momento in cui il pianeta vive il collasso climatico, la foresta amazonica sta davvero al centro del mondo. Se non comprendiamo questo, non c’è modo di affrontare la sfida del clima.
Questa è la ragione che ci porta a collocare i nostri corpi qui, in questa città, Manaus, capitale di Amazonia, stato del Brasile, il paese che ospita circa il 60% dell’Amazonia. Manaus è tanto una foresta in rovina, quanto le rovine di un’idea di paese. Manaus può essere vista come una scultura viva di un conflitto iniziato nel 1500, con l’invasione europea che ha causato la morte di centinaia di migliaia di uomini e donne indigeni/e e l’estinzione di decine di popoli. In questo momento, nel 2019, stiamo testimoniando l’inizio di un nuovo disastroso capitolo.
Il Brasile è un grande costruttore di rovine. Il Brasile costruisce rovine in dimensione continentale da quando venne inventato dagli europei nel 16° secolo. In questo momento, una forma di vita predatrice chiamata bolsonarismo ha assunto il potere quasi totale e totalitario nel Brasile. Il principale progetto del “bolsonarismo” è quindi costruire rovine con metodo e velocemente nella foresta amazonica. E’ questa la ragione per cui, per la prima volta, a partire dalla ri-democratizzazione del paese, abbiamo un ministro contro l’ambiente. Nessun ministro dell’ambiente degli ultimi trenta anni e oltre ha avuto l’autonomia che ha dimostrato di avere Ricardo Salles, il ministro contro l’ambiente. Lui è l’”office-boy” dell’agro business predatore, quello che è responsabile per la maggior parte di morti sul campo e nella foresta, oltre a essere la maggior forza distruttrice del Brasile. Non è che oggi i “ruralisti” stanno al governo; vi sono da sempre, formalmente o no. Oggi loro sono il governo.
Il principale progetto di poter del bolsonarismo consiste in convertire le terre pubbliche che servono a tutti, nella misura in cui garantiscono la conservazione dei bioma naturali e la vita dei popoli originari, in terre private per il profitto di pochi. Queste terre, la maggior parte delle quali si trovana nella foresta amazonica, sono le terre pubbliche di usufrutto dei popoli indigeni, le terre pubbliche occupate dai “ribeirinhos” (popolazione che vive di pesca, raccolta di lattice, castagne e altri prodotti della foresta da oltre un secolo), e le terre di uso collettivo dei “quilombolas” (discendenti degli schiavi ribelli che conquistarono il proprio diritto ai territori occupati dagli antenati).
Le dispute tra i vari gruppi che occupano il governo sono costanti, anche perché il governo Bolsonaro ha come strategia la simulazione dell’opposizione a se stesso, occupando in questo modo ogni spazio. L’apertura delle terre protette dei popoli indigeni, così come delle aree di conservazione, si basano, però, sul consenso generale. La trasformazione della maggior foresta tropicale del pianeta in bovini, soia e attività di estrazione mineraria non produce nessun tipo di litigio. Alcune delle voci leggermente dissonanti sono già state espulse dal governo.
Il bolsonarismo va molto oltre la creatura che gli dà il nome. Anzi, in un certo senso, il bolsonarismo può addirittura prescindere da Jair Bolsonaro. Il bolsonarismo, collegato intimamente alla crisi globale della democrazia, sta influenzando tutta la regione amazonica, facendo sì che figure che si sono mantenute nell'ombra per anni, o decenni, stiano oggi emergendo in altri paesi dell’America Latina, dove, allo stesso modo, si sta decidendo il destino della maggiore foresta tropicale del mondo. Il bolsonarismo, è importante ripeterlo, non è una minaccia solo per il Brasile, ma per l’intero pianeta, proprio perché distrugge la foresta strategica per il controllo del riscaldamento globale.
Come resistere, quindi, a questa enorme forza distruttiva, a questa forza distruttiva legalizzata?
Per essere capaci di resistere abbiamo bisogno di diventare noi stessi foresta – e resistere come foresta. Come foresta che sa di portare con sé le rovine, che porta con sé sia quello che c’è, sia quello che non c’è più. Mi sembra che sia questo sentimento politico-affettivo a cui abbiamo bisogno di dare forma, per dare senso alla nostra azione. Per questo dobbiamo spostare alcune placche tettoniche del nostro pensiero. Dobbiamo decolonizzare noi stessi.
Il fatto che l’Amazonia sia vista come un luogo lontano e anche – o principalmente – come una zona periferica dà la portata della stupidità della cultura occidentale bianca, di origine europea e successivamente nordamericana; una stupidità che costituisce a dà forma alle elite politiche e economiche del mondo e quindi anche del Brasile. In parte, anche alle elite intellettuali del Brasile e del pianeta. Credere che l’Amazonia sia lontana e periferica, quando la possibilità di controllo del riscaldamento globale è possibile a partire solo dalla foresta viva, è ignoranza di proporzioni continentali. La foresta è il “prossimo più prossimo” che ognuno di noi qui ha. Il fatto che in molti di noi ci si senta lontani anche se ora siamo qui, mostra quanto il nostro sguardo sia contaminato, formattato e distorto. Colonizzato.
Giorni fa, chiacchieravo con procuratori e difensori d’ufficio che erano arrivati da poco in città delle zone interne dell’Amazonia. Era il loro primo incarico. Questa è la logica. L’Amazonia è l’epicentro dei conflitti, ma, per le fiscalizzazioni statali e difendere i diritti dei più vulnerabili, le istituzioni mandano quelli senza nessuna esperienza. Alcuni di loro – non tutti - interpretano questo come una prova o una punizione, un calvario da cui devono passare prima di avere un incarico “decente”. Alcuni di loro – non tutti – non vedono l’ora di ottenere quella che viene chiamata “rimozione” e lasciarsi questo bad trip alle spalle. Non è colpa loro, perché è questa la logica delle istituzioni, lo sguardo sull’Amazonia. Per fortuna, alcuni di loro capiscono l’importanza del proprio ruolo, imparano, capiscono, rimangono e diventano servitori pubblici [in portoghese, come anche in inglese, questo termine indica i dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali (sr)] essenziali per la lotta per i diritti in regioni dove i diritti valgono poco o niente.
Gli ho ricordato che erano, così come sono io stessa, dei privilegiati. Stavano esattamente nel centro del mondo. Erano nel luogo migliore possibile per chi ha scelto quella professione, ma dovevano sforzarsi molto per superare la propria ignoranza, così come io mi sforzo tutti i giorni per superare la mia. Sono le popolazioni locali, i popoli della foresta che dovrebbero avere l’infinita pazienza di spiegare a loro quello che hanno bisogno di sapere, dato che non sanno praticamente niente quando arrivano. Lo stesso principio vale per giornalisti ed esperti.
Se ci riuniamo qui credendo che siamo speciali per il fatto di preoccuparci della foresta, non abbiamo capito niente. Se noi ci percepiamo - noi giornalisti, studiosi, noi bianchi, al di là del colore della pelle - come quelli che lasciano i confort delle proprie case e città “sviluppate” e verosimilmente con più opzioni di svago e cultura, per solidarizzare con i popoli della foresta, non abbiamo capito niente lo stesso. Se c’è una verità, sta nelle rovine. L’unica verità sono le rovine.
Per più di vent'anni, mi sono spostata in diverse regioni dell’Amazonia, per tornare quindi a Porto Alegre prima, e São Paulo dopo, dove vivevo. Nel 2017 mi sono trasferita ad Altamira [comune dello stato di Parà, dove si trova anche la diga di Belo Monte, località che ha il numero più alto di assassinii politico-ambientali (sr)], per non essere più “inviata speciale” in Amazonia, per cambiare il punto di vista a partire dal quale guardavo il Brasile e il pianeta ed essere quindi coerente con la convinzione che la foresta è il centro del mondo.
All'arrivo, ebbi difficoltà a trovare casa. Alcune di quelle che mi piacevano appartenevano a “grileiros” [truffatori che si impossessano di terra, producendo documenti falsi (sr)] e/o a mandanti per crimini contro i popoli della foresta e piccoli agricoltori. Perché qui, nel centro del mondo, la relazione è diretta. Non è che a São Paulo i proprietari di case, appartamenti, hotel e condomini siano più “pulitini”, è solo che la catena tra il crimine e la punta è più lunga e ha più intermediari.
Nelle grandi città del Brasile e del mondo siamo lontani dalle morti, delle quali i nostri piccoli atti quotidiani si fanno complici; abbiamo il privilegio di non essere obbligati a chiederci l’origine dei vestiti che indossiamo o del cibo che mangiamo. Qui, nell’Amazonia, se mangi carne di manzo, hai la certezza che è carne di disboscamento. Se compri legname, sai che non esiste (quasi) legname del tutto legale in Brasile. Se compri un tavolo o un armadio, li guardi e pensi che molto probabilmente sono stati fatti con legno strappato dalle terre indigene o da una riserva estrattivista. Qui, nel centro del mondo, la relazione con la morte della foresta e dei popoli della foresta, così come dell’agricoltura familiare, è diretta. Non gli si fugge. Possiamo vivere solo portandoci dietro – coscientemente – tanto le nostre contraddizioni quanto le nostre rovine.
Per questo dobbiamo affrontare anche la contraddizione di stare qui, finanziati in questo evento da risorse norvegesi. La Norvegia sostiene anche il Fondo Amazonia, oggi sotto attacco da parte del governo Bolsonaro. La continuità del Fondo Amazonia, principale finanziatore della protezione della foresta, è essenziale per bloccare, anche solo in forma minima, la distruzione accelerata del bioma. Questo dato, però, non ci assolve dalla necessità di riflettere sul fatto che il Rainforest Journalism Fund è finanziato, in larga parte, con soldi provenienti dal petrolio, dato che la Norvegia è il maggiore produttore di petrolio europeo. La Norvegia ha ancora un ruolo nei fronti della distruzione dell’Amazonia, come l’impresa Hydro Alunorte, che ha contaminato i fiumi di Barcarena, nel Parà. Dobbiamo andare avanti, affrontando tutte queste contraddizioni – e non scappare dalle stesse, ed esigere migliori pratiche e più coerenza dalla Norvegia.
Con percorsi differenti, penso che siamo qui, e non solo quelli che vengono da fuori, ma anche quelli che si sono già collocati geograficamente in questo territorio, perché sappiamo che la nostra vita dipende da questo, anche se ancora non rappresenta un sentimento – o anche un pensiero – che tutti possano nominare. Non siamo qui per aiutare i popoli della foresta, raccontando là fuori quello che accade qui, ma siamo qui per chiedere – umilmente – a loro se ci accettano al loro fianco nella lotta.
Siamo noi che abbiamo bisogno di aiuto da parte dei popoli della foresta. Loro hanno la conoscenza di come si vive, nonostante le rovine. Loro hanno l’esperienza di come resistere alle grandi forze della distruzione. Al fine di avere qualche chance di produrre un movimento di resistenza, dobbiamo comprendere che, in questa lotta, noi non siamo i protagonisti.
Senza comprendere il nostro luogo in questa lotta ed essere disposti a dividere un po’ del potere che abbiamo, o addirittura cedere questo potere, credo che sarà molto difficile produrre un movimento reale. Adesso siamo noi che abbiamo bisogno di smettere di occupare, lasciare che il nostro corpo sia influenzato da altre esperienze di essere e di stare in questo pianeta. Non come una violenza, com'è stata la colonizzazione dell’Amazonia e dei suoi popoli, quella che è in corso ancora oggi, e con un processo sempre più accelerato. Questa volta come scambio, miscuglio, relazione amorosa, come sesso consenziente.
Riprendo qui un discorso del filosofo Peter Pál Pelbart, che fa questa brillante sintesi: “Forse la sfida consiste nell’abbandonare la dialettica del Sé e dell’Altro, dell’Identità e dell’Alterità, e recuperare la logica della Molteplicità. Non si tratta più solo del mio diritto a essere differente dall’Altro o del diritto dell’Altro a essere differente da me, mantenendo quindi tra di noi una opposizione. Non si tratta neppure di una relazione di pacificata coesistenza tra di noi, in cui ognuno è legato alla propria identità come un cagnolino al palo, e quindi in essa incastonato. Si tratta di qualcosa di più radicale, in questi incontri: si tratta di includere e assumere tratti dell’altro, fino a differire da se stessi, a volte, scollarsi da sé, distaccarsi dalla propria identità e costruire una sua inusitata deriva”.
Durante molto tempo, noi, giornalisti, esperti bianchi occidentali - e quando mi riferisco ai bianchi occidentali, mi riferisco a qualcosa che va molto al di là del colore della pelle, mi riferisco a un modo di pensare e di abitare questo mondo – abbiamo usato i popoli della foresta appena come fonte per il nostro lavoro. Esperti di tutte le aree, inclusa l’area dell’umano, hanno costruito la propria carriera a partire dalla conoscenza del popolo della foresta, citandolo nei propri lavori accademici solo come “fonte”, le volte che li citavano.
Nonostante questa pratica sia ancora largamente in voga nella produzione scientifica, in molti hanno iniziato a capire che adesso non è più eticamente possibile farlo. I popoli della foresta hanno bisogno di essere riconosciuti, come minimo, in quanto co-autori. Gli intellettuali, così come gli esperti, non si trovano solo nell’accademia. Entrambi stanno anche – e molto – nella foresta.
Ciò è quello che molti intellettuali indigeni dicono al mondo intero in questo momento. In Brasile, l’opera più significativa di co-autorialità tra un intellettuale accademico e un intellettuale della foresta è La Caduta del Cielo, risultato di un prodotto collettivo effettivo, reale, basato sul mutuo rispetto e apprendimento, tra Davi Kopenawa, intellettuale yanomami, e Bruce Albert, antropologo francese.
Forse il dibattito più importante di cui abbiamo bisogno nel giornalismo è come questa sfida etica e anche estetica possa tradursi in produzione giornalistica in questa fase cruciale. Come collaborare con i popoli della foresta, per invade e occupare il giornalismo, a partire dalle loro specifiche esperienze – e non lasciarsi solo formattare dal nostro modello di stampa. Si tratta, mi sembra, non solo di una occupazione di spazi, con indigeni, “ribeirinhos” e “quilombolas” a fare giornalismo. Deve essere una trasformazione dello spazio, del modo stesso di fare giornalismo.
Uno dei modi per cominciare questo movimento all'interno del Rain Forest Journalism Fund è stimolare la co-autorialità per i servizi sul campo, perché la maniera più efficace di occupare gli spazi di potere è … occupare gli spazi di potere. Ancora: dobbiamo accettare questa sfida non perché siamo cool o per nostra concessione o favore – e neppure perché è solo più corretto agire in questo modo – ma perché abbiamo molto bisogno di imparare e perché possiamo insegnare. Abbiamo bisogno di inventarci in un modo nuovo se vogliamo avere una chance nell'affrontare questo momento in cui la specie umana è diventata essa stessa la catastrofe che temeva.
Bolsonaro non è soltanto una minaccia per l’Amazonia. E’ una minaccia per il pianeta, proprio perché è una minaccia per l’Amazonia. Di fronte a questa forza accelerata di distruzione che è il bolsonarismo, noi, di qualunque nazionalità, dobbiamo fare come gli africani schiavizzati che si ribellarono contro l’oppressore. Ci dobbiamo “aquilombar” [diventare quilombolas, cioè i discendenti degli schiavi fuggiti nella foresta (sr)]. Siccome non sappiamo come farlo, dobbiamo avere l’umiltà di imparare da chi sa.
La parte migliore – e più potente – del Brasile attuale e dell’Amazonia, in tutte le regioni, è rappresentato dalle periferie che rivendicano il centro. La nostra migliore opportunità è aggiungerci alle forze del vero centro del mondo, dove la disputa per il futuro è bloccata, a volte con le pallottole.
E’ a questo movimento che noi, giornalisti ed esperti, dobbiamo umilmente prestare il nostro servizio. Spero che i popoli della foresta possano, dopo tutto quello che abbiamo fatto contro i loro corpi, accettarci al loro finaco nella lotta.
*Discorso della giornalista, scrittrice e documentarista Eliane Brum, membro del Comitato fondatore, consultivo e di controllo del Rainforest Journalism Fund, che finanzia servizi in Amazonia e altre foreste tropicali, in partenariato con il Centro Pulitzer. Il discorso è stato tenuto il 12 giugno 2019 a Manaus (Amazonia-Brasile).
L’articolo è stato pubblicato originariamente in portoghese su El Pais Brasil il 10.08.2019: A Amazônia é o centro do mundo.
Traduzione dal portoghese di Stefano Rota
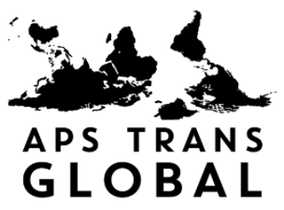
Scrivi commento