
“We are here because you were there”. Soggettività migrante e mercato del lavoro tra condizione postcoloniale e “cittadinanze postmigratorie”.
Stefano Rota – Transglobal
Innanzi tutto desidero rivolgere un sentito ringraziamento al prof. Boerchi per avermi coinvolto in questa importante iniziativa.
Vorrei iniziare presentando in modo molto sintetico il rapporto coestensivo tra migrazioni e postcolonialismo. A tale rapporto si riferisce il titolo di questo mia relazione che, come sempre accade quando le intelligenze, le sensibilità, le potenze vitali vogliono esprimersi in modo immediato e direi anche performativo, sintetizza in modo perfetto decenni di studi e ricerche. Si tratta di una scritta che lessi su un muro di Brixton, a Londra, verso la metà degli anni Ottanta: “We are here because you were there”.
Il colonialismo, ci dicono gli studiosi che si occupano del tema[1], non può essere interpretato semplicemente come un periodo che si colloca storicamente in una data epoca, quindi da relegare nel passato[2]. Il colonialismo, nel modo in cui si è articolato a livello globale per almeno due secoli e mezzo, segna in modo indelebile i modelli politici, economici, culturali che descrivono il nostro presente.
Ecco allora che il prefisso “post” messo davanti a “colonialismo” non ne indica il superamento, ma la sua riproduzione, la sua attualizzazione in forme, valori, culture, politiche che descrivono il globo non più suddiviso in zone rigidamente definite (il primo mondo, il terzo mondo, le metropoli avanzate, le zone rurali arretrate), ma secondo striature, sovrapposizioni, contiguità tra aree, soggetti, economie, tempi che tagliano trasversalmente l’intero pianeta[3].
Queste partizioni e frammentazioni vanno di pari passo con la proliferazione di confini fisici, immateriali, culturali, professionali, corporali, facendone l’ambito attorno a cui si costruisce il paradigma della contemporaneità[4]. Si tratta di confini mobili – anche nel caso di quelli territoriali – che definiscono la strutturazione delle principali forme di organizzazione della vita: le possibilità di movimento, le condizioni abitative, le organizzazioni produttive, i sistemi educativi, le opportunità di cura, gli spazi di socializzazione, di culto. In una frase, definiscono la forma costituente della cittadinanza[5]. Analizzarne le gradazioni[6] dal punto di osservazione della mobilità del confine consente di cogliere uno dei tratti salienti della condizione postcoloniale del nostro presente. A differenza della cittadinanza nel periodo coloniale, connotata da una chiara staticità strutturale[7], la cittadinanza europea attuale è portatrice di una mobilità condizionata. Non si nasce e si muore in uno status; si nasce e si muore all’interno di forme variabili di assoggettamento che agiscono non sulla vita, ma al livello della vita, al cui interno si attuano modalità di soggettivazione che contemplano risposte e agganci diversi, producendo conseguentemente soggettività differenti.
È nelle differenze, nelle diverse risposte che vengono date a quelle interpellazioni che si colloca, secondo me, lo spazio e la dimensione esistenziale – e quindi politica - della cittadinanza postmigratoria. Come già in precedenza, il prefisso “post” non sta a indicare l’oltre, ma la riproduzione di una condizione – in questo caso quella di migrante – che si ripresenta attualizzata nei cambiamenti intercorsi, ma mantenendo inalterati alcuni suoi tratti “emergenti”[8]. Ne risulta una modalità di essere, o di esserci, che, anche a distanza di decenni dall’evento migratorio e con figli nati e cresciuti nel nuovo contesto, connota il soggetto migrante (ovviamente non stiamo parlando della totalità di questi) con un sentire, una percezione di sé, che lo tiene vincolato a quell’evento[9]. Va ricordato che gli studi sui “figli delle migrazioni” mettono in evidenza più che la scomparsa di questo sentire nelle nuove generazioni, la sua trasformazione in svariate direzioni[10].
Negli stralci di tre interviste che presento, realizzate a Roma nel 2015-2017 a cittadini italiani originari del Bangladesh[11] e del Pakistan, vengono descritte situazioni riconducibili, a mio parere, all’ambito che coniuga cittadinanza postmigratoria e soggettività[12].
Inizio con un breve brano di un’intervista a Ejaz Ahmad, cittadino italiano di origine pakistana: “Il problema della doppia identità si trasforma, col passare degli anni, in una doppia estraneità: cominci a diventare straniero anche al tuo paese e continui a esserlo dove vivi. L’essere straniero assume il valore di una terza identità. […] Dopo il 7 gennaio [del 2015, data dell’assalto alla sede di Charlie Hebdo] hanno espulso due ragazzi pakistani, tutti e due di seconda generazione. Erano attratti da quest’idea dello stato islamico, perché non si sentivano appartenenti a niente e a nessuno, come accade a molte seconde generazioni.”[13]
Ejaz delinea in modo chiaro il passaggio dalla doppia appartenenza a quella della doppia assenza, o doppia estraneità, problematizzando il concetto di identità. Tra le cosiddette “seconde generazioni” il senso di alterità che si palesa può risultare addirittura amplificato rispetto ai genitori. L’evento migratorio che li ha generati continua a lavorare nei processi di costituzione della loro soggettività, magistralmente descritti dal giovane regista romano Phaim Bhuiyam nel suo film “Bangla”, ma già anticipati in alcune sue “schegge” degli anni precedenti[14].
Passando ai cittadini di origine bangladese:
Nazim: “Sono in Italia da oltre vent’anni, ho due figli nati qui e due mesi fa ho perso il lavoro. […] Ho deciso di mandare la mia famiglia al paese e di andare a cercare lavoro da solo in un altro paese. Non so ancora quale, ma sto pensando alla Polonia. Lì c’è lavoro: ti pagano 800 euro. Già tanti stanno andando in Polonia dal Bangladesh. Anche da Roma sono partite ultimamente otto persone. […] Gli ultimi tempi avevo una funzione di supervisore come elettricista. Gli italiani e i rumeni non volevano avere un supervisore straniero. Gli ho detto che ero italiano anch’io, ma niente. Forse anche per questo ho perso il lavoro. Non voglio che i miei figli vivano una situazione simile”.
Dice Nazim: Lì c’è lavoro, ti pagano 800 euro al mese. Non viene fatta menzione del tipo di lavoro, le condizioni, l’orario, ma solamente del valore che ha la propria vita migratoria, sulla base delle esigenze primarie che Nazim ha. Subito dopo, conferma come la sua vita stessa sia attraversata da un confine, quello che lo colloca, formalmente, tra i cittadini italiani, ma che lo lascia tra gli “stranieri” sul posto di lavoro.
Hanif: “Sto pensando di andare a Londra. Ci sono già almeno una settantina di amici miei là. Mi chiamano sempre per dirmi di andare. Mi chiedono cosa faccio ancora qui, in Italia, senza lavoro e con due figli da mantenere. Il tempo di sistemare la famiglia qui con dei familiari e mi trasferisco io da solo, almeno per il momento. Appena trovo un lavoro, li faccio venire tutti a Londra. I miei figli sono nati in Italia e sono italiani (anch’io ho la cittadinanza italiana), ma cosa possono fare qui in futuro? A Londra se studiano possono andare a lavorare in una società, un ufficio. Qui, anche se studiano, vanno a fare i lavapiatti o lavorano in un negozio”.
Parlando del futuro dei propri figli, è come se Hanif dicesse: ‘Quello che io oggi sono, è quello che saranno domani i miei figli, il modo in cui io sono oggi “parlato”, è lo stesso in cui saranno “parlati” domani i miei figli’. Non è importante stabilire se questo sia vero, se corrisponde alla ‘realtà’: è importante il processo di veridizione che vi sta alla base, perché è su questo che si fonda l’ontologia dell’essere migrante, del cittadino “postmigratorio”.
Quanto presentato finora mi consente di giungere al concetto di inclusione differenziale[15], un concetto centrale nella lettura di alcuni aspetti del rapporto tra migranti e mercato del lavoro. L’inclusione differenziale sta a indicare una modalità di inclusione che ri-produce una differenza, o forse sarebbe meglio dire che moltiplica una differenza, fino a farne la condizione d’esistenza dell’essere migrante, ma estendibile anche ad ambiti ben più ampi[16].
Quello che si intende dire è che l’inclusione differenziale non nega l’accesso ad alcuni ambiti, ma lo consente in forma, appunto, differenziata; problematizza la distinzione stessa tra dentro e fuori. La mobilità e la porosità dei confini consentono di mettere in evidenza una pluralità di modi di entrare e stare dentro. L’inclusione differenziale, in sintesi, produce una moltiplicazione di inclusioni minori.
Vorrei, su questa base, interrogare alcuni dati sulle previsioni di assunzioni di lavoratori “immigrati” in Liguria dal 2017 al 2019 contenute nell’indagine Excelsior.[17] Per ciascun profilo viene indicato il numero di assunzioni previste totali e quello per le quali si prevede una difficoltà di reperimento[18]. Ciò che accade nel triennio può essere così sintetizzato: la domanda di lavoro straniero si espande orizzontalmente e cresce verticalmente, ma resta in larga parte concentrata in pochi profili professionali[19].
Ciò che mi interessa di più mettere in evidenza è però relativo alla difficoltà di reperimento.
Nel triennio, quindi, la domanda totale di lavoro straniero aumenta (+11%), ma parallelamente e in modo più che proporzionale aumenta la quota di lavoratori per i quali si prevede una difficoltà di reperimento (+29%), soprattutto allontanandosi dai profili dove si concentra il maggior numero di lavoratori non di origine italiana. Nel 2019, oltre un quarto del totale di lavoro straniero che si vorrebbe assumere risulta difficile da reperire.
Cosa significa che la domanda di ‘panettieri e pastai artigianali’, ‘addetti all’accoglienza e informazione’, ‘meccanici’, ‘conduttori di mezzi pesanti e camion’, e altre decine di profili resta in larghissima parte, quando non totalmente, disattesa? Provo a dare una mia parziale interpretazione, riprendendo quanto ho espresso sopra riguardo all’inclusione differenziale e aggiungendo alcuni spunti di riflessione che credo possano risultare di qualche utilità.
Ci sono molti enti di diversa natura che, interagendo tra loro, contribuiscono a definire i processi di inclusione nel mercato del lavoro, non immediatamente riconducibili alla logica binaria oppositiva domanda-offerta[20]. Questa pluralità di enti – di cui una parte è nel paese d’origine, un’altra nel paese di destinazione e una terza che potremmo definire transnazionale - produce una concatenazione di logiche d’azione e di funzionamento[21], un sistema di cui gli individui stessi sono parte attiva. Ciò che intendo dire è che il cittadino che migra non viene involontariamente e inconsciamente assoggettato a quel sistema. Gli individui, al contrario, producono all’interno di quelle relazioni un’auto-affezione, o, per dirla in altri termini, producono “in modo circolare il proprio riferimento”[22], in qualità di soggetti sociali.
È a partire da qui che vorrei riprendere i dati esposti sopra sul mercato del lavoro in Liguria, cercando di porli in relazione con quanto appena sostenuto.
Ciò che fa di un migrante “naturalmente” un aiuto cuoco in un ristorante, un addetto alla vendita in un negozio o una badante[23] è un processo complesso e articolato, anche dal punto di vista geografico, costituito da sistemi amministrativi e organizzativi e sistemi valoriali e culturali, con un apparato molto complesso di norme[24]. La soggettività e la coscienza dell’individuo si formano in questo concatenamento.
L’interiorizzazione psichica delle norme[25], tutte le norme, contribuisce in modo decisivo a far dichiarare a Nazim a proposito dei figli: ‘Qui, anche se studiano, vanno a fare i lavapiatti o a lavorare in un negozio’.
Concludo provando a rispondere al quesito che mi sono posto poc’anzi. Quella domanda di lavoro resta disattesa perché i concatenamenti di cui si è detto riproducono un rapporto migranti-mercato del lavoro fortemente e storicamente connotato dalla relazione “metropoli-periferie” di natura coloniale[26]; dall’interiorizzazione psichica della subalternità che vi è implicita. Da un lato, come dimostrano molti progetti e questo stesso congresso, è possibile immaginare percorsi professionali e rapporti nel mercato del lavoro basati su presupposti differenti. Dall’altro, è evidente che si tratti di percorsi lunghi e complessi, che vanno di pari passo con cambiamenti importanti a livello macropolitico, culturale e amministrativo in ambito nazionale e sovranazionale, oggi difficili da traguardare. Perché ciò si renda possibile, come ha detto a luglio Aboubakar Soumahoro, è però indispensabile, anche o soprattutto, “avere l’audacia di avviare una rivoluzione spirituale capace di ricostruire la nostra anima e di rinnovare le nostre menti, decolonizzandole dalla cultura impostaci dall’attuale sistema”
[1] A questo proposito vorrei ricordare, tra coloro ai quali sono maggiormente debitore per questa relazione, i lavori di Sandro Mezzadra, Enrica Rigo, Miguel Mellino e Iain Chambers, e ancora Stuart Hall, Nicholas De Genova, Yann Moulier Boutang, Robert JC Young, Achille Mbembe, Engin Isin.
[2] Si è soliti definire il colonialismo un’esperienza ascrivibile specificamente alle condizioni storiche, economiche e politiche che hanno segnato il passaggio dal protocapitalismo mercantile al capitalismo industriale, o dalla costituzione e consolidamento dei grandi stati-nazione europei all’emergere delle strutture sovrannazionali politiche ed economiche. Quello che si sostiene qui è, al contrario, il suo costituire un punto di svolta nella storia globale, con diramazioni rizomatiche che creano continuamente nuove forme di subalternità e, conseguentemente, di opposizione. Il Brasile di oggi rappresenta forse la forma più evidente e drammatica di “colonial settelment”, con l’Amazzonia sotto assedio e i suoi abitanti considerati “dispensabili”.
[3] Una definizione estremamente efficace della teoria postcoloniale è data da Robert Young: “una complessa rete di concetti e pratiche eterogenee che sono state sviluppate da tradizioni di resistenza a una traiettoria storica globale dell'imperialismo e del colonialismo”. Ne deriva che “il problema è quello di individuare i rizomi nascosti della portata storica del colonialismo, di ciò che rimane invisibile, silenzioso o non detto. In un certo senso, il postcolonialismo ha sempre riguardato la vita in corso di residui, resti viventi, eredità persistenti”. “il postcoloniale riguarda per molti versi una questione incompiuta, la continua proiezione di conflitti passati nell'esperienza del presente, l'insistenza persistente delle immagini residue della memoria storica che guidano il desiderio di trasformare il presente”. R.J.C. Young, Postcolonial remains, New Literary History, J. Hopkins UP, vol. 43, n.1, 2012, pp. 21-22. Traduzione mia.
[4] La molteplicità di confini costituisce il dispositivo della governamentalità delle migrazioni: per mezzo di questo dispositivo vengono definite politiche di inclusione, esclusione, divisione, settorializzazione, finanche di “razzializzazione”. I confini tagliano le aree geografiche, le metropoli, i quartieri, le comunità, i luoghi di lavoro, i corpi. Questo è il tema centrale del volume di S. Mezzadra e B. Neilson, Confini e Frontiere, Il Mulino, Bologna, 2016. Lo stesso tema porta a definire l’intimità del legame tra migrazioni e postcolonialismo: “Il termine postcoloniale [indica] una sorta di «ritorsione coloniale» sui vecchi centri metropolitani, ovvero l’irruzione della questione coloniale nel cuore stesso dell’Europa. […] Una «irruzione dei margini al centro»”. M. Mellino, Cittadinanze postcoloniali. Appunti per una lettura postcoloniale delle migrazioni contemporanee, in Studi culturali, Vol. 6, 2009. pag. 287
[5] Ètienne Balibar traduce il termine greco politeia, con “costituzione della cittadinanza”, dato da “il legame soggettivo tra polites e polis. […] Si tratta sempre di formare o configurare il cittadino, portatore dell’agire politico, definendo un insieme articolato di diritti, di doveri e di poteri, e prescrivendo le modalità del loro esercizio”. È. Balibar, Cittadinanza, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, pp. 23-24.
[6] Per schematizzare, abbiamo i cittadini formali (i titolari della cittadinanza, che costituiscono un insieme tutt’altro che omogeneo), i semi-cittadini (migranti UE), gli aspiranti cittadini (possessori del permesso di lungo soggiorno), fino al limbo di coloro che possono essere ricondotti al termine denizenship (la condizione di straniero residente con diversi tipi di permesso di soggiorno a scadenza) e, ancora più giù, tra le fiamme dell’irregolarità e clandestinità, la cui “illegalità” viene costantemente e “legalmente prodotta”, come sostiene Nicholas De Genova. Basti pensare alla assoluta funzionalità del lavoro “clandestino” al lavoro agricolo, nella piccola industria e in tutti gli altri comparti dove si applica per ragioni di mercato (leggi, di profitto) la massima riduzione possibile del costo del lavoro, consentita dallo status dei lavoratori. Cfr. N. De Genova, “The queer politics of migration: reflections on illegality and incorrigibility”, Studies in Social Justice, 101-126, 2010. Per una trattazione esaustiva della struttura della cittadinanza nell’Europa contemporanea, si veda E. Rigo, Europa di confine, Meltemi, Milano, 2007.
[7] Maria Paula Meneses descrive la struttura gerarchica della cittadinanza nel Mozambico al tempo del colonialismo. Gli ‘europei’ sono i portoghesi nati in Portogallo; i portoghesi nati in Mozambico o altre colonie sono i “brancos de segunda”; gli “assimilados” sono ‘indigeni’ che, aver reciso nettamente il legame con la propria storia e cultura, acquisiscono la cittadinanza portoghese, molto più formale che sostanziale. Infine, citando lo Statuto dell’Indigenato del 1929, Meneses riporta: “non vengono attribuiti agli indigeni, per mancanza di significato pratico, i diritti relazionati alle nostre Istituzioni costituzionali”. “Não se atribuem aos indígenas, por falta de significado prático, os direitos relacionados com as nossas instituições constitucionais” Meneses M.P. “Poderes, direitos e cidadania: o 'retorno' das autoridades tradicionais em Moçambique”. Revista crìtica de Ciências Sociais , p. 9-42, 2009, p. 10. Traduzione mia.
[8] Si fa riferimento qui al concetto di “emergenza” in Nietzsche, discusso da Foucault in Microfisica del potere, Einaudi, Torino, 1977, p. 37 e seguenti. L’emergenza è “il momento della nascita”, “un luogo di scontro”; “l’opera recitata su questo teatro senza luogo è […] quella che ripetono indefinitamente i dominatori e i dominati”.
[9] Prendendo a prestito un concetto usato da Pierre Macherey, credo si possa parlare, forse, del sorgere di una “seconda natura”, “attraverso una procedura che ha reso naturale […] ciò che in realtà non lo è”. P. Macherey, Il soggetto delle norme, Meltemi, Milano, p. 159. Macherey, in realtà, usa questo concetto per descrivere il modo in cui il lavoratore si soggettivizza nel sistema produttivo e nella società delle norme che lo assoggettano. Se ne propone quindi un’estensione a questo specifico ambito. Questa “realtà innaturale” si palesa nell’incertezza della “doppia assenza”, secondo la definizione di A. Sayad, La doppia assenza, Cortina Raffaello, Milano, 2002. Il “non essere più” si coniuga con un “non essere ancora”, o un “non poter mai essere”.
[10] Tra i moltissimi lavori, si segnala il contributo di Luca Queirolo Palmas I figli dell’immigrazione e la posterità inopportuna, contenuto in S. Mezzadra, M. Ricciardi (a cura di) Movimenti indisciplinati, Ombre Corte, Verona, 2013.
[11] Contenute in S. Rota, Cittadinanze e identità migratorie, https://associazionetransglobal.jimdofree.com/progetti-projects/ebook-library/
[12] Alla base di queste e altre interviste vi è un’impalcatura epistemologica che riassumo in questi termini: Gli eventi trovano piena vita solo all’interno di una storia priva di essenzialismi, di identità ed enti iniziatori, ma basata sulla proliferazione di avvenimenti che si sono dispersi nel divenire genealogico. È in quel divenire che si formano le soggettività. Il soggetto non preesiste a nulla e non conclude nulla.
[13] Contenuta in S. Rota, Il tempo dei migranti, “Vedevo tutto bianco – Conversazione con Ejaz Ahmad” https://associazionetransglobal.jimdofree.com/progetti-projects/ebook-library/
[14] Si veda a questo proposito “Mission: Vivere o non vivere in Italia” una “scheggia” illuminante e geniale di poco più di un minuto di Phaim del 2012, allora sedicenne, a cui devo moltissimo per le mie ricerche e interessi in questo ambito. https://associazionetransglobal.jimdofree.com/2016/01/13/vivere-o-non-vivere-in-italia-phaim-bhuiyan/
[15] Il concetto è stato sviluppato da S. Mezzadra e B. Neilson, soprattutto in Confini e frontiere (cit.). In precedenza, Castles e Miller hanno usato il modello della “esclusione differenziale” per descrivere le tecniche di ammissione e di esclusione allo stesso tempo: “i migranti dovevano essere incorporati temporaneamente in alcune aree della società […] mentre non era loro permesso di accedere ad altre”. M. J. Miller e S. Castles in The Age of Migration, McMillan Press, London, 1993, p. 244, traduzione mia.
[16] Sarebbe infatti riduttivo applicare questo modello unicamente alla condizione di migrante. La teoria femminista ha molto insistito su questo concetto. Si veda, ad. es., D. Haraway, Manifesto Cyborg, Feltrinelli, Milano, 2018.
[17] L’indagine Unioncamere-Excelsior rileva ormai da circa vent’anni questi dati con una metodologia che è divenuta nel tempo sempre più precisa. Va detto che gli andamenti delle Comunicazioni Obbligatorie per i lavoratori assunti, di fatto, confermano le previsioni rilevate l’anno precedente, sia pur con uno scarto fisiologico dato dalla mancanza di alcuni settori strategici nel sia pur ampissimo campione di rilevamento di Excelsior (agricoltura, lavoro domestico con famiglia come datore di lavoro, la PA, le organizzazioni associative), tracciano linee diagrammatiche molto simili. https://excelsior.unioncamere.net/xtm/geoChooser/scegli-archivio.php
[18] Tale difficoltà può essere di tre tipi: la dimensione quantitativa (scarsa presenza), la dimensione qualitativa (offerta inadeguata) e la rispondibilità (Answerability è per Engin Isin uno degli elementi connotanti la capacità d’agire del cittadino migrante. E. Isin, Citizens without frontiers, Continuum, London-NY, 2012) dell’offerta rispetto alle condizioni lavorative che il profilo richiede (retribuzione, orari di lavoro, turni, ecc.), che nell’indagine viene genericamente indicata con “altro”.
[19] Nello specifico, aumenta il numero di profili professionali per i quali si prevedono assunzioni di lavoratori stranieri (erano 102 nel 2017 e diventano 120 nel 2019); aumenta il numero totale delle previsioni di assumere un cittadino straniero, passando da 12.600 a 14.000; queste si mantengono molto concentrate nelle professioni storicamente presidiate dal lavoro immigrato. Il 60% della domanda di lavoro prevista nel 2019 interessa le prime dieci delle 120 professioni per cui si intendono effettuare assunzioni di lavoratori stranieri.
[20] Questo aspetto - trattato qui necessariamente in modo molto sommario – è fondamentale per la lettura e comprensione delle interconnessioni che vincolano i migranti al mercato del lavoro. La complessità degli enti coinvolti e le articolazioni che si creano tra di essi che, con gradi diversi di “legalità”, hanno come fine l’arrivo del migrante nel paese di destinazione e il suo inserimento in un determinato contesto lavorativo, è stato descritto come “l’infrastruttura delle migrazioni”, in B. Xiang, J. Lindquist, Migration Infrastructure, in Migration International Review, Volume 48, n. S1, 2014, p. 122-148. Quello che si propone qui è una estensione del significato di infrastruttura anche ad ambiti familiari e comunitari. Il tema è stato trattato in: Ejaz A, Juvi E, Jackie B, A. E. M., Stefano R. Il Tempo dei migranti - Nel ventre del drago, https://associazionetransglobal.jimdofree.com/progetti-projects/ebook-library/
[21] Questo concetto stato sviluppato da G. Deleuze e F. Guattari in due saggi, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Orthotes, Napoli, 2017, e in L’Anti-Edipo, Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 2002, dove prende il nome di “concatenamento macchinico”.
[22] M. Lazzarato, Segni e macchine. Il capitalismo e la produzione di soggettività. Trad. Gianfranco Morosato, Ombre Corte, Verona, 2019, p. 73.
[23] Questi sono esempi di professioni particolarmente significativi in Liguria; in altre regioni il lavoro straniero è maggiormente orientato in ambito agricolo o industriale e meno concentrato in pochi profili, ma il senso generale non cambia.
[24] Per provare a dare alcuni esempi, ne fanno parte la famiglia d’origine, le agenzie per l’organizzazione dei viaggi e agenzie di reclutamento, i sistemi di comunicazione, i sistemi di gestione degli ingressi e del soggiorno, la comunità di appartenenza nel paese di destinazione, i servizi per il lavoro, il sistema d’istruzione con le proprie regole di riconoscimento di percorsi di studio. Ognuno degli enti nominati, e altri, svolge un ruolo preciso nella produzione della “naturalità” di determinati percorsi.
[25] Judith Butler ha trattato in modo esaustivo l’interiorizzazione psichica della norma e la formazione della coscienza in J. Butler, La vita psichica del potere, Mimesis, Milano, 2013.
[26] Tale relazione si basa sull’identificazione tra appartenenza etnica e professione, estremamente efficace per la ricattabilità e la minaccia di sostituzione con altre “etnie”. Si crea un vincolo con la comunità di riferimento, vero garante dell’affidabilità del lavoratore, con la logica del concatenamento di cui si è detto.
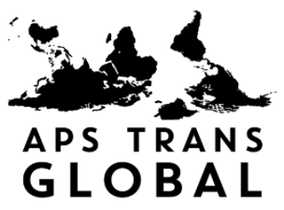
Scrivi commento