Parto da una riflessione sulla testimonianza di Simonetta, la driver di Amazon che ha contribuito alla stesura di “La fabbrica del soggetto. Ilva 1958 – Amazon 2021”, alla presentazione del libro in piazza dei Truogoli di santa Brigida, a Genova, il 6 luglio. Da lì, proverò a muovermi nella direzione che dà il titolo a questo scritto. Le due cose mi sembra siano correlate, almeno nel mio modo di vedere il dispositivo lavoro nella nostra attualità.
Senza farla lunga, Simonetta ha sostanzialmente detto che ad Amazon si trova bene, che lavora in un ambiente accogliente e rispettoso. Inutile dire che tali affermazioni hanno suscitato non pochi aggrottamenti di sopracciglia tra i presenti. Una parte di questi si aspettava una presa di posizione centrata sulla critica alle forme di neo-taylorismo digitale, sul dominio impersonale e onnipresente dell’algoritmo che governa il lavoro in Amazon.
Niente di tutto questo. Simonetta in Amazon si trova bene.
Solo come aggiunta, la persona che ha reso la sua testimonianza sul lavoro di magazziniere in un megacentro dell’hinterland romano, Dario, ha messo sì in evidenza quei temi, ma senza con questo metterli in contrapposizione col significato che assume per se stesso il lavoro in generale, prima ancora di come viene declinato in Amazon. Passato ad altro, Dario dice nel suo contributo alla auto-postfazione del libro che tutto sommato rimpiange quello che faceva nell’impianto del colosso dell’e-commerce, dove tutto risultava più chiaro, nel bene e nel male.
Provo a farmi aiutare nella comprensione di quanto appena riportato da due prodotti cinematografici in cui entra in gioco il lavoro nella logistica, ma solo in uno dei due Amazon: Sorry, we missed you, di Ken Loach e Nomadland, di Chloé Zhao. Chi ha visto i due film si ricorderà del divario che separa le storie dei due interpreti, complice anche il diverso contesto socio-geografico in cui prendono vita: molto drammatica e tipicamente working class inglese la prima, più romantica, on the road stile hobos del XXI secolo con sullo sfondo i grandi spazi americani, la seconda.
Rocky, il driver di un corriere nel film di Loach, ci presenta lo stereotipo del tifoso inglese nel nord dell’Inghilterra, membro di una famiglia stritolata dalla crisi del 2008, che tenta di risalire la china con il mito dell’essere “imprenditore di se stesso”, un mito che lo trascina in un vortice di progressivo stritolamento da cui non si vede possibilità di uscita. Il tipo di ditta presso la quale lavora Rocky è ben rappresentato anche nel panorama italiano e non a caso è in quell’ambito che si sono innescate le lotte, anche molto dure, dei lavoratori della logistica in questi ultimi anni. È lo stesso ambito dove ha lavorato Simonetta per diversi anni, prima di approdare al subappalto in Amazon, e dove ha partecipato in prima persona a picchetti e blocco dei cancelli.
La disincantata donna di mezz’età interprete del film di Zhao gira da sola negli spazi immensi del Mid West con un van, fermandosi per lavorare nei magazzini di Amazon, ma subito pronta a ripartire alla volta del successivo parcheggio dove incontra amici in perenne movimento come lei. Non traspare nessuna particolare tensione o rivendicazione: ciò che Amazon propone a Fern, la protagonista del film, è né più né meno quello di cui lei stessa ha bisogno per il tipo di vita – nomade – che ha scelto, o che si è trovata costretta a scegliere.
Quello che i due personaggi mettono in evidenza, nelle differenze che li connotano, è il modo in cui il lavoro entra in relazione con l’impianto esistenziale che scandisce le loro vite sulla base di un complesso concatenamento di valori, esperienze e aspettative che travalicano, e di molto, il contesto in cui il lavoro stesso si espleta.

Abbandono la parentesi fiction, intrisa peraltro di realismo di ottima fattura, e torno al nostro quotidiano, portandomi però dietro un elemento che tornerà utile nel passaggio successivo e che viene ripreso in più punti nel libro. Che tipo di verità produce il narrato di Simonetta e quello di Dario (ma allo stesso modo quello dei lavoratori di Fincantieri e di tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del libro) e che rapporto intrattiene con la soggettività che si manifesta nel momento in cui descrivono la propria esperienza. Per dirla con Foucault, quelle parole, pronunciate su un reale che “non costituisce la ragion d’essere di quel discorso”, ma che si sovrappongono a esso come un nuovo strato senza che tra i due piani (il reale e il discorso) vi siano necessariamente contatti, quelle parole assumono il carattere evenemenziale della verità. Il discorso di verità costituisce un “evento”, è la verbalizzazione dell’emergere dell’esperienza come momento di sutura tra tecniche di potere e tecniche di rapporto di sé con sé.
Provo a partire da una considerazione tanto ovvia quanto considerata irrilevante, sembra, dagli stupiti ascoltatori delle parole di Simonetta. L’esperienza che racconta, e la verità che la sostiene, non può essere estrapolata da un’esistenza connotata da grandi difficoltà e durezze. Il lavoro in subappalto per Amazon, se confrontato con tutto quanto ha costellato la sua vita lavorativa nel corso degli ultimi 35 anni, rappresenta senza dubbio un punto di arrivo. Come Fern, forse, quello che le offre Amazon collima con un’idea di lavoro che è ciò che le serve per prendersi cura di sé, dei propri figli, per aver tempo di andare in palestra.
Dal canto suo, Dario, nella conversazione avuta con Piero e me, ci racconta delle pause alla macchina del caffè. Nei momenti in cui si parla di lavoro, dando per scontata la fuoriuscita da Amazon per quasi tutti loro dopo tre o sei mesi, ci si scambiano opinioni su cosa fare, dove cercare. Verrebbe da dire che c’è corrispondenza tra le loro strategie e il contesto in cui si muovono, che li vuole sempre più votati al nomadismo, non solo o non tanto geografico, ma soprattutto esistenziale, attitudinale.
Di questo, il colosso di Seattle, come tutte le aziende della platform economy che sempre più si costituiscono come referente smart per il “lavoro 4.0”, è perfettamente consapevole. A partire da quella consapevolezza si struttura e si espande la logica estrattivista che vede nei corpi degli individui (prima che dei lavoratori), il terreno da scavare. Detto questo, le nostre osservazioni sul modello Amazon, molto ben presentate in un numero ormai elevato di scritti da parte di ricercatori e studiosi, devono fare i conti con almeno due elementi che contribuiscono a posizionare il (questa volta nostro) discorso rispetto al reale. Il primo, come emerge dalle indagini di Marco Veruggio [1], ci dice che su circa 14.000 lavoratori e lavoratrici in Italia inclusi i “somministrati”, chi ha aderito a una sigla sindacale sono pochissime centinaia; il secondo è che ad Amazon la fila davanti alla porta è all’esterno per entrare, non all’interno per andarsene sbattendola. Se non fosse così, non si spiegherebbe il successo che ha.
Aggiungo un ulteriore elemento. Tra le nove persone incontrate in Fincantieri che hanno partecipato alla stesura di “La fabbrica del soggetto”, solo una si trova ancora là dove era stata trovata: tutti gli altri sono in altre città o altri stati, lavorano in altri settori, o non lavorano affatto. Certamente in questi casi gioca un ruolo determinante il fatto che si tratti di cittadini/lavoratori con un background migratorio, che continua a essere presente nella loro vita anche a vent’anni o più dal primo evento che li ha visti partire dal loro paese. L’immagine di nomade, in questo caso, si coniuga con quella che è stata definita anni fa “la condizione postmigratoria” che si traduce in seconde, terze migrazioni.

Il nomadismo nel lavoro, quindi nella vita, contiene il precariato ma allo stesso tempo lo eccede. La distinzione tra le due condizioni può essere vista in una tensione alla fuga, alla diserzione che connota il primo, ma non necessariamente lo si trova nel secondo. Fuga, diserzione: ma da cosa e verso dove?
Per rispondermi a questa domanda faccio riferimento a un’indagine in corso sui fabbisogni professionali e formativi delle aziende che mi sta conducendo a incontrare i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e altri soggetti che insieme contribuiscono a definire il sistema di governamentalità del lavoro in Liguria. La stessa indagine venne condotta circa due anni fa, quindi nella fase iniziale di allentamento delle restrizioni dovute alla crisi pandemica. Quest’ultimo è un dato importante, perché l’immagine che ci restituivano i nostri interlocutori allora era tarata sulla loro realtà pre-pandemica, considerando quella in corso una condizione del tutto eccezionale, da cui si sarebbe usciti ritornando allo stato di cose che l’avevano preceduta. Gli incontri attuali, al contrario, mettono in evidenza un cambiamento iniziato, come ci dicono i nostri interlocutori, un anno e mezzo fa e in continua crescita: considerando i profili professionali di livello medio-basso per contenuto tecnologico e cognitivo, o giudicati tali, la carenza di offerta di lavoro (i lavoratori, per chi non ha dimestichezza con la terminologia) è arrivata a livelli molto elevati. Non solo ci sono interi settori che non riescono a far fronte alle esigenze di personale oggi (commercio, ristorazione, grande distribuzione, artigianato di produzione, edilizia), ma verosimilmente non riusciranno a farvi fronte neanche domani, perché i corsi di formazione proposti per questi profili vanno sistematicamente deserti, o quasi. Di tutto questo non vi è traccia nel precedente ciclo di incontri.
Va detto che da questa tendenza sono escluse le aziende di maggiore dimensione (ma non la grande distribuzione) e i profili che si collocano nella fascia medio-alta della piramide dei profili professionali.
La prima osservazione che viene da fare è che se offri condizioni lavorative e salari non adeguati, giustamente i più giovani, ma non solo, si tengono alla larga. È vero, ma è altrettanto vero che due anni fa questa situazione non venne presentata da nessuno dei nostri interlocutori e, se ricordo bene, condizioni lavorative e salari di merda non sono una novità di questi ultimissimi tempi. L’altro refrain che i ragazzi preferiscono stare a casa con il reddito di cittadinanza credo non vada neppure commentato.
Cosa rimane? Per una minoranza, certamente l’accesso a posti di lavoro più ambiti (nel pubblico, nelle aziende di maggiore dimensione, in proprio), ma si tratta di una minoranza e, se consideriamo quelli che il programma GOL del PNRR considera i soggetti deboli e lontani dal mercato lavoro, molto ristretta, per non dire inesistente.

Per la grandissima maggioranza di questi ultimi, che include donne sole con figli, immigrati, disoccupati di lunga durata, i cosiddetti “neet”, cinquantenni espulsi dal lavoro e difficilmente ricollocabili, percettori di NASpI e di RdC e molte altre categorie, le porte dei Centri per l’Impiego sono girevoli: si entra perché si è costretti e si esce con qualche indicazione e qualche buona intenzione.
Lì si verifica il primo distacco che produce fuga, diserzione da un modello basato su tirocini, apprendistato, formazione non retribuita. In sintesi, lavoro e formazione in cambio di periodi lunghi senza reddito o con redditi simbolici che, ovviamente, i soggetti di cui sopra non si possono permettere. Se aggiungiamo a questo le condizioni lavorative tipiche delle piccole unità, con il fiato del datore di lavoro sempre sul collo, che magari dal lavoratore si aspetta lo stesso tipo di coinvolgimento e dedizione che ci mette lui nel lavoro, dimenticandosi distrattamente la distinzione tra titolare e dipendente, abbiamo completato il quadro.
Anzi, a dire il vero, il quadro si completa aggiungendo un elemento che avrà bisogno di essere indagato in maniera approfondita nei prossimi anni. I lavori che reggono e attraggono, sia pur con modalità differenti, sono quelli che nel biennio della pandemia non solo non hanno subito arresti, ma che al contrario hanno proliferato. Si tratta, da un lato, delle professioni di cura (le uniche per le quali si riescono a fare dei corsi di formazione, ci dicono i nostri interlocutori) e, dall’altro, logistica e gig economy. Verso quest’ultima, la crescita d’interesse da parte di cittadini variamente classificabili è molto alta.
Tralascio i primi due (cura e logistica in senso ampio) e provo a concentrare le ultime righe di questo articolo sulla gig economy. Innanzi tutto da dove proviene il nome. Ce lo spiega Bruno Cartosio, insieme a molte altre cose contenute nel suo articolo su Officina PrimoMaggio[1]: “ha preso a prestito l’etichetta dal mondo dello spettacolo, dove indica il ‘numero’ che un attore senza compagnia è chiamato a fare se si ha bisogno di lui e per il quale è pagato”. Si tratta di un settore in costante crescita, di cui gli ormai familiari riders del food delivery che vediamo percorrere le nostre città a qualunque ora e con qualunque condizione atmosferica (e sanitaria!) rappresentano la parte, appunto, più visibile. In realtà, e Cartosio ne offre una descrizione molto accurata e documentata, i gig works interessano una platea molto più ampia di lavoratori e nei settori più disparati, che vanno dal dogsitter al produttore di logo per aziende (“paghi solo se ti piace”, dice la homepage di TRɛLOGO), dalla consegna e montaggio di mobili al lavoro da remoto per Amazon.
[1] B. Cartosio, Gig work tra passato e futuro https://www.officinaprimomaggio.eu/gig-work-tra-passato-e-futuro/?utm_source=substack&utm_medium=email

Quello che contraddistingue il gig work in qualunque settore si svolga è la percezione, fondata o infondata che sia, poco importa, di gestire il proprio lavoro con le modalità e i tempi che si scelgono. Da qui, come riporta sempre Cartosio nel suo articolo, la soddisfazione di una quota molto alta dei gig workers verso questa modalità lavorativa.
A questo proposito, il rappresentante della CGIL Nidil a Genova mi ha raccontato un aneddoto piuttosto emblematico. La vertenza che ha condotto JustEat a riconoscere i propri riders come lavoratori dipendenti è stata ricevuta molto male (per usare un eufemismo) da moltissimi di loro, che si sono sentiti ingabbiati in una modalità lavorativa che non cercavano.
Mi fermo qui sul gig work per non dire male cose che Cartosio ha detto molto bene. Restano alcuni punti importanti da approfondire che necessitano di tempi e tecniche adeguate. C’è un filo rosso che unisce questi lavoratori tra loro, con quelli di Amazon e Fincantieri e con la definizione di nomadismo che è stata usata in precedenza? All’interno di quale progetto di vita, di quale idea di futuro (mi tremano le dita a scrivere questa parola, ma è l’unica che mi viene in mente) si colloca questa modalità lavorativa? La pandemia ha avuto un ruolo di acceleratore di questa tendenza all’espansione, e se sì quale e su cosa ha agito?
Sono quesiti che percepisco come assolutamente centrali per la comprensione di un fenomeno che ci attraversa quotidianamente ma di cui sappiamo solo le cose di più immediata visibilità e intellegibilità.
Abbiamo di fronte un lavoro decisivo, che può essere svolto solo se facciamo dell’inchiesta l’asse portante della nostra volontà di capire, in nome di un attivismo che non può attendere oltre e, soprattutto, non può percorrere le comode strade basate su modelli interpretativi che manifestano, da ieri, tutta la loro inadeguatezza.
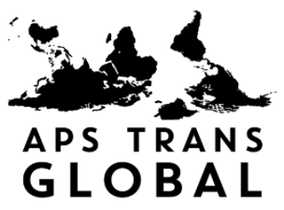
Scrivi commento
Giuseppe De Feo (domenica, 30 luglio 2023 16:47)
Una riflessione acuta, stimolante, un bel punto di avvio per il processo di ricerca. Tra l'altro evidenzia bene alcune posizioni paradossali del mondo dell'offerta di lavoro, oggi così diversificato.