Stefano Rota
C’era molta gente martedì 17 settembre all’incontro organizzato ai Giardini Luzzati a Genova con i rappresentanti del Collettivo della GKN, persone che coprono anagraficamente quattro generazioni, per fortuna. Ma questo, forse, non è neppure il dato più importante, o quantomeno lo è in derivazione di un altro elemento.
C’erano rappresentanti di associazioni che operano nei quartieri (a dire il vero, sempre lo stesso, il centro storico della città, e di questo siamo tutti un po’ responsabili, io per primo, che vivo in periferia), che si occupano di inclusione socioculturale dei migranti, giovani dei centri sociali, dei movimenti femministi ed ecologisti. C’erano ex-militanti dei sindacati che furono in prima linea nel ciclo di lotte nelle grandi fabbriche genovesi fino agli anni Ottanta, e i rappresentanti di nuove forme sindacali sorte nel modello di organizzazione del lavoro postfordista. C’erano vecchi militanti delle organizzazioni politiche che hanno vissuto la stagione del “lungo ‘68”, e altri più giovani che hanno avuto il battesimo di fuoco con il G8, o in uno dei tanti sgomberi di centri sociali, o nelle occupazioni delle scuole. C’erano esponenti del mondo accademico e scolastico, in forma di professorato e di studentato, e così via.
Le quattro generazioni (boomer, x, millenial, z) si riflettevano in questo arcipelago di vissuti, esperienze, lotte; per usare un termine che prova a includerle tutte, un arcipelago di pratiche quotidiane di antagonismo.
Di fronte a questo variegato e sensibile pubblico, i rappresentanti di quella che rappresenta oggi l’emblema della lotta contro le tecniche finanziarie e predatorie del neoliberalismo hanno raccontato tre anni di resistenza e di proposte. Chi non fosse aggiornato, può trovare qui tutto il materiale che serve, quindi non provo neanche a riprendere male quello che è scritto lì molto bene.
Mi interessa mettere l’attenzione su due termini che sono stati usati più volte in quell’incontro, uno in modo esplicito, il secondo meno. Il primo è convergenza, il secondo è mutualismo. Quest’ultimo è entrato nella presentazione in forma di acronimo: SOMS, Società Operaia di Mutuo Soccorso. A una di queste, la SOMS Insorgiamo, nata nel 2022 per iniziativa degli operai della GKN, è stato dato il compito di raccogliere i fondi dell’azionariato sociale per il nuovo avvio delle attività della fabbrica.
La trovo una scelta importante e del tutto condivisibile, per ciò che sono e soprattutto sono state le SOMS. Anche in questo caso, sarebbe troppo lungo descrivere cosa hanno rappresentato quelle strutture dall’inizio dell’industrializzazione in Italia, una storia facilmente reperibile in rete. In termini molto generali, si può dire che le SOMS rappresentano nella memoria collettiva un esempio di organizzazione dal basso di solidarietà e sostegno a coloro che, per varie ragioni, si trovavano in difficoltà, almeno fino alla metà del secolo scorso.
Personalmente, considero il mutualismo una pratica fondamentale per dare vita a quello che molti studiosi hanno definito il potere costituente, ma anche, senza mettere i due termini in contrapposizione, potere istituente. Il concetto stesso, mutuo, rimanda a un agire che, nel dispiegarsi di una potenza solidale, dà vita alla costituzione di pratiche che tendono a sottrarre spazi e tempi all’ordine neoliberale. Così facendo, quell’agire si fa istituzione, definisce forme organizzative che ridisegnano le modalità relazionali che stanno alla base di quello stesso ordine.
Il mutualismo come pratica fondamentale, dicevo, perché è al suo interno dove il soggetto “si può rifugiare per rendere tollerabile la sua esistenza”, come ho messo nella conclusione del precedente articolo a cui mi ricollego (qui e qui). Ma allo stesso tempo è dove si può “frequentare il futuro”: non immaginarlo, non sublimarlo, ma viverlo oggi.
Con “frequentare il futuro” intendo vivere in uno spazio in cui le singole problematiche (o le singole attività politiche) sono collocate in una posizione tale da produrre articolazioni con altre problematiche. Articolazione non significa adesione e neppure convergenza. Significa punto di sutura, quel punto specifico dove un’istanza di qualunque natura essa sia ne incontra un’altra o altre. Il punto in cui si produce una frazione del comune.
Convergenza indica un percorso diverso, anzi, per essere più precisi, indica un tratto successivo del percorso. Un’esperienza formidabile come quella del collettivo GKN è naturale che chiami a convergere verso la propria lotta altre forme collettive di dissenso e di critica radicale allo stato di cose presenti.
Se questo rafforza il sostegno - e ne hanno tutto il diritto di chiederlo - verso l’intero progetto dell’attività del collettivo GKN, resta la domanda se, alla base di quel convergere, esista una reale articolazione di altre problematiche della stessa o di diversa natura, in ambito lavorativo o in altro ambito.
L’altra domanda che pongo, prima di tutto a me stesso, è quale forma organizzativa può essere in grado di assumere in sé quelle articolazioni, in modo da lasciare sempre spazio a nuovi punti di contatto. Non credo possa essere la “forma partito”, per lo meno come siamo abituati a intenderla; neppure un’organizzazione sindacale specifica. Neppure – lo dico con tutto il rispetto e la solidarietà possibile per quella vertenza – il collettivo di una fabbrica in lotta.
Sono, questi, spazi “saturi”. C’è bisogno di una istituzione che riesca ad assumere la funzione del politico, come momento di convergenza – adesso sì – delle politiche, intese come specifiche azioni ognuna nel suo ambito di riferimento, che hanno raggiunto un punto di articolazione. Questa istituzione può presentarsi solo come uno spazio “vuoto”, nell’accezione positiva del termine, al cui interno il “potere di agire” in una specifica situazione si trasformi in “potenza dell’azione” del comune.
In ogni angolo, in ogni voce del quartiere qualunque in cui viviamo si avverte in modo sempre più drammatico il senso di individualizzazione nel far fronte a problemi collettivi, il costante arretramento della dimensione comunitaria. Questo riguarda tanto gli aspetti direttamente riconducibili alle condizioni economiche legate al reddito e al lavoro, quanto alla crescente riduzione dell’accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, per non parlare degli spazi di socializzazione e di produzione culturale.
Descrivo quello che vedo abitualmente: la crescente violenza tra gli adolescenti (ieri sulla metro un gruppetto di quattordici-quindicenni parlavano di scontri con il coltello con altri, come se fosse la cosa più normale, e forse lo sta diventando), l’emarginazione di interi quartieri dove nessuno, se non gli abitanti, sa veramente cosa succede, le persone anziane che sempre con maggior difficoltà e rassegnazione accedono ai servizi socio-sanitari. Andando avanti, i ragazzini delle periferie (come quelli che ho incontrato in metro) che si riconoscono nei messaggi di trapper infarciti di violenza, mito del denaro facile e disprezzo per le donne (non sto facendo nessun facile moralismo da sessantenne, sia chiaro!), le scuole che propongono modelli meritocratici in puro stile aziendalista, che lasciano indietro sempre gli stessi. E poi i lavoratori della platform economy, spinti a vedere nel lavoro qualcosa di simile a un gioco (Marco Veruggio, grande conoscitore del pianeta Amazon, mi ha raccontato di un lavoratore che in una chat chiedeva come poteva fare per rinunciare alle ferie, perché si sentiva un “vero driver Amazon”!), quelli in sub-subappalto in Fincantieri, che pur di costruire una casa sicura in Bangladesh sono disposti a tutto, quelli che hanno perso il reddito di cittadinanza, i “beneficiari” del programma GOL dei Centri per l’Impiego.
So che sto facendo una lista molto parziale e centrata solo sul mio vissuto; chiunque, tra coloro che stanno con gli stivali ben piantati nel fango, potrebbe aggiungere altri esempi di desertificazione del tessuto societario e civico in cui siamo immersi.
Anche limitandosi a quanto elencato, mi viene in mente ciò che si chiedeva un grande pensatore nel 1977 (quasi cinquant’anni fa!), la cui risposta ha aperto un dibattitto che, mi sembra, latiti molto in questo triste nostro tempo. “Quando parliamo di lotta di classe, di che lotta stiamo parlando?” (M. Foucault).
Se mi volessi avventurare nella zona malfamata bazzicata da coloro che hanno una risposta per tutto, azzarderei “una lotta del molteplice”, che articoli tra loro tutte le esperienze che vediamo come forme di resistenza e quelle che o non vediamo, perché sono troppo vicine, o perché proprio non esistono. Il molteplice non è sinonimo di multiplo: il multiplo è la somma di esperienze (N+1), il molteplice è sottrarre la centralità del singolo, a favore del comune (N-1). Non è una definizione mia, ma me la sento sotto la pelle.
Rimane l’ultimo punto. Verso cosa vogliamo che converga questa articolazione di esperienze? Sto ancora un attimo in quella zona là e provo ad abbozzare una risposta, tanto provvisoria, quanto poco articolata. Verso strutture che si basino sui principi e le pratiche del mutualismo (vecchio e nuovo stile). Strutture per ripensare la solidarietà, il sostegno mutuo tra soggetti che difficilmente oggi si parlano, che siano il punto di riferimento per la messa in campo di azioni concrete. Tra queste ultime, anche quelle che producono sostegno economico, o offerta di servizi in cambio di altri servizi (come l’esperienza della Banca del Tempo), o l’organizzazione di ambulatori solidali, di corsi di formazione, di recupero di terreni rurali o spazi urbani abbandonati, e via discorrendo.
Azioni che abbiano come obiettivo rifondare il senso di comunità sul principio della fratellanza e sorellanza, della liberazione quotidiana di pezzetti di vita da presentare a tutti come un futuro “comune”, già da oggi frequentabile.
Articolo pubblicato originariamente su comune-info
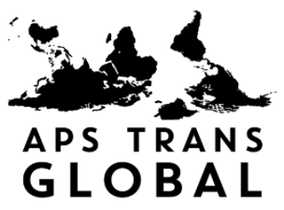
Scrivi commento