Stefano Rota
[Nel testo sono presenti dei paragrafi rientrati a sinistra e messi tra parentesi quadre. Possono essere saltati e passare al primo paragrafo successivo senza rientro. Segue una terza parte]
Secondo tempo
Mi sembra che il punto 1[1] implichi una domanda importante, più che mai attuale, ma molte volte elusa: a cosa serve la ricerca sociologica?[2] La risposta deve partire, credo, dalla contestualizzazione nel tempo e nello spazio in cui la ricerca si svolge e, quindi, come già accennato sopra, alle condizioni che il sapere offre tramite gli strumenti disponibili in un determinato contesto. Un contesto che definisce ed è definito dalle emergenze e le urgenze di fenomeni a cui la sociologia è chiamata, per usare la sequenza weberiana che forma la “sociologia comprendente”, a offrire una “comprensione, spiegazione e interpretazione” dell’esperienza, individuandone il senso che solo quelle determinate condizioni e non altre consentono di far emergere e quindi di cogliere. È un percorso di conoscenza che si colloca su un piano intermedio tra nomotetico (leggi generali) e idiografico (azioni ed eventi idiosincratici) (Weber, 2014).
La razionalità della sociologia comprendente che sta alla base del metodo weberiano – e che consente di cogliere anche gli aspetti di irrazionalità che lo stesso Weber riscontra, e valorizza, in tutti i contesti che analizza come conseguenze non intenzionali dell’azione - trova in quella sequenza una sua valida e attuale sintesi. Il senso che si vuole provare a dare qui alla questione relativa l’uso e l’utilità della ricerca sociologica si colloca lungo una linea che da quella sequenza diparte, per intraprendere un percorso che assume più i connotati dell’inchiesta.
Da un lato, seguendo un’impostazione alquatiana, l’orizzonte epistemologico è dato da una “conoscenza soggettiva, empirica e sperimentale, che si dà «sul campo»”, attraverso una pratica che guarda la “costruzione della soggettività politica e mettendo in discussione la dicotomia tra inchiestante e inchiestato” (Polleri, 2018).
Dall’altro lato, nel momento in cui il ricercatore si sottrae al vincolo della domanda ‘a chi può servire immediatamente il sapere che sto producendo e dove devo presentarlo?’, si dispiega un modo di fare inchiesta che “non è fatta allo scopo di accumulare conoscenze, ma per accrescere la nostra intolleranza e farne un'intolleranza attiva” (Foucault, 2017, p. 265). Ciò comporta un ruolo dell’intellettuale che, secondo Foucault, “non è più di porsi ‘un po' avanti o un po' a lato’ per dire la verità muta di tutti; è piuttosto di lottare contro le forme di potere là dove ne è ad un tempo l'oggetto e strumento: nell’ordine del ‘sapere’, della ‘verità’, della ‘coscienza’, del ‘discorso’ (Foucault, 1982, p. 109. Corsivo mio).
È all’interno di quella logica d’inchiesta che la “verità muta di tutti” lascia spazio ad altre visibilità e altre voci, ad altri regimi di verità, produce spaesamento.
[Il numero 1 del 2007 della rivista Sociologica ospita un saggio di Michael Burawoy, titolato Per la sociologia pubblica, una definizione coniata dall’autore. Nello stesso numero e in quello successivo della rivista vengono raccolti contributi di studiosi italiani sul tema, in particolare Marco Santoro (2007) e Antonio Chiesi (2007) a indicare un interesse crescente anche in Italia verso le tesi di Burawoy, tesi poi ulteriormente riprese e commentate da Mauro Palumbo (2014). La sociologia pubblica, dice Burawoy, intende “riportare il sapere a coloro da cui esso proviene, trasformare problemi privati in questioni pubbliche”. L’autore articola il saggio in undici tesi, descrivendo i rapporti tra i quattro tipi di sociologia che egli identifica per comprendere le posizioni e le funzioni operative di quella scienza: la sociologia professionale, pubblica, pratica (di policy) e critica. Quello che interessa molto sinteticamente mettere qui in evidenza è ciò che per Burawoy rappresenta il senso e la funzione della sociologia pubblica. Specificando cosa intende con tale definizione, Burawoy dice che essa “dà luogo a una conversazione tra la sociologia e i pubblici, intesi come persone esse stesse impegnate in una conversazione”. Una versione “militante” della sociologia pubblica viene definita da Burawoy, prendendo in prestito il lessico gramsciano, organica. Il “sociologo pubblico organico” dice l’autore, opera “a stretto contatto con un pubblico visibile, ‘denso’, locale e spesso antagonista”. Si tratta di un pubblico da creare nell’interazione con i gruppi con cui la ricerca interagisce – “malati di Aids, donne con tumori al seno, donne, gay” -, e in quella stessa interazione crea anche il pubblico dei sociologi pubblici organici, “capace di azione nell’arena politica”. Qui si aggancia la tesi di Burawoy, secondo cui la sociologia pubblica e quella di policy “non si escludono a vicenda e non sono antagonist[e]”, affermando la possibilità di una trasformazione della prima nella seconda.
Se questa elaborazione del ruolo e della funzione della sociologia rappresenta senza dubbio un elemento di interesse e un J’accuse nei confronti di una smarrita anima critica della sociologia stessa, non mi sembra che la proposta di Burawoy vada oltre il limite marcato, appunto, da una funzione “critica” del lavoro di ricerca. Cosa consente di fare la sociologia pubblica? Rende “vero” una parte del Reale, lo vincola ai processi di veridizione, modificandoli; produce un evento, consente l’articolazione di una critica. Quello che mi sembra manchi alla proposta di Burawoy è un passaggio successivo: in che modo e a quali condizioni un’attitudine critica si trasforma in “attività attivista” o “clinica”? Su questo proverò a formulare qualche opinione nelle pagine seguenti. Qui, mi limito a dare un esempio di cosa intendo per attività clinica, citando il lavoro lungo, minuzioso, finanche pericoloso, svolto da Marco Omizzolo nelle campagne del basso Lazio con i lavoratori ipersfruttati del subcontinente indiano nelle attività agricole di quell’area, che ha condotto a rivendicazioni, astensioni da lavoro, conquiste e anche molte minacce [3]].
In cosa consiste questo spaesamento, questo “stupore epistemico”? Principalmente nel “far apparire ciò che è così vicino […] da non poter essere percepito”. In questo, forse, sta la novità del nostro tempo: c’è una parte consistente del reale che non entra nei processi di veridizione dell’agire politico, regolati dal gioco di vero/falso; non è intercettabile, visibile attraverso quei processi[4]. La sovrapposizione di tempi, la copresenza di più “mondi” in uno stesso contesto – due caratteristiche della condizione postcoloniale che viviamo – rendono le distinzioni più sfumate, anche quelle ideologiche, etiche, non solo le differenze materiali. In quelle sfumature vivono soggettività che hanno bisogno di luce e parole, di articolazioni.
Se questa è la novità del nostro tempo rispetto a quattro-cinque decenni fa, entra in gioco un altro tipo di ricerca sociale; una ricerca sociale che deve procedere secondo una logica “analitico-politica”, o clinica, muovendosi su un piano che può essere solo quello dei processi micropolitici, con un approccio multidisciplinare.
La ricerca attivista, si diceva prima, necessita, come punto di partenza, di una solida base di dati, perché solo i dati, al netto del loro aggiornamento e delle rigidità strutturali classificatorie al cui interno vengono disponibilizzati, consentono una prima quantificazione dei sub-universi che le variabili e i loro incroci perimetrano. Allo stesso modo, necessita di una verifica sul campo di quei dati, attraverso le pratiche diffuse di interviste, raccolta di testimonianze ed elaborazione ragionata di tutte le informazioni. Deve avvalersi, in estrema sintesi, della funzione professionale, critica e pubblica della sociologia (Burawoy, 2007).
L’inchiesta attivista non può prescindere né da quelle informazioni, né dalla professionalità che serve per metterle a frutto. È solo da qui che può partire per tracciare un percorso preciso. Analizzare i processi micropolitici non significa eliminare dall’orizzonte euristico – e quindi dagli usi che si intende fare della ricerca – la dimensione macro (per un uso pratico, di policy, direbbe Burawoy, come quarta funzione della sociologia). Al contrario, significa ripartire dall’esperienza che la ricerca, l’inchiesta, ha prodotto in alcuni periodi della nostra storia recente e attuale[5], dando ai fenomeni “inchiestati” un’altra colorazione, più viva e attuale rispetto al tempo che stiamo vivendo, ma anche e soprattutto uno spazio immediatamente politico e sociale d’azione. Da questo punto vista - e data la complessità e drammaticità del legame profondo tra neoliberalismo e soggettività[6] - è fondamentale la presa in carico delle dinamiche che, a livello individuale, producono quello che Suely Rolnik chiama “l’inconscio colonial-capitalistico”; in altre parole, l’interiorizzazione psichica, profonda, di norme, valori, desideri, erotismi che riproducono automaticamente, e perversamente, i modelli di funzionamento mortiferi della “necropolitica” neoliberale. Qui, mi sembra, stia la grande novità del nostro tempo, rispetto a cui la sociologia - e con essa l’antropologia, la filosofia, la psicologia, il pensiero politico - deve darsi strumenti adeguati, per non limitarsi a ripetere la verità muta di tutti.
[Suely Rolnik ha dedicato il suo ultimo lavoro editoriale, Esferas da Insurreição (2018), a questo tema.
Vengono riportati qui alcuni stralci dell’importante introduzione al libro di Paul Preciado. “Si tratta di un lavoro aperto, di un archivio in divenire, in costante cambiamento, […] una cartografia delle pratiche micropolitiche di destabilizzazione delle forme dominanti della soggettivazione, un diagramma della sinistra che verrà. […] Suely Rolnik descrive i processi di oppressione coloniale e capitalistica come processi di cattura della forza vitale, una cattura che riduce la soggettività a esperienza come soggetto, neutralizzando la complessità dell’effetto delle forze del mondo sul corpo, a beneficio della creazione di un individuo con un’identità. Questo processo di soggettivazione funziona per ripetizione e per restringimento delle possibilità di creazione, impedendo il sorgere di ‘mondi virtuali’. Il soggetto coloniale moderno è uno zombi che utilizza la maggior parte della sua energia pulsionale per produrre la sua identità normativa: angustia, violenza, dissociazione, opacità, ripetizione… non sono altro che il prezzo che la soggettività colonial-capitalistica paga per poter mantenere la propria egemonia”.
“’Micropolitica’ è il nome dato da Guattari negli anni ’60 a quegli ambiti che, per essere considerati relativi alla “vita privata” nel modo di soggettivazione dominante, sono rimasti esclusi dall’azione riflessiva e militante della sinistra tradizionale: la sessualità, la famiglia, gli affetti, la cura, il corpo, l’intimo. Tutto ciò che successivamente Foucault tenterà definire con “microfisica del potere” e, più tardi ancora, con “biopotere”. In tal senso, la nozione di micropolitica rappresenta una critica del modo secondo cui la sinistra tradizionale (poco importa che si tratti della sua versione marxista, leninista, trotskista o socialista) considerava la trasformazione delle politiche della produzione come il momento prioritario della trasformazione sociale, lasciando in secondo piano le politiche di riproduzione della vita. Da lì la frattura tra i movimenti femministi, omosessuali, anticoloniali e la sinistra tradizionale”.
Achille Mbembe, uno dei principali pensatori africani contemporanei, ha coniato il termine necropolitica (2016), da cui prende il titolo un suo saggio, in cui descrive il potere e la capacità massima della sovranità di decidere chi può vivere e chi deve morire. Esercitare la sovranità significa, allora, attivare il controllo sulla mortalità e definire la vita come trasposizione e manifestazione del potere stesso.
In termini non molto diversi si esprime Judith Butler parlando di “dispensabili” in Alleanza dei corpi (2017). Sintetizzando, si può dire che il soggetto dispensabile è sempre connotato da gradi elevati di precarietà e vulnerabilità; su di esso si innestano le tecniche predatorie, estrattive, di controllo e sicurezza che stigmatizzano il soggetto “incapace di conformarsi alle norme del farcela da solo”.]
Il punto di partenza obbligato, quindi, non può essere altro che l’analisi dei processi di soggettivazione. È per questo che abbiamo bisogno di tempo. Se è vero che la soggettivazione è indissolubilmente connessa all’agire e all’esperienza che il soggetto fa al suo interno, è altrettanto vero che ridurre la soggettivazione al “soggetto”, nel senso di individuo socialmente definito e “parlato” in un certo modo, eluda una serie di questioni importanti. La distinzione tra i due sostantivi si potrebbe perimetrare con l’area, più o meno ampia, che eccede la rappresentazione identitaria del soggetto. Un’area che contempla l’esistenza di forme di esperienza, di sapere, di espressione, di godere, represse, anestetizzate, farmacologicamente e non, dalla colonizzazione neoliberale della psiche e che, una volta riappropriatesi della potenza vitale e creativa, possono rifiorire in una “soggettivazione dissidente”. È in questi termini, mi sembra, che la questione assume una certa rilevanza e, di conseguenza, assumono valore i processi di attivazione politica che una ricerca può – e dovrebbe – favorire. Perché questo divenga possibile è necessario che la ricerca prenda alcune caratteristiche, tanto di natura metodologica, quanto epistemica: cos’è importante indagare, comprendere, di un soggetto e dei rapporti che lo costituiscono in quanto tale; quale modello di ricerca dobbiamo adottare per far sì che la ricerca stessa costituisca un evento, un punto di aggancio per la produzione di una soggettività che si fondi sulla complessità dei processi di soggettivazione. Ma, soprattutto, come fare perché la ricerca/indagine resti lì dove ha preso avvio e lì continui il suo lavoro; quindi, con quale linguaggio, quali priorità, quali alleanze, ma anche senza quali filtri, senza quali preconcetti, senza quali limiti. Sarebbe infantile dire: “tutti”. Non è possibile, saremmo noi i primi a essere indisponibili, vanno fatte delle scelte.
Innanzi tutto va problematizzato il concetto di identità. Provincializzare l’identità significa lavorare non sulle posizioni che vengono occupate dalle rivendicazioni identitarie, ma nello spazio, sempre in costituzione, che si trova “tra” le complessità dei soggetti e delle loro capacità espressive, che vengono schiacciate dal linguaggio identitario. Lavorare nello scarto, piuttosto che sulle posizioni – come suggerisce François Jullien in “L’identità culturale non esiste” – consente di individuare linee di congiunzione che si sottraggono alla cristallizzazione identitaria e che in quello spazio trovano piena visibilità.
[Quello dell’identità è uno dei concetti che hanno maggiormente interessato in modo multidisciplinare gli studi sull’individuo nel suo costituirsi come soggetto politico, che agisce in uno spazio pubblico. Le logiche e le finalità di interazione con l’altro – sia esso umano o altro vivente –, i rapporti di potere in cui è costantemente inserito, a partire dal rapporto con se stesso, il predominio dell’”io”, del cogito, sulla pluralità di istanze che lo compongono sono alcuni degli ambiti che hanno messo in evidenza il legame profondo tra soggetto e identità. Stuart Hall, in un suo breve saggio dal titolo “Chi ha bisogno dell’’identità’?” (incluso nella raccolta di suoi saggi che prende il titolo Politiche del quotidiano (2006)), ne offre una lettura molto convincente.
Hall parte dal concetto di identificazione (“infido quasi come quello di ‘identità’ – anche se è da preferire”) per ripensare il soggetto “in base alla nuova posizione, spostata o decentrata, che occupa entro il paradigma [della teoria della pratica discorsiva]”. Puntando su questo paradigma foucaultiano, Hall descrive l’identificazione come una costruzione, “un processo di articolazione, una suturazione, una sovradeterminazione e non una sussunzione. C’è sempre qualcosa di troppo, o di troppo poco. […] Per consolidare il processo, ha bisogno di ciò che è rimasto fuori, del suo costitutivo mondo esterno”. Le identità appaiono “entro il gioco di specifiche modalità di potere, […] la costituzione di un’identità sociale è [essa stessa] un atto di potere”, in quanto fondata sulla differenza e l’esclusione di quel fuori che, di fatto, è la sua condizione di possibilità.
Le identità […] rappresentano il venire a patti con i nostri itinerari, […] scaturiscono dalla “narrativizzazione del Sé”: sono il “punto d’incontro, di sutura, tra – da una parte – i discorsi e le pratiche che cercano di interpellare, di parlarci o di sistemarci come soggetti sociali di determinati discorsi, e – dall’altra – i processi che producono soggettività, che ci costituiscono come soggetti che possono essere ‘parlati’.”]
Proverò in chiusura di questo scritto a riprendere la domanda implicita nel punto 1, alla luce delle considerazioni fatte, sperando di riuscire a dare/mi una risposta il più possibile coerente con quanto sostenuto, lasciandola comunque totalmente aperta a ripensamenti e suggestioni che possono arrivare da qualunque lato.
[1] Dalla prima parte: “Una ricerca attivista, non ha come fine la stesura di un rapporto. Una ricerca attivista, forse, non lo vede neppure chiaramente un fine, perché non è nella sua natura. Una ricerca attivista mette in moto, definisce delle linee di sviluppo, resta aperta, ma, soprattutto, resta là, dove è stata realizzata, pronta a ricominciare da dove si era fermata, pronta a aggiungere il contributo di un nuovo ‘conricercatore’”.
[2] A questo proposito, Mauro Palumbo ricostruisce le funzioni operative della sociologia, a partire dal duplice problema che sin dall’inizio la scuote, cioè “se è scienza del divenire e del cambiamento, se è scienza riformatrice della società, deve trovare, in modo implicito o esplicito, un referente al quale affidare le sue diagnosi e le sue terapie [da un lato, e] il rapporto con i soggetti che forniscono le informazioni su cui essa si basa per la propria teorizzazione [dall’altro]” (2014). Ancora Palumbo, così come Marco Santoro (2007) e Antonio Chiesi (2007) intervengono su un tema che ha segnato il dibattito sulla domanda “sociologia per chi e per cosa?” in anni recenti, la sociologia pubblica. Introdotta nel dibattito internazionale da Michael Burawoy, la sociologia pubblica, dice Santoro, è “un modo di praticare la disciplina che si preoccupa del suo essere-nel-mondo, e a questo ‘mondo’ si rivolge in primo luogo”. Palumbo (2014) si chiede se la tipologizzazione delle sociologie fatta da Burawoy (di cui quella pubblica è una delle quattro individuate) consenta di continuare a vedere nella sociologia la caratteristica che le era stata assegnata da Touraine, ovvero una “forma di riflessività della società su se stessa”, così come se riesce a essere strumento efficace nella sua attività di policy.
[3] Tra i numerosissimi lavori editoriali che danno conto dell’impressionante mole di lavoro di Omizzolo, cito F. Fanizza, M. Omizzolo, Caporalato, an authentic agromafia, Mimesis International, Milano, 2018.
[4] Su questo tema Foucault ha tenuto una lezione illuminante il 18 marzo 1981, nel corso “Soggettività e Verità” che dà il titolo al testo pubblicato da Feltrinelli nel 2017, pp. 233-253.
[5] Penso soprattutto ai lavori di Aquati nelle fabbriche torinesi e di Foucault con il GIP (gruppo d’inchiesta sulle prigioni) negli anni ’60 e ‘70, di Stuart Hall a Birmingham sulla cultura popolare (anni ’70-’80) e, per arrivare ai giorni nostri, al lavoro di Marco Omizzolo nelle campagne del sud del Lazio.
[6] Su questo legame, o, per meglio dire, sul fatto che il neoliberalismo rappresenti a tutti gli effetti la produzione di una nuova soggettività, di un uomo nuovo, e che quindi ha bisogno di una nuova antropologia, si veda il lavoro della psicoanalista argentina Nora Merlin, in particolare Colonización de la subjectividad, Letra Viva, BA, 2020. La colonizzazione della soggettività avviene, secondo Merlin, principalmente attraverso la manipolazione dei sentimenti, come angoscia, colpa, paura e odio. Tutto questo avviene - e questo è il punto più alto - in una costruzione mentale indotta, in cui il soggetto è spinto a sentirsi libero, imprenditore di se stesso, dentro un sistema di meritocrazia che lo può premiare, se sarà capace e se lo meriterà. La colonizzazione della soggettività produce quindi una sensazione di onnipotenza dell’io.
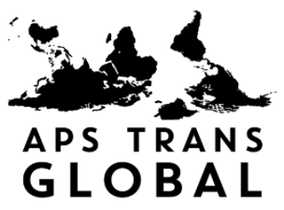
Scrivi commento